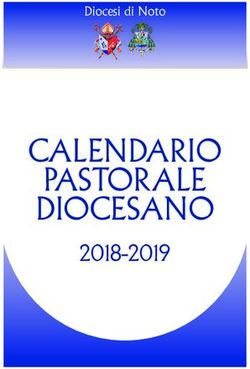Roma guarda ad Occidente: papato e patronato ad inizio Ottocento
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Lusitania Sacra. 43 (janeiro-junho 2021) 15-29 doi: https://doi.org/10.34632/lusitaniasacra.2021.10377
Roma guarda ad Occidente:
papato e patronato ad inizio Ottocento
ROBERTO REGOLI
Pontificia Università Gregoriana, Itália
regoli@unigre.it
Abstract: Si vuole qui presentare la concezione e la visione che Roma aveva del patronato in America Latina all’inizio
del XIX secolo. Dall’America Latina e dalla penisola iberica la questione del patronato è letta in chiave prettamente
politica, secondo un uso politico della religione. Roma invece aveva chiaramente un altro approccio alla questione.
La sua chiave di lettura era duplice: eminentemente religiosa, ma pure inevitabilmente politica nelle sue implicazioni.
In ogni caso l’esigenza religiosa era realmente primaria su quella politica. La questione religiosa si confonde con
quella politica in rapporto alla legittimità del potere politico. La domanda ultima è assai essenziale: chi detiene
legittimamente il potere? Nel lungo ‘800 si confrontano due autorità, quella statale e quella della Chiesa, in ordine
ai poteri decisionali nella Chiesa, chi può decidere cosa. Se la Santa Sede non si trova a suo agio con i regimi
costituzionali questo non le impedisce comunque di operare secondo i suoi fini religiosi: in definitiva non ha difficoltà
con l’istituto del patronato, ma con le modalità di attuazione.
Parole chiave: Santa Sede, Stato, Autorità, Sovranità, Poteri, XIX secolo.
Roma olha para o Ocidente: o papado e o padroado no início do século XIX
Resumo: O objetivo do presente artigo é apresentar a conceção e visão de Roma do padroado na América Latina
no início do século XIX. Da América Latina e da Península Ibérica, a questão do padroado é lida numa chave
política da religião. Roma tinha claramente uma outra abordagem à questão. A sua chave de leitura era dupla:
eminentemente religiosa, verdadeiramente primária, mas também inevitavelmente política nas suas implicações.
A questão religiosa é confundida com a questão política em relação à legitimidade do poder político. A questão
última é muito essencial: quem detém legitimamente o poder? No longo século XIX, duas autoridades, a do Estado
e a da Igreja, confrontaram-se relativamente ao poder de decisão na Igreja, quer dizer, quem pode decidir o quê.
Se a Santa Sé não está à vontade com os regimes constitucionais, isso não a impede de funcionar de acordo com
os seus objetivos religiosos: em última análise, não tem qualquer dificuldade com a instituição do padroado, mas
sim com a forma como é implementado.
Palavras chave: Santa Sé, Estado, Autoridade, Soberania, Poderes, Século XIX.
15RO B E R TO R E G O L I
Rome looks to the West: papacy and patronage in the early 19th century
Abstract: The aim here is to present Rome’s conception and vision of patronage in Latin America at the beginning
of the 19th century. From Latin America and the Iberian Peninsula, the question of patronage is read in a purely
political key, according to a political use of religion. Rome, on the other hand, clearly had another approach to the
question. Its reading key was twofold: eminently religious, but also inevitably political in its implications. In any case,
the religious need was truly primary over the political one. The religious question is confused with the political one in
relation to the legitimacy of political power. The ultimate question is very essential: who legitimately holds power?
In the long 19th century, two authorities, that of the state and that of the Church, confronted each other regarding
decision-making powers in the Church, who can decide what. If the Holy See is not at ease with constitutional regi-
mes, this does not prevent it from operating according to its religious purposes: ultimately it has no difficulty with
the institution of patronage, but with the way it is implemented.
Keywords: Holy See, State, Authority, Sovereignty, Powers, 19th century.
Introduzione
Il rapporto tra Chiesa romana e patronato è stato molto studiato in epoca
moderna e non poco si è scritto sui rapporti Stato-Chiesa in quelle terre anche in
occasione dei 200 anni dell’indipendenza dell’A merica spagnola da Madrid1. Le
principali prerogative del patronato regio – come ben si sa – riguardano il diritto di
comunicazione tra Chiese locali e Roma, il diritto regio di presentazione ai benefici,
il controllo sulla Chiesa tanto in ambito economico come nella vita religiosa. Quel
che interessa qui presentare è la concezione o meglio la visione che aveva Roma
del patronato ad inizio Ottocento, nel momento in cui il re Borbone perdeva il suo
potere politico e militare a favore della nuova élite governativa locale, che richiedeva
anche il riconoscimento di un proprio potere religioso (cioè mirava all’assunzione
del potere di patronato regio), che avrebbe influito sul patriottismo di tutti, cioè
sulla fedeltà ai nuovi poteri. Si vuol guardare anche al Brasile con ben altra storia
istituzionale, senza cioè la problematica del cambiamento di autorità nel diritto
di patronato, essendosi trattato di un passaggio di corona all’interno della stessa
famiglia reale, che manteneva nella continuità tutti i precedenti istituti governativi,
e non di una rivoluzione dell’ordine politico.
Dall’A merica latina e dalla penisola iberica la questione del patronato è letta
in chiave prettamente politica, secondo un uso politico della religione. Roma aveva
chiaramente un altro approccio alla questione. La sua chiave di lettura era duplice:
eminentemente religiosa, ma pure inevitabilmente politica nelle sue implicazioni.
1 A livello puramente esemplificativo: SARANYANA, Josep-Ignasi; AMORES, Juan Bosco, ed. – Política y religión en la
independencia de la América hispana. Madrid: Universidad de Navarra-Biblioteca de Autores Cristianos, 2011; la sezione: Iglesia
y Estado en la América Hispana entre el Antiguo y el Nuevo Régimen. In Anuario de la Historia de la Iglesia. 27 (2018) 145-293.
16Rom a g u ard a ad Occid ente: papato e patro nato ad inizio Otto cento
In ogni caso l’esigenza religiosa era realmente primaria su quella politica. Ma le
due si confondevano creando disagi. Si pensi al caso del Messico, dove a causa di
mancati rapporti con Roma, su 10 sedi episcopali ne sono coperte 4 nel 1821 e 1
sola nel 18292 . La questione religiosa si confonde con quella politica in rapporto
alla legittimità del potere politico. La domanda ultima è assai essenziale: chi detiene
legittimamente il potere? La questione si era posta precedentemente in Europa con
la Rivoluzione francese, che aveva detronizzato e ghigliottinato i propri sovrani. In
quel caso la Santa Sede applicò il più stretto realismo, sottoscrivendo il concordato
con la Francia napoleonica nel 1801 (facendo venire meno precedenti sostegni alla
Vandea)3. La questione sempre in Europa si era posta anche con il triennio liberale
spagnolo: anche lì si riconosce per legittimo chi detiene veramente il potere4. In
Europa si attua la stretta teologia politica paolina: ogni potere viene da Dio. E a
quel potere bisogna obbedire. Più tardi con Gregorio XVI si applicherà anche alla
Polonia russa: i rivoltosi sono tenuti all’obbedienza a San Pietroburgo, cioè i cattolici
devono obbedire agli ortodossi5. La teologia politica porta all’obbedienza verso chi
detiene realmente il potere per la tutela della religione. Per la questione dell’A merica
spagnola ci sono più complicazioni, perché la chiarificazione della detenzione del
potere tra poteri locali americani e Madrid dura a lungo, rimanendo sullo sfondo
e centrale la ricerca del bene spirituale dei fedeli da parte di Roma. Nell’ambito
proprio della politica ecclesiastica, la questione della legittimità in quelle terre
americane trova un punto critico di confronto e tensione nell’ambito del diritto di
patronato e più esattamente in un suo aspetto6: la nomina ai benefici, specialmente
all’episcopato.
La lunga stagione di passaggio del potere porta ad una reale gravità della
situazione religiosa ben percepita a Roma, almeno nei suoi uomini più avveduti.
2 SARANYANA – Política y religión en la independencia de la América hispana, p. 47.
3 Cfr. BOUTHILLON, Fabrice – La naissance de la Mardité. Une théologie politique à l’âge totalitaire: Pie XI (1922-1939).
Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2002.
4 Cfr. REGOLI, Roberto – La «Congregación Especial para los Asuntos Eclesiásticos de España» durante el trienio liberal.
Anuario de Historia de la Iglesia. 19 (2010) 141-166. Per gli sviluppi successivi un’interesante sintesi in LA PARRA, Emilio
– Léon XII et le roi d’Espagne Ferdinand VII. In SERMATTEI, Ilaria Fiumi; REGOLI, Roberto; TRUSCELLO, Paolo Daniele, ed.
– Dall’intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII. Ancona: Consiglio Regionale – Assemblea
legislativa delle Marche, 2019, p. 79-92.
5 Cfr. LEFEVRE,Renato – S. Sede e Russia e i colloqui dello Czar Nicola I nei documenti vaticani. In Gregorio XVI. Miscellanea
Commemorativa, vol. 2, Roma: Pontificia Università Gregoriana, 1948, (Miscellanea Historiae Pontificiae, 14), p. 159-293.
Per il periodo precedente: BARAŃSKA, Anna – Des grands espoirs à la désillusion. Léon XII vis-à-vis des tsars russes et leurs
ambassadeurs. In FIUMI SERMATTEI, Ilaria; REGOLI Roberto, ed. – La Corte papale nell’età di Leone XII. Ancona: Assemblea
legislativa delle Marche, 2015, p. 45-56; BARAŃSKA, Anna – «Une circonspection qui ne dorme pas un seul jour». Le Saint-
Siège et l’Empire Russe sous le pontificat de Léon XII. In SERMATTEI – Dall’intransigenza alla moderazione, p. 141-159.
6 Cfr. CANAVERO, Alfredo – La Santa Sede e l’indipendenza dei nuovi Stati dell’America Latina. In CARERA, Aldo; TACCOLINI,
Mario; CANETTA, Rosalba, ed. – Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea. Studi in
onore di Sergio Zaninelli, Milano: Vita e Pensiero, 1999, p. 619-631.
17RO B E R TO R E G O L I
La centralità latinoamericana
È emblematico a tal riguardo riportare alcuni passaggi dell’ultimo colloquio
intercorso nel gennaio 1824 tra il nuovo papa Leone XII e il cardinale Ercole Consalvi,
già segretario di Stato di Pio VII, che per primo dovette affrontare la questione latino-
americana7, colloquio che porterà alla nomina del porporato a capo di Propaganda
fide. All’uscita di quell’incontro il papa commenterà con il cardinale Placido Zurla:
«Quale conversazione! Noi non abbiamo avuto mai con persona alcuna l’occasione
di occuparci di comunicazioni più importanti, più sostanziose e che potessero
tornare più utili allo Stato!»8. In quel contesto i due vecchi amici (allontanatosi tra
loro nel tempo per diversità di visioni politiche) avevano affrontato insieme i punti
delicati della situazione politica ed ecclesiale del momento, dai rapporti con la Francia
in funzione della protezione dei cattolici nel Levante ai carbonari, dall’indizione di
un giubileo alla situazione dei cattolici in Russia e Gran Bretagna. Inevitabilmente
il cardinale aveva portato l’attenzione sulla «protezione» dei cattolici in America
latina, avendo come obiettivo papale «la conservazione del cattolicesimo in tutta la
sua purezza»9. Consalvi confessa a Leone XII che a tal fine da segretario di Stato,
tra il 1822 ed il 1823, con circospezione aveva trattato con le Cortes americane in
relazione alle nomine episcopali a fronte di una Spagna senza alcun potere in quelle
terre. In nome della legittimità, precedentemente, il cardinale aveva concesso tempo
a Madrid per il recupero del controllo sull’A merica, ma confessava a Leone XII
che «nella sua ingratitudine o nella sua impotenza la Spagna d’Europa parea fare
del nostro silenzio un’arma per colpire più vivamente i suoi ribelli»10. Vedendo le
difficoltà del recupero territoriale spagnolo, Consalvi non aveva più voluto legare
la causa cattolica a quella monarchica, come quando Pio VII aveva scritto il noto
breve legittimista Etsi longissimo (30 gennaio 1816)11. E in tal senso si può leggere la
missione negli anni ’20 del vicario apostolico nell’A merica meridionale, la più nota
missione di mons. Giovanni Muzi12 . Se Roma avesse aspettato altro tempo, a detta
7 Su questa questione durante il pontificato leonino si rimanda a: FERNÁNDEZ MELLÉN, Consolación – Nell’interesse della
religione e nell’uso della plenitudo potestatis del papa. La politica di Leone XII verso l’America indipendente. In SERMATTEI
– Dall’intransigenza alla moderazione, p. 231-260; SANTIROCCHI, Ítalo Domingos – Leone XII e l’Impero tropicale (Brasile,
1823-1829). In SERMATTEI – Dall’intransigenza alla moderazione, p. 261-275. Si rimanda anche al già citato saggio LA PARRA
– Léon XII et le roi d’Espagne Ferdinand VII.
8 ARTAUD DE MONTOR, Alexis-François – Storia del pontefice Leone XII, vol. I, Milano: Presso Giovanni Resnati 1843, p. 134.
9 ARTAUD DE MONTOR – Storia del pontefice Leone XII, p. 131.
10 ARTAUD DE MONTOR – Storia del pontefice Leone XII, p. 131.
11 Il testo in BELLOCCHI, Ugo, ed. – Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: 250 di storia visti dalla
Santa Sede, vol. II, Città del Vaticano: LEV 1994, p. 400-401 e pure in https://w2.vatican.va/content/pius-vii/it/documents/
breve-etsi-longissimo-30-gennaio-1816.html. Cfr. LETURIA, Pedro de – La encíclica de Pío VII (30 de enero de 1816) sobre la
revolución hispano-americana, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1948.
12 La documentazione relativa a questa missione si può trovare in LETURIA, Pedro de; BATTLORI, Miquel – La primera misión
pontificia a Hispanoamérica, 1823-1825. Relacion oficial de mons. Giovanni Muzi. Città del Vaticano: Biblioteca Vaticana,
18Rom a g u ard a ad Occid ente: papato e patro nato ad inizio Otto cento
di Consalvi, il vicario avrebbe trovato in quelle terre «metodisti e presbiteriani,
e nuovi adoratori del Sole, e che so io. […] ne avrebbe trovati forse in numero eguale
a quello de’ cattolici»13. Per tale motivo di urgenza religiosa, anzi di sopravvivenza
del cattolicesimo, Consalvi aveva aperto il precedente pontificato di Pio VII ai nuovi
poteri latinoamericani. Queste parole gli sono messe in bocca da Alexis-François
Artaud de Montor:
«Io adunque ho creduto bene d’intrattenere legami di dipendenza e d’amore tra Roma
e tutti quelli che sì violentemente separavansi, e con tante probabilità di prospero suc‑
cesso, da qualunque sommessione alle Giunte, od a Ferdinando VII. Ho spinto con
impazienza i miei sguardi persino sul Paraguay. Vostra Santità può seguire la medesima
direzione, ma con una prudenza che non si smentisca giammai. Il gabinetto di Madrid,
Beatissimo Padre, è vostro personale amico: ma voi saprete conciliare la tenerezza della
riconoscenza col dovere del Pontificato»14.
Insomma, la Roma di Consalvi guardava con prudenza alla situazione
cattolica nell’A merica spagnola. Apriva ai nuovi poteri locali. E in tutto ciò
rientravano anche considerazioni intorno all’istituto del patronato.
A Roma c’erano diversi protagonisti della gestione di questi dossier
americani. Qui interessa presentare le dinamiche decisionali interne alla Curia
romana sulle tematiche in gioco, prendendo le mosse dalle riunioni dei cardinali
della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, nata solo nel 1814, ma
preposta a valutare le grandi questioni dei rapporti Chiesa-Stato di quegli anni,
diventando nel tempo un vero e proprio Think tank, un Gran Consiglio della Chiesa
cattolica e in primis del papa15. Attraverso le carte e specialmente i verbali delle
riunioni cardinalizie, si può comprendere il pensiero romano e la sua evoluzione di
fronte ai cambiamenti geopolitici e culturali dell’A merica latina.
1963 (Studi e testi, 229). Inoltre: MARTINA, Giacomo – La prima missione pontificia nell’America Latina. Archivum Historiae
Pontificiae. 32 (1994) 149-193; AYROLO, Valentina – Una nueva lectura de los informes de la misión Muzi: la Santa Sede
y la Iglesia de las Provincias. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’. 14 (1996) 3era
serie, 31-60.
13 ARTAUD DE MONTOR – Storia del pontefice Leone XII, p. 132.
14 ARTAUD DE MONTOR – Storia del pontefice Leone XII, p. 132.
15 Sulla Congregazione nel periodo preso in considerazione: BARAŃSKA, Anna – Léon XII et la Congrégation des Affaires
ecclésiastiques extraordinaires: nouveaux horizons, nouveaux défis. In REGOLI, Roberto; FIUMI SERMATTEI, Ilaria; DI
SIMONE, Maria Rosa, ed. – Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII. Ancona: Consiglio Regionale
– Assemblea legislativa delle Marche, 2019, p. 115-135; PÁSZTOR, Lajos – La Congregazione degli Affari Ecclesiastici
Straordinari tra il 1814 e il 1850. Archivum Historiae Pontificiae. 6 (1968) 238-241; PETTINAROLI, Laura – Les sessioni de la
congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires: évaluation générale (1814-1938) et remarques sur le cas russe
(1906-1923). Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Mediterranée. 122/2 (2010) 493-537, anche online http://
journals.openedition.org/mefrim/585; DOI: 10.4000/mefrim.585. Per una visione più ampia della Congregazione nella
storia: DOUBLET, Nicholas – A politics of peace. The Congregation for Extraordinary Ecclesiastical Affairs during the pontificate
of Benedict XV (1914-1922). Roma: Studium 2019.
19RO B E R TO R E G O L I
Di sicuro è ben noto il discorso pubblico del Papato sul legittimismo
spagnolo e sull’indipendenza americana, con tutte le sue oscillazioni, da un già
citato Etsi longissimo legittimista, ad una lettera del 7 settembre 1822 di Pio VII al
vescovo Rafael Lasso de La Vega, vescovo di Merida (Venezuela), aperturista alla
causa indipendentista, alla bolla Etsi jam Diu di Leone XII (25 settembre 1824) di
nuovo legittimista (se pure moderatamente), fino all’ultima parola di Gregorio XVI
con la bolla Sollicitudo Ecclesiastum del 1831 a favore del realismo politico. Si conosce
anche il dialogo diplomatico tra i tre protagonisti dell’epoca (Roma al centro, in
contatto con Madrid e i nuovi Stati latinoamericani)16.
Ma come si attuò questa dinamica di idee contrastanti tra posizioni legittimiste
monarchiche e quelle più aperturiste di Gregorio XVI? Si trattò di un vero e proprio
laboratorio di idee, che si elaborarono in Curia all’interno della riflessione collegiale
cardinalizia, specialmente di quella della neonata Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari, a volte anche alla presenza papale (coram SS.mo), avendo
da stimolo i voti di Mauro Cappellari (prima consultore e poi membro cardinale),
il futuro Gregorio XVI17, considerato «el Papa de Hispanoamérica»18, la cui azione
papale è vista in piena continuità con quanto precedentemente pensato e realizzato
da prefetto di Propaganda fide19.
Le sessioni cardinalizie della Congregazione degli Affari Ecclesiastici
Straordinari al tempo di Pio VII
Tra le riunioni cardinalizie dell’epoca della Restaurazione solo una minima
parte è dedicata all’America latina. Nei primi 10 anni di vita, sotto Pio VII, se ne
hanno solo 5: 4 relative al Brasile20 e 1 all’America spagnola e propriamente al
16 LETURIA, Pedro de – Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. 3 vol., Caracas – Romae: Sociedad Bolivariana de
Venezuela – Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1959-1960; LETURIA – La primera misión pontificia a Hispanoamérica;
LETURIA, Pedro de – El ocaso del patronato real en la América española : la acción diplomatíca de Bolivar ante Pío VII (1820-
1823) a la luz del Archivo Vaticano. Madrid: Razón y Fe, 1925.
17 Gli studi complessivi più recenti su di lui: LONGO, Francesca; ZACCAGNINI, Claudia; FABBRINI, Fabrizio, ed. – Gregorio XVI.
Promotore delle Arti e della Cultura. Ospedaletto (Pisa): Pacini Editore, 2008; UGOLINI, Romano, ed. – Gregorio XVI tra
oscurantismo e innovazione. Stato degli studi e percorsi di ricerca. Pisa-Roma: Fabrizio Serra Editore, 2012; FORNACIARI,
Roberto; RAZIOLI, Giovanni, ed. – Gregorio XVI. Dal Monastero di San Michele in Isola alla Sede di Pietro. Atti delle Giornate di
studio in occasione del 250° anniversario della nascita, Belluno 20-21 novembre 2015. Camaldoli: Edizioni Camaldoli, 2016.
18 LÓPEZ V., Alvaro – Gregorio XVI y la reorganización de la Iglesia hispanoamericana. El paso del régimen de patronato a la
misión como responsabilidad directa de la Santa Sede. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004, p. 381.
19 Cfr. LÓPEZ V. – Gregorio XVI y la reorganización de la Iglesia hispanoamericana, p. 385.
20 Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati, Archivio Storico (d’ora in avanti: S.RR.SS.), Archivio della Sacra
Congregazione degli Affari ecclesiastici Straordinari (d’ora in avanti: AA.EE.SS.), Sessioni, anno 1816, sessione 53, 8
agosto 1816: Esame di tre Pastorali del nuovo Arcivescovo della Bahia nel Brasile; S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessioni, anno 1816,
sessione 54, 25 agosto 1816: Brasile – Vescovo della Città di S. Paolo; S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessioni, anno 1816, sessione
55, 5 settembre 1816: Estratto di alcune Proposizioni censurabili cavate da tre Pastorali di Monsig. Abreu Vieira attuale
Arcivescovo della Bahia; S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessioni, anno 1817, sessione 71, 28 settembre 1817: Dispaccio di Mons. Macchi
Internunzio Apostolico in Lisbona all’E.mo Sig. Card. Segr. di Stato.
20Rom a g u ard a ad Occid ente: papato e patro nato ad inizio Otto cento
Cile21. Quest’ultima è la più interessante perché tratta di quella che poi passerà
alla storia come missione Muzi, la prima missione pontificia dopo l’indipendenza.
Inviare un vicario apostolico in partibus appariva come un modo di ignorare de
facto il patronato. E in più le istruzioni pontificie che concedevano all’arcivescovo
di provvedere alle sedi vacanti tramite vicari apostolici e al ritorno in Spagna dei
vescovi oriundi non più graditi localmente andavano ancora più decisamente
nella stessa direzione.
Le determinazioni prese in quella riunione sono la base dell’atteggiamento
della Santa Sede verso l’indipendenza e il patronato, tanto da essere richiamate nelle
successive riunioni sull’A merica latina.
Quella riunione fu preparata da altre esterne agli Affari Ecclesiastici
Straordinari. Ci fu, infatti, una prima Congregazione particolare nell’agosto 1822,
composta dai cardinali della Genga (futuro papa Leone XII), Della Somaglia,
Consalvi, Pacca, Castiglioni e De Gregorio con segretario mons. Raffaele Mazio,
che decise l’invio di un vicario apostolico22 . Dopo questo indirizzo il dossier
fu portato alla Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, per essere
dibattuto nell’aprile 182323. Dalla storiografia si sa che in quella riunione si discusse
proprio sulle facoltà del vicario di nominare i vescovi in quelle terre lontane24. I
cardinali vollero fissare delle clausole. La nomina e consacrazione di vescovi, se
venne concessa, fu ugualmente sottoposta ad alcune restrizioni:
«ciò non doveva presupporre il riconoscimento, da parte della S. Sede, del patronato
alle nuove repubbliche, essendo ancora in corso la guerra con la Spagna e che, per la
diocesi di Santiago, le nomine dei vescovi dovessero essere approvate dal vescovo tito‑
lare, mons. Zorilla. Il Vicario apostolico, inoltre, aveva le stesse facoltà per trattare gli
affari ecclesiastici locali con gli altri Stati indipendenti»25.
Il bene religioso non doveva necessariamente portare al passaggio di
patronato da Madrid alle nuove capitali nazionali.
21 S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessioni, anno 1820, sessione 88a, 18 aprile 1823, Chile, Deputazione di un vicario ap.lico per il Chile.
Il verbale, però, non si trova al suo posto. Le indicazioni archivistiche rimandano ad altra posizione, S.RR.SS., AA.EE.SS.,
America III, Cile, anno 1821-1825, pos. 1, fasc. 68, ma la posizione non si trova neanche dentro quel fascicolo.
22 VALENTINI, Ubaldo – Giovanni Muzi. Vicario apostolico in America Latina, Arcivescovo vescovo di Città di Castello, fondatore delle
Figlie della Misericordia. Città di Castello: Edizioni Porziuncola, 1992, p. 44; PÁSZTOR – La Congregazione degli Affari, 244, che
rimanda a Archivio Segreto (ora Apostolico) Vaticano, Carte Mazio, America. Sulle riunioni cardinalizie: LETURIA – Relaciones
entre la Santa Sede e Hispanoamérica, vol. 2, p. 183-226 e LETURIA – La primera misión pontificia a Hispanoamérica. Per la
composizione cardinalizia: SALLUSTRI, Giuseppe – Storia delle missioni apostoliche dello Stato del Chile, colla descrizione del
viaggio dal vecchio al nuovo mondo fatto dall’autore. Vol. I, Roma: Presso Giuseppe Mauri 1827, p. 2.
23 S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessioni, anno 1820, sessione 88a, 18 aprile 1823, Chile, Deputazione di un vicario ap.lico per il Chile.
24 VALENTINI – Giovanni Muzi. Vicario apostolico in America Latina, p. 45.
25 VALENTINI – Giovanni Muzi. Vicario apostolico in America Latina, p. 45. Come fonte rimanda a Archivio storico di Propaganda
Fide, Scritture riferite nei Congressi, America Meridionale 1804-1825, p.619s e a F. Capaccini, lettera riservata a Muzi, 1 marzo
18232, in AVCC, c. 831.
21RO B E R TO R E G O L I
Dopo il rifiuto di Pietro Ostini26, il segretario di Stato cardinale Consalvi si
determinò a scegliere per la missione americana, mons. Giovanni Muzi. Francesco
Capaccini, in quel tempo minutante alla Segreteria di Stato, gli scrisse chiaramente:
«Trattasi di andare in un paese così lontano ad esercitare in nome del Papa le più
estese facoltà, e si deve stare al contatto di un governo che non si deve riconoscere»27.
Il bene religioso richiede contatti con i nuovi poteri, ma non il loro riconoscimento.
Capaccini parlava francamente all’amico:
«Il Papa manderà al Chili un Vicario Apostolico col carattere Arcivescovile, il quale
farà per così dire il Papa in America, tanto ampie sono le facoltà che si è determinato
accordargli. La grande opera affidata a questo Vicario si riduce a mantenere attaccata
alla S. Sede tutta l’America, ed a presiedere a tutte le cose ecclesiastiche principalmente
nel regno del Chili dove sarà in fatto considerato come un Nunzio o per meglio dire
come un Legato della Santa Sede… Il Governo Pontificio non sarà compromesso con
questa missione, essendosi già combinato tutto, e convenuto che sarà evitato ogni atto
che potesse comprometterlo con la Spagna»28.
Le facoltà del vicario sono amplissime29. Grazie al triennio liberale spagnolo,
Roma aveva potuto cercare con più libertà il bene religioso in America, non per
forza propria, ma per felice combinazione degli eventi. Infatti, i contrasti in Spagna
tra liberali e monarchia avevano aperto nuovi orizzonti alla diplomazia papale. Di
fronte al nuovo regime politico liberale, il nunzio a Madrid dichiarava, in nome della
Santa Sede, «la indiferencia de la Iglesia en materias de régimen político y exhortaba
la obediencia al nuevo Gobierno»30, secondo la più classica tradizione teologica
di origine paolina. Il centro è l’obbedienza a chi realmente detiene il potere. Nel
momento in cui, però, inizia a dispiegarsi una politica di antiquato regalismo, Roma
reagisce. È proprio in questo contesto che Pio VII apre ai nuovi governi sudamericani
26 Pietro Ostini, matematico, storico al Collegio romano, teologo presso l’Accademia dei Nobili Ecclesiastici, è consultore di
alcuni dicasteri della Curia romana e qualificatore al Sant’Uffizio. Successivamente intraprenderà la carriera diplomatica
pontificia. Cfr. REGOLI, Roberto – Gli uomini del papa. La rete della diplomazia papale. In SERMATTEI – Dall’intransigenza alla
moderazione, p. 19-38.
27 F. Capaccini, lettera riservata a Muzi, 1 marzo 1823, in VALENTINI – Giovanni Muzi. Vicario apostolico in America Latina, p. 45.
28 F. Capaccini, lettera riservata a Muzi, 1 marzo 1823, in VALENTINI – Giovanni Muzi. Vicario apostolico in America Latina, p. 46.
29 «Rilevanti erano le facoltà: la possibilità di concedere la bolla della crociata nella forma usata nei tempi coloniali; la nomina
di tre vicari apostolici, concordati con il Governo cileno, e di consacrarli vescovi in partibus; permettere al Governo l’uso
del patronato nella presentazione di ecclesiastici per i gradi inferiori all’episcopato. Inoltre i vicario apostolico poteva
assolvere gli eretici, gli apostati, coloro che erano colpiti da censure riservate alla S. Sede, i simoniaci; poteva concedere
dispense relative al matrimonio, ai voti semplici, alla secolarizzazione dei religiosi e religiose, alla recita delle ore canoniche;
concedere la riduzione delle festività, la rivalidazione delle giurisdizioni ecclesiastiche e dei matrimoni». VALENTINI –
Giovanni Muzi. Vicario apostolico in America Latina, p. 49-50.
30 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel – La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (1803-1833). In CÁRCEL ORTÍ, Vicente,
dir. – La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975). Vol. V: Historia de la Iglesia en la España. Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos, 1979, p. 3-113, qui p. 84.
22Rom a g u ard a ad Occid ente: papato e patro nato ad inizio Otto cento
in relazione alle nomine episcopali31 (si pensi alla nota e già citata lettera del papa al
vescovo Lasso de la Vega di Mérida in Venezuela del 7 settembre 182232) e invia un
vicario apostolico per il Cile, con poteri su tutta l’A merica. Dinanzi agli interventi
regalisti dei governi liberali di Madrid33, la Santa Sede si rende disponibile a trattare
l’assetto ecclesiale americano con i rivoluzionari delle ex colonie spagnole34. Si è
all’interno di una questione di politica ecclesiastica35, che Roma seppe giocare bene,
come risulta in un verbale di riunione cardinalizia del 1825, che ricorda il periodo
liberale di poco precedente:
«Il Governo Spagnuolo si mostrò soddisfatto del modo, con cui procedè allora la
S. Sede. Vero è però, che la Spagna a quell’epoca era sotto il Regime Costituzionale,
e quindi da una parte il Re la vedeva con piacere poco calcolata dalla S. Sede; e
dall’altra parte il Partito dominante in quel tempo non poteva contrastare gli Ameri‑
cani in diritto quella indipendenza, che si era esso arrogata in un senso poco diverso
nell’Europa»36.
Le sessioni cardinalizie della Congregazione degli Affari Ecclesiastici
Straordinari al tempo di Leone XII
La situazione spagnola evolve a Madrid con il ritorno al pieno potere di
Ferdinando VII, come anche in America, ma in quest’ultima regione contrariamente
al potere spagnolo. In questi nuovi orizzonti si stagliano le riflessioni della Curia
romana intorno al patronato in America. A Roma c’è un nuovo papa, Leone XII,
che già da cardinale aveva seguito le questioni latinoamericane. Non è un novellino.
La Congregazione nei suoi lavori segue sia l’Europa che l’A merica latina.
Quest’ultima vede affrontati alcuni affari intorno al Brasile (3 sessioni), la Colombia
(3 volte), il Guatemala, il Messico e il Cile (questi ultimi una sola volta ciascuno)37.
La prima questione latino-americana trattata (2 marzo 1825) presso la
Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari ha a che fare con la Colombia
31 LETURIA, Pedro de – Autenticidad e integridad de la Enciclica del Papa León XII sobre la revolución hispanoamericana.
Revista de Historia de America. 34 (1952) 413-447.
32 La lettera è pubblicata in LETURIA – Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica 1493-1835. Vol. III: Apendices –
Documentos – Indices. Caracas: Sociedad Bolivariana de Venezuela / Romae : Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1960,
p. 241-242. Una riflessione più recente sul vescovo: OLIVARES, Alexander – Rafael Lasso de la Vega, obispo de la diócesis de
Maracaibo y su adhesión a la independencia de Venezuela. Tiempo y Espacio. 57 (2012) 22, 46-64.
33 Cfr. REVUELTA GONZÁLEZ – La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (1803-1833), p. 3-113, qui p. 87.
34 Cfr. LETURIA – Autenticidad e integridad de la Enciclica del Papa León XII sobre la revolución hispanoamericana, 413-447.
35 Cfr. REGOLI – La «Congregación Especial para los Asuntos Eclesiásticos de España» durante el trienio liberal.
36 S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessioni, sessione 95, 2 marzo 1825, Nuova Repubblica di Colombia, e provvidenza della S. Sede
per la medesima. Pos. Stampa n. 11. Il verbale della riunione è pubblicato in LETURIA – Relaciones entre la Santa Sede e
Hispanoamérica, vol. 2, p. 283-296, qui p. 294-295.
37 Cfr. il già citato saggio di BARAŃSKA – Léon XII et la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires: nouveaux
horizons, nouveaux défis.
23RO B E R TO R E G O L I
e la nomina dei suoi vescovi38. I cardinali coinvolti sono Giulio Maria Della
Somaglia, Bartolomeo Pacca, Francesco Saverio Castiglioni (futuro papa Pio
VIII), Emmanuele De Gregorio e Placido Zurla «e oltre il Segretario anche Mgr
Mazio che ebbe precedentemente mano negli Affari da discutersi». Nella posizione
si rimanda costantemente al precedente caso cileno, che diviene così del tutto
esemplare. La Santa Sede è consapevole delle sue precedenti posizioni ondivaghe e
dell’importante condizionamento spagnolo, ma vuole guardare i «bisogni spirituali
di quelle Popolazioni», ha «premura di soccorrere ai spirituali bisogni dei Fedeli».
La questione è altamente politica, ma l’orizzonte di movimento è chiaro, così come
riporta il verbale della riunione cardinalizia:
«Bisogna quindi tenersi fermi alle Dichiarazioni espresse nel Breve della Sa. Me. di Pio
VII al detto vescovo di Merida, e nelle Istruzioni date al Vicario Apostolico del Chili, cioè
“di tenere per canone fisso, ed invariabile, di non imbarazzarsi né punto, né poco di ogge‑
tti, e di regolare la sua condotta in modo che tutti conoscano, essersi mossa la S. Sede a
spedirlo unicamente per provedere ai bisogni spirituali di quelle rimote Popolazioni”».
Nella questione colombiana sono in gioco tre aspetti propri del Patronato:
«1° la facoltà ai Provinciali per l’esercizio dei diritti spettanti ai Vicari Generali Spag‑
nuoli non più riconosciuti da quelle Parti. 2° La destinazione di un vescovo ausiliare
per quelle Provincie. 3° La conferma della collazione delle Parochie di Patronato Regio
e delle elezioni Capitolari, e la facoltà di proseguire in appresso».
Nel rispondere positivamente a tante questioni provenienti dai vescovi
e capitoli colombiani, la Santa Sede preferisce impiegare il termine di risposta di
concessione ad beneplacitum S. Sedis:
«fu risoluto di preferire detta espressione, perché se mai accadesse un cambiamento, vi
sia luogo a prendere quelle nuove determinazioni, che si giudicheranno opportune; e
perché il contegno della S. Sede persuada sempre meglio il Governo Spagnolo, che il S.
Padre si studia di non recare alcun pregiudizio ai suoi diritti su i [!] Stati di Colombia,
nell’atto che per dovere del suo ministero vedesi nella necessità di accorrere ai bisogni
spirituali di quelle Popolazioni».
Il rapporto con Madrid condiziona continuamente. Di fronte alla vacanza
delle sedi diocesane, si determina di nominare un vescovo ausiliare al vescovo di
Merida, ma con cautela: «Che si dia come Ausiliare al Vescovo di Merida può
38 S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessioni, sessione 95, 2 marzo 1825, Nuova Repubblica di Colombia, e provvidenza della S. Sede per
la medesima. Pos. Stampa n. 11. Cfr. GÓMEZ ORTIZ, Fernando – Le relazioni diplomatiche tra Gran Colombia e Santa Sede.
Salerno: tesi di dottorato, Università di Salerno, 2012: http://elea.unisa.it/jspui/bitstream/10556/314/1/tesi%20F.J.%20
Gomez%20Ortiz.pdf. Concultato il 29/07/2021.
24Rom a g u ard a ad Occid ente: papato e patro nato ad inizio Otto cento
passare, non mai però come Coadjutore. Potrà essere utile anche alle altre Diocesi,
ma per i soli Atti di Ordine. Il caso è alquanto diverso da quello del Chili. Si trattava
allora di spedire sulla faccia del luogo un Vicario Apostolico, e in conseguenza
poteva correre, che venisse munito della speciale facoltà di nominare uno, o più
vescovi in Partibus, assicurandosi prima della idoneità dei soggetti. Per Colombia
non abbiamo un Vicario Apostolico, e la cosa è molto delicata anche per l’esempio».
La questione in gioco è sempre politica, legata al patronato regio spagnolo e
per questo in tutta la posizione si trova una preoccupazione giustificativa da parte
della Santa Sede. Pensando ad un governo spagnolo «assolutamente monarchico»,
Roma più volte deve riaffermare il suo orizzonte spirituale:
«la Santa Sede deve prendersi una eguale sollecitudine per tutti i fedeli, indipenden‑
temente dalle vicende, e cambiamenti politici. È certo altresì, che esistono tali bisogni
nelle Diocesi Americane di Colombia, e che quanto più si tarda, tanto più vanno ad
aumentarsi con grave pregiudizio della Religione, e delle Anime. Dunque è innegabile,
che la S. Sede debba assolutamente occuparsi del bene spirituale di que’ fedeli».
Ma allo stesso tempo non può negare il condizionamento politico:
«la Santa Sede non potendo tenersi più a lungo indifferente ai gravi bisogni spirituali
dei Cattolici di Colombia, non ha punto dimenticato tutte quelle cautele, e riserve, che
lasciano intatti i diritti di S.M. Cattolica, tenendo dietro alle tracce segnate dalla Sa.
Me. di Pio VII per il Chili, ed astenendosi sopra tutto dal provedere al rimpiazzo delle
Sedi vescovili vacanti, quantunque la lunga vedovanza di quelle chiese non possa non
essere di grave pregiudizio».
Il fine è chiaro:
«il Sommo Pontefice, spinto dai doveri del suo ministero, si è occupato dei bisogni
spirituali di quelle popolazioni, lo ha fatto in quella misura soltanto, che possa supplire
alla necessità le più urgenti, evitando con la più scrupolosa diligenza qualunque scoglio
politico».
Le questioni si ripetono nel tempo, sotto modalità particolari. Nel
gennaio 1827, a fronte del cosiddetto scisma del Guatemala (Stato di San
Salvador, 1819)39, dove, ignorando Roma, le autorità politiche avevano non solo
eretto autonomamente un vescovato ma anche datolo in possesso a José Martí
Delgado, i cardinali degli Affari ecclesiastici straordinari (Della Somaglia, Pacca,
Castiglioni, De Gregorio, Zurla, Cappellari, con segretario mons. Castruccio
39 S.RR.SS., AA.EE.SS., Rapporti delle Sessioni, sessione 102, 13 agosto 1826, America Guatemala, Scisma del Guatemala.
Posizione Stampata n. 17. Cfr. CANAVERO– La Santa Sede e l’indipendenza dei nuovi Stati dell’America Latina, 628; GÓMEZ
ORTIZ – Le relazioni diplomatiche tra Gran Colombia e Santa Sede, passim.
25RO B E R TO R E G O L I
Castracane) si riuniscono alla presenza del papa (coram SS.mo) avendo timore di
un allargamento dello scisma ad altri territori e Stati. La base della discussione è
il voto del cardinale Cappellari. La Congregazione «giudicò opportuno di fissare
la massima che si provvedessero di Vescovi le Sedi vacanti, onde precludere la
strada, per quanto fosse possibile, ad un tanto male; e di più stabilì i mezzi della
esecuzione di questa massima». Se a suo tempo il vescovo di Merida chiedeva
la soluzione della questione tramite nomina di vescovi ausiliari, ora il governo
colombiano chiede dei «Vescovi in proprietà». E i cardinali seguono il governo,
ritenendolo l’unico modo per non aprire uno scisma e non inimicarsi i locali.
Ma con una attenzione, quella di non fare parola del diritto di nomina, per «i
riguardi dovuti alla Spagna», per non somministrare «un fondamento alla
medesima di credere leso il giuspatronato, che pretende di conservare ancora
sopra le Chiese di America». Allo stesso tempo, però, i cardinali vogliono evitare
di fare riferimento alla richiesta del governo colombiano, cassando una frase dalla
lettera di accompagnamento delle bolle di nomina: «Che il Santo Padre, si è messo
a provvedere le Chiese di Colombia a petizione di quel Governo». E ciò per evitare
che il governo colombiano possa «abusare di tale espressione, pubblicandola,
e tirandola ad una quasi ricognizione di giuspatronato». Il punto in questione
è effettivamente il patronato. E la Santa Sede non vuole riconoscerlo a nessuno,
anche se di fatto e non in diritto lo concede ai governi nazionali, a chi realmente
detiene il potere politico, secondo la più classica impostazione pontificia. Questa
situazione di fatto si cristallizzerà nei futuri concordati, che lasceranno ai
presidenti delle Repubbliche il diritto di presentazione ai vescovati.
Per il bene dei fedeli, viene pure deciso di nominare un ausiliare all’arcivescovo
di Charcas (Alto Perù), essendo emigrato, anche senza consultarlo.
Vengono allora nominati da Leone XII, su proposta delle autorità locali, 2
arcivescovi (Bogotà e Caracas) e 5 vescovi (Antioquia, Santa Marta, Guyana, Quito
e La Paz), anche se per rispetto alla Spagna si tace della presentazione politica. Di
conseguenza la Spagna espelle il nunzio. Dal progetto consalviano sotto Pio VII
di nominare dei vicari, si era passati alla nomina di vescovi residenziali. Ma per il
Cile nel 1828 si era tornati alla nomina di un vescovo titolare e vicario apostolico di
Santiago nella persona di Manuel Vicuña Larraín40. Nel 1831 Gregorio XVI nomina
6 vescovi in Messico su presentazione del governo locale, nel 1832 nomina i vescovi
di Buenos Aires e di Santiago41. Negli anni ’30 le indipendenze sono riconosciute de
jure, a partire dalla enciclica Sollicitudo ecclesiarum (1831).
40 Cfr. SALINAS ARANEDA, Carlos – Estudios históricos. El derecho canónico en Chile. Siglo XIX. Valparaíso: Ediciones
Universitarias de Valparaíso – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2016, p. 36.
41 Sulle relazioni tra Santa Sede e America latina al tempo di Gregorio XVI: CASTAÑEDA DELGADO, Paulino – Relaciones Iglesia-
Estado en Hispanoamérica. Gregorio XVI. In SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis; MARTÍNEZ DE CODES, Rosa María, coord.
26Rom a g u ard a ad Occid ente: papato e patro nato ad inizio Otto cento
Come viene ben dichiarato in un’altra riunione relativa al vescovo dell’Avana,
la questione in gioco non è politica ma religiosa. Se la Santa Sede non si trova a suo
agio con i regimi costituzionali questo non deve impedirle di operare secondo i suoi
fini religiosi. In maniera chiara, il verbale riporta il pensiero dei cardinali:
«interessa al sommo il tenere uniti siffatti Governi alla Santa Sede, perché possano aver
luogo le provvidenze necessarie a portarsi ai bisogni spirituali di quella parte di Mondo
Cattolico; così è necessario, che la Santa Sede si astenga da ogni occasione, che possa ai
detti Governi somministrare pretesa di alienazione dal Centro dell’Unità»42 .
In definitiva la Santa Sede non ha difficoltà con l’istituto del patronato, ma
con le modalità di attuazione. Tanto è vero che il patronato vivrà fino al XX secolo,
quando emergerà e diverrà gradualmente dominante un’altra visione, secondo la
quale la libertas Ecclesiae passa per l’autonomia ecclesiale nelle nomine agli uffici
ecclesiastici (sebbene sempre sotto alcuni limiti, così come vengono espressi nei
concordati: il candidato ad un episcopato, ad esempio, deve essere un cittadino
dello Stato in questione ed avere alcuni requisiti politici, ovvero non avere alcune
non meglio determinate criticità politiche con il governo in carica). Il Codice di
diritto canonico del 1917 è un fedele testimone di questa ricerca di autonomia
ecclesiale, in quanto pone quale principio ecclesiale la libera nomina dei vescovi da
parte del papa. In ogni caso, la neutralità, se non addirittura la positività di giudizio
verso il patronato, emerge ancora nel 1827 nelle discussioni relative al Brasile, là
dove anche nei voti dei consultori, come quello di mons. Paolo Polidori, futuro
cardinale, secondo una visione romana43, si riconosce nel patronato l’obiettivo del
perseguimento del bene spirituale dei fedeli:
«se i Pontefici prima della erezione de’ Vescovati ne’ Paesi di nuova scoperta conces‑
sero ai Re di Portogallo, ed al Gran Maestro dell’Ordine di Cristo amplissime facoltà
per spirituale regime di quelle anime, ciò fu perché non potendosi per la immensa
loro distanza implorare dalla Santa Sede le necessarie provvidenze, che altronde non
ammettevano dilazione, potessero in proporzione degli avanzamenti delle Armate vin‑
citrici prestarsi subito quei soccorsi spirituali, i quali nel chiamare que’ Popoli al lume
della vera Religione rendevansi necessarj al momento»44.
– Homenaje a Alberto de la Hera. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p. 171-198. Consultabile online
anche in https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2548/11.pdf. Consultato il 29/07/2021.
42 S.RR.SS., AA.EE.SS., Rapporti delle Sessioni, sessione 111, 11 maggio 1828, Indie Occidentali – Avana, Disordini prodotti nella
Diocesi da Mons. Gio. Giuseppe Diaz de Espada, vescovo dell’Avana nell’India Occidentale, e provvidenze da prendersi. I
cardinali congregati sono Della Somaglia, De Gregorio, Zurla, Micara, Cappellari con segretario Castracane.
43 Voto di mons. Paolo Polidori, in S.RR.SS., AA.EE.SS., Rapporti delle Sessioni, sessione 105, 11 marzo 1827, Brasile, Domanda
dell’Imperatore del Brasile per una speciale Costituzione Apostolica,f. 126v-129v.
44 Voto di mons. Paolo Polidori, f. 127v-128r.
27RO B E R TO R E G O L I
Il riconoscimento del patronato in Brasile è volto agli stessi fini di bene dei
fedeli, così come scrive ancora Polidori:
«che abbiasi ad impiegare viemaggiormente la pietà di quel Sovrano a zelare i progressi
della Religione, vegliando alla difesa della sana dottrina, proteggendone i Sacri Minis‑
tri, e vendicandola dagli attentati di quelli, i quali non conoscendo, che la sapienza della
carne, formano nell’avvilimento della Religione la ruina del Trono»45.
Le criticità di giudizio riguardavano in ultimo la scelta dei candidati ai
benefici, così come emerge dal voto del consultore sacerdote Albertino Bellenghi:
«Evvi tra gli Ecclesiastici dell’America, senza escluderne il Brasile, un disgraziato
forte partito di Novatori Regalisti dichiarati, acerrimi nemici della Santa Sede, delle
sane massime, e delle Cattoliche verità. Tutto ciò chiaramente apparisce tanto dalle
relazioni, che da colà vengono, quanto dai libri che ivi si stampano, i quali ridondano
di perverse massime dei Regalisti, Giansenisti, Febroniani, sostenuti dai Governi, ed
anche dei Filosofi tollerati dai Monarchi: tutto frutto della libertà di stampa. In sequela
di queste viste è prudenza il dubitare, che col concedersi la richiesta speciale Costituzione
diasi motivo ad ulteriori peggiori abusi, derivanti dal partito degli anzidetti Ecclesiastici
nemici della S. Sede, uniti ai Secolari Regalisti, i quali potrebbero coi loro raggirati dis‑
corsi, ed in forza di sofismi sorprendere il Ministero, ed ingannare il Sovrano, per far sì
che cadesse la nomina, e la presentazione sopra di loro medesimi; e per conseguenza su
di persone indegne; lo che recherebbe non lieve pregiudizio alla Cattolica Religione»46.
Il patronato in ultimo era un istituto concesso a sovrani cattolici per fini
eminentemente cattolici: il bene dei fedeli. Non dissimile in Europa era la nomina dei
vescovi lasciata ai sovrani cattolici o ai governi con presidenti/primi consoli cattolici
(come la Francia del 1801). I problemi per la Santa Sede nascono nel momento in
cui i diritti di patronato o la tolleranza passiva verso le nomine episcopali imposte
diviene oggetto politico o quando vengono nominati candidati indegni. Per
l’A merica latina dell’800 e della prima parte del ‘900 la questione sarà legata alla
dignità morale e dottrinale dei candidati, proposti non raramente da governi non
solo non cattolici ma propriamente anticlericali47.
45 Voto di mons. Paolo Polidori, f. 129r.
46 Voto dell’abate Albertino Bellenghi consultore, in S.RR.SS., AA.EE.SS., Rapporti delle Sessioni, sessione 105, 11 marzo 1827,
Brasile, Domanda dell’Imperatore del Brasile per una speciale Costituzione Apostolica, con cui si dichiari esso, ed i suoi
successori Gran maestri dell’Ordine di N.S. Gesù Cristo nel Brasile con tutti i diritti e i privilegi annessi. Pos. Stampata n.23,
f. 117v-126r, qui 122r.
47 Cfr. REGOLI, Roberto; VALVO, Paolo – Tra Pio X e Benedetto XV. La diplomazia pontificia in Europa e America Latina nel 1914.
Roma: Studium, 2018.
28Rom a g u ard a ad Occid ente: papato e patro nato ad inizio Otto cento
Visione di insieme e di prospettiva
Tentando di gettare uno sguardo d’insieme, si può considerare che nel lungo
‘800 si confrontano due autorità, quella statale e quella della Chiesa, in ordine
alla legittimità delle loro decisioni in ambito beneficiale. La questione ultima del
patronato riguarda, infatti, i poteri decisionali nella Chiesa, chi può decidere cosa.
Nell’800 la questione tocca la tematica della sovranità della e nella Chiesa, per cui
si giunge alla mimesi dello Stato da parte della Chiesa (perfecta societas), che mutua
per l’appunto forme statali per rendere ragione della propria pretesa di autonomia
e indipendenza. Non a caso la questione dell’autorità e quindi della legittimità
ecclesiale nel mondo passa anche per il primato papale (uno che governa su tutti),
riconosciuto nel Concilio Vaticano I48.
Questo equilibrio di poteri, in ordine non solo al rapporto Chiesa-Stato,
ma anche Chiesa-società (che è il vero ambito del confronto tra Chiesa e seconda
modernità), si riverbera su lungo periodo nei testi dei concordati sottoscritti tra il
papa e gli Stati indipendenti latinoamericani49. In quegli accordi, infatti, ritorna
il patronato sotto la forma semplificata del diritto di nomina agli episcopati, cioè
compare un patronato sotto altro nome. In quei testi, nelle trattative e nella successiva
attuazione emerge chiaramente una volontà di controllo sulla Chiesa, quando in
Europa cominciava a perdersi o, meglio, cominciava a spostarsi l’attenzione su altri
fronti. In qualche modo i modelli di Chiesa e Stato in gioco in Europa e America
latina sono diversi.
In Europa da una vecchia e superata concezione teologica dello Stato, nata in
un contesto di christianitas, dove il sovrano indirizza la vita della Chiesa all’interno
dei territori posti sotto la sua sovranità, si procede, a causa delle forze liberali, verso
una desacralizzazione dello stesso Stato, nonostante i Te Deum cantati nelle grandi
occasioni della vita civile. Ormai si distingue sempre più nettamente l’ambito
religioso da quello politico, fino a giungere a un disinteresse del politico nei riguardi
dei processi decisionali ecclesiali, esemplarmente proprio nel caso delle nomine
episcopali. Ormai il ruolo dei sovrani e dei presidenti delle Repubbliche non ha più
una valenza ecclesiale. Le Chiese nazionali muoiono e i patronati non hanno più
ragione d’essere. Tanto in Europa che in America.
48 Cfr. BAUMEISTER, Martin; CIAMPANI, Andrea; JANKOWIAK, François; REGOLI, Roberto, ed. – Il Concilio Vaticano I e la
modernità, Roma: G&BPress, 2020.
49 LORA, Erminio, ed. – Enchiridion dei concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa Stato. Bologna: EDB, 2003.
29Puoi anche leggere