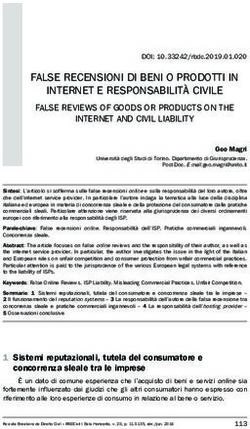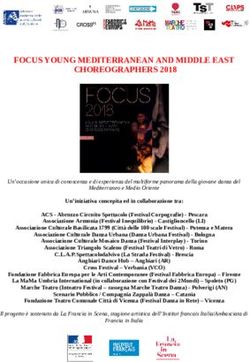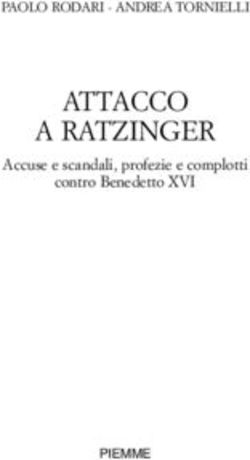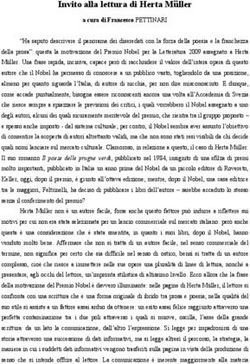Presentazione - La Venaria Reale
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Presentazione
Con il secondo volume della collana Architettura e Potere. Lo Stato Sabaudo
e la costruzione dell’immagine in una corte europea continua il progetto di
ricerca – frutto della cooperazione della Bibliotheca Hertziana di Roma (Isti-
tuto Max-Planck per la Storia dell’Arte), del Consorzio «La Venaria Reale» e
del Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e Design e Diparti-
mento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio) – orientato
ad approfondire e specificare il ruolo degli architetti di corte dei Savoia nel-
l’ottica delle relazioni internazionali, sia sotto l’aspetto biografico, sia negli in-
terventi progettuali ex novo e di completamento su diverse scale a livello ur-
banistico per i sovrani, per la nobiltà e il clero, anche in centri italiani e non.
Il convegno sistematizza gli studi finora condotti e fornisce nuove letture
della figura di Benedetto Alfieri e della sua opera di architetto in un contesto
che vede operanti e intrecciate la tradizione tardobarocca e rococò e la rinno-
vata attenzione al linguaggio classico. I saggi, presentati da studiosi di livello
internazionale, permettono innanzitutto di inquadrare in un sistema più orga-
nico i contributi e le ricerche sin qui svolte, ma anche di riflettere sull’effettivo
profilo di Alfieri attivo tra Asti, Torino, Vercelli e Ginevra.
Anche con questo volume si vuole sottolineare l’importanza della coopera-
zione della comunità scientifica internazionale e confermare il lavoro delle
istituzioni coinvolte, accresciuto dalla possibilità di ospitare i convegni nei
luoghi degli eventi, permettendo il contatto diretto con le opere discusse nelle
giornate di studi. L’auspicio che si rinnova è quello che le ricerche finora con-
dotte possano incentivare un’apertura del mondo accademico e scientifico nel
processo interdisciplinare di aggiornamento, sistematizzazione e avanzamento
della ricerca.
Il comitato scientificoArchitettura e architetti di corte in Europa tra Tardobarocco, Rococò e Classicismo 1 Paolo Cornaglia, Elisabeth Kieven, Costanza Roggero Benedetto Alfieri (1699-1767), architetto, avvocato e titolare delle cariche pubbliche di consigliere e sindaco di Asti, nel 1739 succedette a Filippo Juvar- ra (1678-1736) come Primo Architetto civile del re di Sardegna: una ponderosa eredità che seppe gestire magistralmente con un’attività ininterrotta presso Carlo Emanuele III (1701-1773), la sua corte e la città di Torino. A distanza di oltre trent’anni dalla prima monografia sull’artista 2 e a un ventennio dalla mostra sull’opera astigiana del Nostro 3 – gli unici lavori che affrontino coeren- temente il tema –, da un convegno su Benedetto Alfieri ci si attende una serie di risultati che specifichino e gettino nuova luce su quegli aspetti dell’attività del Primo Architetto Regio rimasti ancora insoluti. Questi sono stati elencati nel saggio di Amedeo Bellini: la sua formazione scolastica e culturale, la prima attività, ossia «le basi di una carriera che lo conduce [...] non più giovanissimo dilettante di provincia [...] alla carica di Architetto Regio», la verifica del- l’affermazione che non si trattava di un architetto dilettante, ma di un perso- naggio con un profilo professionale esperto e con una «preparazione architet- tonica di duplice valenza», il suo apporto nel funzionamento dello Studio Re- gio di Architettura, la continuazione dei progetti juvarriani, il suo eclettismo e la questione delle opere non realizzate, nonché della continuazione di quelle da lui improntate. Nel suo bilancio Bellini riconosce il persistere di condizioni ineludibili che ancora continuano a ostacolare un totale scioglimento dei punti rimasti irrisolti. Pur tuttavia sono significativi gli apporti di natura storico-biografica con- fluiti nel contributo di Carla Forno che aiutano a meglio comprendere la figu- ra alfieriana inserendola in un articolato reseau genealogico, nel quale per pri- ma cosa non va dimenticato il celebre Vittorio Alfieri e l’immagine che egli ha trasmesso dello zio nel complesso rapporto fra i due artisti – il poeta e l’ar- chitetto – accomunati dall’appartenenza a un’antica nobiltà di origini medioe- vali, oltre che dal vincolo familiare e dai legami di parentela che li univano a personaggi di spicco nella Torino settecentesca. Pur evitando di redigere un profilo ufficiale del «semi-zio» Vittorio, nella sua autobiografia, ci rende parte- cipi di ricordi e di giudizi in merito all’attività di Benedetto, aiutandoci a in- quadrare attitudini professionali e talvolta risvolti psicologici del nostro ar- chitetto. Oltre alle fonti scritte, per le quali mancano quasi totalmente testimo- nianze d’archivio che attestino, anche da parte di terzi, contatti di natura pri-
12 PAOLO CORNAGLIA, ELISABETH KIEVEN, COSTANZA ROGGERO vata o rapporti di carattere professionale e dove solo la tardiva biografia di Paroletti (1803) rimane l’unico punto di riferimento, scarseggiano anche quelle visive. Sono unicamente tre le tracce iconografiche che ci consentono di ri- costruire l’aspetto fisico di Benedetto Alfieri, che tuttavia risultano quanto mai problematiche per la loro autenticità. Andrea Merlotti le analizza nei suoi aspetti più importanti, sottolineando quelli incongruenti con la conoscenza che abbiamo dell’Alfieri uomo e architetto. E nuovamente viene confermata la natura sfuggente di questo personaggio, favorita dalla situazione in parte la- cunosa degli archivi, quelli romani ad esempio, che pur permettendo di speci- ficare alcuni momenti dell’infanzia romana di Alfieri non consentono di verifi- care una sua frequentazione del collegio gesuita, venendo a mancare i registri di classe. Ciò nonostante Elisabeth Kieven delinea l’esuberante situazione cul- turale e artistica degli anni sotto il pontificato clementino (1700-1721), la forza motrice esercitata dall’Accademia di San Luca, la presenza di Juvarra a Roma e i dibattiti intellettuali presso la corte pontificia, ma anche nei circoli di nobili eruditi. Pur non disponendo di informazioni precise sull’insegnamento ricevu- to dal promettente architetto, certo è che nella città papalina egli aveva avuto la possibilità di sfruttare un fertilissimo terreno intellettuale. Con questo bagaglio di esperienze Alfieri fece dapprima ritorno a Torino, dove studiò legge presso il Collegio dei Nobili, trascorse successivamente un periodo ad Asti dove esercitò tra l’altro l’arte forense prima di entrare a contatto con la corte sabauda e diventarne il principale artefice in campo architettonico. Ma prima di affrontare questi aspetti va delineato il contesto internazionale. Grazie a studi specifici su figure contemporanee al Nostro, attive presso corti italiane ed europee, una campionatura ha reso possibile un confronto sulla po- sizione, l’attività, la competenza e le responsabilità di un architetto di corte: Vanvitelli (1700-1773) per i Borbone a Napoli, Jean-Nicolas Jadot (1710-1761) per i Lorena nel Granducato di Toscana, Ennemond-Alexandre Petitot (1727- 1801) per i Borbone a Parma, Ange-Jacques Gabriel (1698-1782) alla corte francese e Ventura Rodríguez (1717-1785) uno dei massimi esponenti dell’ar- chitettura tardobarocca spagnola. Dai singoli studi emerge che la figura dell’architetto di corte non ha un pro- filo preciso e definito, ma che varia a seconda delle esigenze e in virtù del- l’eterogeneità delle corti, seppur nel comune intento di una loro massima cele- brazione. Così i temi della chiamata a corte, il conferimento della carica, i compiti e le competenze vanno affrontati di volta in volta singolarmente. Tro- viamo Luigi Vanvitelli, nell’analisi di Jörg Garms, al seguito dei Borbone a Caserta, il quale pur non essendo per natura ‘uomo di corte’, ben si inserisce e adatta alla situazione, soprattutto cercando di sfruttare la sua posizione, oltre che a fini personali, anche per garantire un futuro ai figli. Spesso tuttavia le chiamate non dipendono da una fama consolidata, ma piuttosto da un talento che spesso si manifesta più nella forza persuasiva dei progetti e nelle compe- tenze tecniche che nelle architetture realizzate. Le doti di Vanvitelli – per il quale, contrariamente all’Alfieri, si dispone di innumerevoli lettere – sono la «prontezza lodata dal re [...], i disegni e le grandiose prospettive [...], la con-
ARCHITETTURA E ARCHITETTI DI CORTE IN EUROPA 13 duttura delle acque, il traforo del monte e l’acquedotto» – che furono sostenu- te dalle ottime raccomandazioni. Pur tuttavia la fiducia va conquistata e con- fermata presso i sovrani e per Vanvitelli sono puntualità, precisione, onestà, «servizio con amore e assiduità» a fornirgli il giusto apprezzamento, ma solo finché serve: cambiano le situazioni, il sistema si trasforma e l’architetto può presagire il suo declino a corte e l’abbandono del cantiere con importanti opere ancora da ultimare; quelle che prima erano raccomandazioni possono diventare screditamenti: dall’ascesa alla caduta. Anche la personalità artistica di Jadot, affrontata da Oronzo Brunetti, è dif- ficilmente definibile e ugualmente per lui sono lacunosi gli anni della for- mazione, non si hanno testimonianze di un’appartenenza a un’accademia, le opere eseguite sono modeste (tra l’altro quasi tutte di natura effimera) e molteplici sono le manifestazioni di ostilità da parte dei fiorentini nei confron- ti dell’architetto lorenese. Anche in questo caso rimane imperscrutabile il mo- tivo per cui il granduca Francesco Stefano (1708-1765) abbia tanto sostenuto la carriera del giovane Jadot, che a Firenze aveva eseguito unicamente un arco di trionfo, e lo abbia addirittura portato con sé a Vienna nel 1753 otto anni dopo la sua elezione a imperatore. Per Petitot, come ricorda Carlo Mambriani, sono già state evidenziate le caratteristiche che lo accomunavano all’Alfieri, sia di natura personale che riguardanti «i linguaggi variegati» e la concezione utopica di certi progetti, ma anche la comune predilezione per soluzioni o temi architettonici, come ad e- sempio i teatri. In maniera empirica si deduce l’uso che entrambi fanno di un vocabolario formale, che seppur personale e rielaborato, traeva ispirazione dal repertorio architettonico europeo, ma che non trova riscontro in scritti teorici. La prima educazione e le possibili influenze assimilate dalle frequentazioni di artisti e teorici vanno dunque analizzate per ricostruire processi formativi, sperimentazione e sviluppo di abilità eterogenee, oltre all’ars combinatoria di diversi stilemi e la propensione agli assemblaggi per rispondere alle aspettative di una corte, pur nella certezza che il «Primo Architetto di un principe, gode di una sicurezza d’impiego e di un prestigio che gli evitano la faticosa ricorsa di occasioni professionali e le attività mercantilistiche collaterali». Queste manifestazioni erano ancora possibili prima che l’estetica illuminista e la teoria classicista definissero un programma più consono e filologicamente coerente soprattutto nei riguardi dell’Antico. Ange-Jacques Gabriel si differenzia dai casi precedenti poiché, discendente di un’antica famiglia di architetti non è mai stato in Italia, ma gravita e si forma nell’entourage di corte accanto a Mansart e de Cotte, e come successore del padre Jacques, è testimone di una triplice eredità: familiare, architettonica e monarchica, divenendo responsabile dello sviluppo del «grand goût» di una delle maggiori dinastie europee, come sottolinea Alexandre Gady. Il suo per- corso alla corte di Luigi XV (1710-1774) vede la sua trasformazione da decora- tore a ideatore su scala monumentale, dovendosi confrontare con l’ampliamen- to delle grandi fabbriche di Fontainebleau, Compiègne e Versailles, e dovendo affrontare compiti nuovi come l’École Militaire, Place Louis XV (Place de la
14 PAOLO CORNAGLIA, ELISABETH KIEVEN, COSTANZA ROGGERO
Concorde) o il Petit Trianon, considerato il suo capolavoro. Nel difficile mo-
mento di trasformazione che coincide con la metà del Settecento Gabriel, in
questo ruolo completamente incentrato sulle esigenze della corte, diventa me-
diatore fra la tradizione monarchica, quella francese e il nuovo linguaggio del
Neoclassicismo, ottenendo risultati e apprezzamenti anche contrastanti.
Ventura Rodríguez, invece, come emerge dal saggio di José Luis Souto e Jo-
sé Luis Sancho, non lavora esclusivamente per la corte, ma altresì per l’aristo-
crazia e la gerarchia ecclesiastica, soprattutto perché, nonostante avesse colla-
borato al fianco di Juvarra e poi del suo allievo Giovanni Battista Sacchetti, al-
la morte di quest’ultimo sfortunatamente non venne nominato architetto di
corte. Tuttavia il suo contributo all’architettura spagnola del XVIII secolo fu
determinante: Rodríguez seppe ben tradurre il Barocco italiano facendosi por-
tavoce di uno stile di impronta berniniana e borrominiana, ma anche dell’inse-
gnamento di Juvarra con apporti derivanti dall’architettura piemontese, svi-
luppando un linguaggio che caratterizzò l’ultimo periodo barocco spagnolo.
Alfieri architetto per la corte
Le Roy m’a paru content de la lettre que vous m’avez écrite au sujet du Théâtre de
Turin, et S.M. attend et verra avec plaisir le plan que M. de Tournehem lui remettra de
votre part. Je vous avoue que suis aussi curieuse de le voir. Vous avez fait à merveille
de vous lier avec le comte Alfieri (Madame de Pompadour a Marigny, 6 febbraio
1750) 4.
Filippo Juvarra era stato ritenuto il miglior architetto per disegnare il Palaz-
zo Reale di Madrid, e aveva progettato per altre corti, ma anche Benedetto Al-
fieri, un quindicennio dopo la morte del predecessore, è al centro di relazioni
internazionali e gode di un riconoscimento europeo. Nel viaggio di Marigny,
Le Blanc e Soufflot il teatro di Alfieri e la sua figura sono un riferimento. Ma-
rigny, molto ben accolto dal re Carlo Emanuele III e dal duca di Savoia Vitto-
rio Amedeo rientra a Torino nell’estate in occasione del matrimonio di que-
st’ultimo, come ricordato dalla Pompadour :
Je crois que vous ne pouvez vous dispenser de retourner à Turin pour le mariage du
duc de Savoye, après les bontés qu’il vous a marqué, et l’espèce d’engagement qu’il
vous a fait prendre à ce sujet [...]. Informez-vous des habits qu’il vous faudra pour ces
fêtes, et mandez-le moi ; je m’en chargerai, et je veux que vous soyez convenablement
à tous ces égards 5.
Marigny ha quindi modo di apprezzare quanto realizzato dal Primo Archi-
tetto di S.M. per l’occasione. Gli allestimenti realizzati da Alfieri per i festeg-
giamenti mostrano un mélange di riferimenti classici e tradizione tardoba-
rocca : il «peristilio» di Palazzo Madama viene riprodotto con strutture effi-
mere per nasconderne il fronte orientale ancora medievale, il basamento loda-
to da Cochin (e rilevato da Pierre Patte, che lo pubblica nel 1775) viene repli-
cato a nord occultando il vecchio porticato d’accesso all’avant cour del Palazzo
Reale, il centro della piazza viene ornato da una colonna trionfale “romana”ARCHITETTURA E ARCHITETTI DI CORTE IN EUROPA 15 sovrastata dalla raffigurazione di Amore, ma guarnita alla base da strutture an- cora visibilmente barocche. All’interno del palazzo il salone maggiore accoglie un allestimento temporaneo per il ballo, con struttura a cavea allungata e co- lonne trabeate a sostegno delle tribune superiori. Le stesse vicende legate alla cattedrale di Ginevra (sempre intorno a quegli anni, 1751) confermano la rile- vanza dell’architetto nel contesto geopolitico franco-sabaudo che in seguito si è persa nel passaggio dal dibattito corrente alla storiografia. Che Alfieri fosse in qualche modo attento al dibattito del momento ci è ri- velato dalle sue critiche ai “capricciosi modellini francesi” 6 che il conte Giu- seppe Francesco Ludovico Morozzo della Rocca riporta come sue nel memo- riale steso il 30 agosto 1759 in merito al completamento del suo palazzo in Tori- no su progetto di Benedetto Alfieri. Le parole presenti nel memoriale del con- te da un lato riflettono una componente classica presente nell’architettura di Alfieri, dall’altro riecheggiano con prontezza il mutare del contesto, assumen- do modalità tipiche in Europa, dove la critica al rococò passa attraverso la cri- tica alla Francia. L’opposizione ai “capricciosi modellini francesi” è stata inter- pretata come influenza del recente orientamento classicheggiante, peraltro nuovamente di matrice francese. In effetti oltre ai contatti tra Alfieri e Mari- gny, comunque precoci per poter essere ritenuti una fonte, anche se non van- no sottovalutati, occorre ricordare le tappe della via crucis del rococò: nel 1745 l’Abbé Le Blanc, membro del gruppo di Marigny, aveva pubblicato le Lettres d’un françois indirizzate a Caylus, nelle quali si parlava di «gusto depravato», nel 1754 e nel 1755 si susseguono sul Mercure de France 7 gli attacchi di Cochin, nelle forme di una supplica agli orefici affinché abbandonassero tutto il ridico- lo della rocaille e nella incapace e quindi spassosa autodifesa di un architetto rococò che contribuisce ancor di più a stigmatizzare l’involuzione del gusto: «Dato che ci veniva criticata la decorazione esterna l’abbiamo ridotta aumen- tando le finestre. Certo d’inverno fa più freddo e d’estate più caldo. Ma cosa ce ne importa?» Le critiche contenute nei due pamphlets di Cochin sembrano tra l’altro rivolgersi alla diffusione di questo gusto, al ruolo giocato dalle inci- sioni, alla promozione di una certa libertà e all’idea di poter fare da sé, senza regole, al ruolo giocato dal pubblico («il pubblico ci ama»). Ed è proprio la formazione di un “pubblico” a emergere nel memoriale del conte: la nobiltà e non altri architetti commenta le scelte del Morozzo. La ricezione dei pam- phlets citati può essere una delle ragioni alla base delle critiche al rococò, uni- tamente ai rapporti maturati fra Alfieri e il gruppo di Marigny nel 1750. Peral- tro nell’ambito della corte l’attenzione al Classicismo e al dato archeologico emerge proprio in quegli anni: data al 1747 la raccolta del Governatore dei Palazzi Reali Carlo Emanuele Cavalleri di Groscavallo (indicato dall’Algarotti quale «novello Palladio») Disegni di fabbriche si antiche, che moderne fatte per trattenimento di SAR Madama Luisa di Savoia [...], secondo l’autore eseguiti spesso in sua presenza, mostrano un’attenzione verso un’architettura generica- mente palladiana, verso la ricostruzione a volte fantastica di complessi ar- chitettonici romani e la documentazione di monumenti antichi presenti nel
16 PAOLO CORNAGLIA, ELISABETH KIEVEN, COSTANZA ROGGERO regno, come quello di La Turbie presso Nizza o l’arco di Susa, quest’ultimo visto da Cochin e De Lalande. Giovanni Paolo Ricolvi e Antonio Rivautella pubblicano Marmora Taurinensia Dissertationibus et Notis illustrata (Torino 1743-1747) e gli esiti di scavi recenti in Piemonte (Il sito dell’antica città di In- dustria [...], Torino 1745). Gli studi di Scipione Maffei sul lapidario torinese (Museum Taurinensis) sono pubblicati a Verona nel 1749, per i tipi del Semi- nario, nel volume Museum Veronense hoc est Antiquarum inscriptionum atque anaglyphorum collectio cui Taurinensis adiungitur et Vindobonensis [...]. Infine l’architetto Paolo Masazza pubblica nel 1750, presso la Stamperia Reale di Torino, L’Arco antico di Susa. Se questo è il quadro degli anni cinquanta del Settecento, bisogna ricordare che Alfieri raggiunge la carica di Primo Architetto di S.M. nel 1739, grazie alla brillantissima prova costituita dalla progettazione e dalla realizzazione del Tea- tro Regio inaugurato nel 1740. In questa sessione del convegno è Daniel Ra- breau a fornire una acuta analisi della rilevanza di questo edificio nel quadro dell’architettura teatrale del momento. Certo, a fronte dell’emergere del mo- dello palladiano e del teatro all’antica come fonte per quello «gallo-grec» in- carnato dalla Comédie Française di Peyre e De Wailly, «il n’est alors plus que- stion du chef-d’oeuvre d’Alfieri», ma le prime realizzazioni di Soufflot (Lione, 1753-56), Moreau (Parigi, 1770) e Gabriel (Versailles, 1770) tra il 1753 e il 1770 mostrano secondo Rabreau l’influenza della pianta della sala torinese. L’atten- zione alla dimensione teatrale (mostrata da Alfieri anche nella progettazione del giardino del palazzo Morozzo della Rocca, concepito con la pendenza di un palcoscenico) è ancora concretizzata – nei cruciali anni cinquanta – dalla costruzione del Teatro Carignano, anch’esso – come il precedente Regio – oggetto di studio e rilievo da parte di Gabriel Pierre Martin Dumont, autore del Parallèle de plans des plus belles salles de spectacles d’Italie et de France, pubblicato a Parigi, nel 1765-1777. Il tema è qui affrontato da Laura Palmucci, che sottolinea il passaggio dalla sala a ellisse tronca a quella conformata a ferro di cavallo, una scelta sperimentata al teatro Argentina in Roma (Theodoli 1737) e che in Italia verrà poi seguita da Galli Bibiena (Bologna, 1755), Piermarini (La Scala, Milano, 1776-1778), Selva (Venezia, La Fenice, 1790-1791). Come per il Regio anche per il teatro del principe di Carignano emerge visibile l’attentis- sima progettazione dei meccanismi distributivi, separati per funzione e rango. Ancora una volta il teatro sfugge alla città (pur arricchendo la piazza e dotan- dola di un comodo portico), con una discrezione che sarà avversata nel dibat- tito francese di quei decenni: per quanto autonoma nel volume edilizio, l’ar- chitettura presenta se stessa come un palazzo nobiliare, senza enfasi sulla rico- noscibilità della funzione. Il profilo di Alfieri come architetto di corte e di Sta- to è quindi affrontato principalmente nei saggi di Paolo Cornaglia e Tiziana Malandrino, pur in assenza – purtroppo – del contributo di Giuseppe Darda- nello sul ruolo del disegno e del regio studio di architettura. Nel primo dei due contributi è sottolineato un particolare approccio di Alfieri nell’accogliere l’eredità dei predecessori e nell’adeguarsi alle nuove esigenze del pieno Sette-
ARCHITETTURA E ARCHITETTI DI CORTE IN EUROPA 17 cento. Spesso l’architetto completa e “mette a regime” quanto solo in parte impostato da Juvarra, promuovendo però un salto di scala, visibile a dispetto delle perduranti incompiutezze che affliggono anche i suoi cantieri. Al gonfiar- si dei volumi si connette una maggiore monumentalità, adatta alla stabile capi- tale di un regno che si è ancora ingrandito, senza che questo significhi rinun- ciare alla funzionalità (anzi) o alla raffinatezza. Emblema di questo eclettico adeguarsi a input differenti è – come sottolineato – lo scalone delle Segreterie, che muta forma e decorazione, profilo e aspetto in base alle esigenze differenti di piano in piano. L’eclettismo di Alfieri può essere inteso come seria matu- rità, capacità di trovare soluzioni corrette a problemi diversi con formule dif- ferenti. Alla capitale del regno, sotto Vittorio Amedeo II, serviva un genio ca- pace di connotare in modo indelebile il suo volto. Negli anni di Carlo Ema- nuele III serviva invece una mente salda, robusta, capace di tenere le redini di ciò che era stato iniziato ma anche di adeguarlo a nuove e più complesse esi- genze, unendo monumentalità e dettaglio, semplicità e raffinatezza. Lo stesso approccio è verificabile a Venaria Reale, dove si assume il ruolo di completare il palazzo e determina consapevolmente la sua perenne asimmetria. Sono ope- re frutto di una diversa strutturazione dell’Ufficio: disegnatori specialisti – co- me l’architetto Francesco Martinez – sono incaricati di redigere i grandi al- bum di presentazione regia, non presenti in passato 8. Certo l’elenco del Sottis documenta la consistenza dei disegni juvarriani presso l’Archivio Privato del re, ma se gli schizzi sono raccolti in volumi, non sono presenti grandi album come quelli delle fabbriche regie concepite da Alfieri. Peraltro, a fine Sette- cento, l’architetto Randoni, alle prese con il completamento di Rivoli, si la- mentava di avere – di fatto – quale unico riferimento il modello ligneo e poche altre cose. Il Primo Architetto di S.M. Alfieri progetta e vive nell’appartamen- to realizzato nella manica accanto al suo Teatro Regio. Si reca poco in cantiere, si affida molto ai suoi Misuratori Generali. Se i primi disegni per la Cavalleriz- za sono firmati da Alfieri, seguono poi disegni di Giuseppe Giacinto Bays «per il conte Alfieri», quindi disegni firmati dai soli misuratori. Complementari a questo intervento sono il contributo sul concreto dipanarsi del cantiere di Ve- naria Reale, di Silvia Beltramo, attento alla regia di Giuseppe Giacinto Bays quale “mano” di Alfieri nel costruire la sua architettura in base alle sue esigen- ze e ai suoi parametri di qualità, e quello di Beatrice Fracchia sulle istruzioni che regolano i cantieri di Alfieri nella prima fase in cui ancora l’architetto ver- ga di suo pugno – o comunque sottoscrive – i documenti. Tiziana Malandrino, invece, focalizza l’intervento di Alfieri in un edificio cardine dello Stato, quello che riunisce Corte dei Conti e Senato (la magistratura suprema), e il carcere senatorio. Anche in questo caso l’architetto incrementa lo spazio occupato dalle funzioni principali – in special modo per la Camera dei Conti – occupan- do interamente l’isolato, e articolando gli spazi in ragione di ciò che la legge prevede. Alfieriana, versus l’impianto del predecessore, è l’eliminazione della conformazione a padiglioni a favore di una mole più compatta, così come – pur nel mantenimento dell’ordine gigante – il passaggio dall’ordine dorico a quello jonico. Alfieri, peraltro, non si esime dall’uso del dorico per edifici
18 PAOLO CORNAGLIA, ELISABETH KIEVEN, COSTANZA ROGGERO
monumentali dai robusti usi utilitari, come nel caso delle scuderie di Venaria
Reale, rivelando una diversa logica graduata dell’uso dell’ordine. Un aspetto
sicuramente moderno, mostrato da Alfieri in questo frangente rispetto al
panorama relativo ai luoghi di detenzione, emerge nel progetto per le carceri
senatorie: la centralità di una funzione come la cappella è risolta attraverso
l’uso della forma circolare e il posizionamento centrale tra due bracci, ov-
viamente sulla scia della canonica struttura a croce ospedaliera e probabilmen-
te delle esperienze di Fuga a Napoli (Albergo dei Poveri, 1749). Forte è la sug-
gestione che la versione di Alfieri – con un sistema di ambienti a settore di
corona posti intorno alla cappella – suscita in relazione alle successive con-
cezioni benthamiane del panopticon. Proprio in merito alle carceri Alfieri –
come ricorda l’autrice – segna uno scarto rispetto al predecessore Juvarra: la
raccolta dei disegni rivela infatti che sono stati concepiti in base al «sentimen-
to» del Primo Presidente del Senato: il progetto si affranca dal glorioso e pio-
nieristico rapporto sovrano-architetto e si relaziona con una diversa commit-
tenza, in una realtà più articolata dello Stato.
Alfieri architetto della città, dei nobili, del clero
Se la carica di Primo Architetto regio conferita nel 1739 a Benedetto Alfieri
induce a ricondurre nell’ambito della cultura di corte il dibattito sull’architet-
tura tardobarocca con le sue aperture verso il Classicismo, una riflessione non
secondaria può scaturire dalla considerazione del ruolo primario che egli
svolge in parallelo anche all’interno della struttura dirigenziale del Comune di
Torino ove assume, a partire dagli anni quaranta del secolo, l’incarico ufficiale
di decurione, di sindaco, quindi di “chiavaro”. La sua presenza attiva nei lu-
oghi dei due poteri – lo Stato e la Città – riflette in termini quasi simbolici, il
modello di governo di uno Stato attento a perseguire senza conflitti quegli ide-
ali di “pubblica felicità”, nell’assoluta coincidenza non solo programmatica ma
anche esecutiva delle azioni destinate a conferire una moderna dimensione ur-
banistica alla capitale del regno. Nel grande quadro dell’Europa del pieno Set-
tecento, aspetto comune alle grandi “metropoli” o sedi governative, è infatti
quello di proporsi come luoghi di sperimentazione delle politiche urbane, me-
diante il coinvolgimento di gruppi sociali emergenti che ne controllano lo
sviluppo economico.
La razionalità figurativa del nuovo disegno urbano, inteso nell’accezione
progettuale di “piano” attuativo attento alla categoria dell’embellisement dif-
fuso che coinvolge l’intera città secondo le teorie espresse da Marc-Antoine
Laugier alla metà del secolo XVIII, segna l’aprirsi a modi compositivi di stampo
illuminista, nell’indissolubile unitarietà stabilita tra regolarità della trama
viaria e impaginazione degli edifici, accanto alla riflessione sulla funzionalità
dei fabbricati e all’attenzione agli interessi collettivi.
Oltre le suggestioni juvarriane legate all’emergere monumentale dell’ar-
chitettura entro ben individuate visuali scenografiche, in una città che si apre
al territorio in corrispondenza dei nodi delle porte urbiche, la capitale del reg-ARCHITETTURA E ARCHITETTI DI CORTE IN EUROPA 19 no di Carlo Emanuele III subito avvia il proprio disegno di rinnovata moder- nità ed esemplare riforma urbana nel duplice segno del principio della regola- rizzazione del fatiscente e degradato centro antico, ma soprattutto del control- lo globale che si intende esercitare sull’intero processo economico-sociale. Il coinvolgimento dell’Alfieri nell’ampio programma di ristrutturazione del nucleo storico di Torino, è analizzato puntualmente da Maria Vittoria Catta- neo nei suoi complessi risvolti procedurali e attuativi a proposito del radicale intervento di “dirizzamento” (1736) di via Dora Grossa, attuale via Garibaldi. Gli editti insistono sulla categoria del “decoro urbano” quale motivazione necessaria a sostegno della rettifica del percorso viario di una contrada desti- nata ad accogliere attività terziarie e commerciali di lusso, attraverso un inter- vento che prevede l’allargamento del sedime stradale e la conseguente de- molizione e ricostruzione degli edifici di matrice medievale prospettanti la contrada secondo un’architettura “uniforme e normata”, fondata sul principio stabilito di “grossazione” o accorpamento fondiario dei lotti. Di sicuro inte- resse è il diretto coinvolgimento dell’Alfieri, che firma (1739) le norme esecuti- ve che dal suo regio Studio di architettura invia all’ufficio municipale del Vica- riato, precisando i criteri da seguire per il disegno della quinta uniformata de- gli isolati, configurando il modello architettonico e funzionale dei palazzi da reddito settecenteschi. A garantire l’esito del processo, è la conferma dei ruoli istituzionali che attribuiscono al Vicariato cittadino il diretto controllo sulle procedure, mentre al Primo Architetto compete l’approvazione finale del dise- gno delle facciate in progetto e l’aderenza ai piani generali approvati. Se strette analogie pongono in relazione le norme adottate per via Dora Grossa con il progetto di riforma (1756) della via e piazza delle Erbe, ora piaz- za Palazzo di Città, questo intervento – analizzato da Costanza Roggero – con- ferma in via definitiva l’importanza riconosciuta alla centralità del luogo su cui prospetta la sede storica del potere municipale. Con l’acquisizione progressiva di lotti posti nel medesimo isolato San Massimo, intorno al municipio sono unitariamente aggregati e ricostruiti non solo i fabbricati destinati alle funzioni amministrative ma anche palazzi da reddito di proprietà comunale. L’in- quadramento del seicentesco fronte lanfranchiano del palazzo del comune, en- tro quinte uniformi di nuovi edifici che creano anche un diretto collegamento con la nuova via Dora Grossa in costruzione, ridefinisce in senso aulico nel cuore del nucleo centrale torinese la sede del potere civico, con il tradizionale mercato attiguo. In un attento disegno di sicuro livello urbano l’Alfieri esercita il controllo dello spazio tracciando precise geometrie visuali entro un misurato dimensionamento razionale di un luogo, già riconosciuto in precedenza, di particolare rilevanza. Vale ricordare che nel 1722, in occasione del matrimonio tra il principe ereditario Carlo Emanuele di Savoia e la principessa Anna Cristina di Sultzbach viene infatti demolito il fatiscente fabbricato detto della “Volta rossa” per consentire la visione diretta tra piazza Castello e il Palazzo comunale, considerati attestamenti bipolari di un cannocchiale ottico tracciato nel sedimentato tessuto del nucleo antico della capitale. Editti, disegni e molteplici fonti documentarie restituiscono l’iter di un
20 PAOLO CORNAGLIA, ELISABETH KIEVEN, COSTANZA ROGGERO cantiere urbano di straordinarie dimensioni e profondità, attraverso la voce congiunta di committenti e progettisti, di azioni giuridico-normative e prov- vedimenti legali, fino alla definitiva validazione regia degli esiti architettonici sempre conformi alle coordinate urbanistiche generali. Il carattere di uniformità del tessuto urbano nelle contrade coinvolte dai provvedimenti di riforma, pur attraverso la molteplicità degli interventi ese- guiti, restituisce con forza l’immagine gerarchizzata della stessa organizzazione del lavoro nell’intero ambito del settore edilizio torinese settecentesco, in cui architetti, ingegneri ed estimatori, a fianco di impresari e maestranze – nume- rose ancora quelle provenienti dal territorio dei laghi e dal Canton Ticino – animano un’azione scenica sapientemente controllata dall’apparato burocrati- co dello stato d’intesa con il comune. Accanto ai nomi delle importanti casate dei committenti – è questo il momento dell’affermazione del nuovo ceto im- prenditoriale nobilitato a seguito delle riforme amedeane – scorrono quelli di un’intera generazione di architetti e misuratori impegnati a diverso titolo nel progetto urbanistico di ristrutturazione della città. Su tali personaggi si atten- de ancora una sistematica e aggiornata analisi storico-critica in grado di preci- sare competenze e profili professionali, anche nello studio delle reciproche re- lazioni; tra questi sono Carlo Emanuele Rocca, Antonio Maria Lampo, Ignazio Bertola, Gian Giacomo Plantery, Michele Barberis, Giovanni Battista Pagano e Antonio Vittorio Gallo, oltre al più celebre Bernardo Vittone. Alla valorizzazione della centralità urbana e al ruolo emblematico che svol- gono le pubbliche piazze della città barocca guarda ancora il Primo Architet- to, sempre d’intesa con gli uffici del Vicariato, nel momento in cui affronta la difficile questione del grave dissesto statico dell’«audace e originale» portico castellamontiano nella Piazza Reale, attuale piazza San Carlo. A partire dal rin- novamento (1753) del palazzo Isnardi di Caraglio, l’Alfieri profila in questo ca- so un abile e complessivo intervento di restauro, compiutamente eseguito in anni successivi, integrando le colonne binate secentesche entro un maschio murario architravato oltre all’inserimento di nuove catene negli archi del sot- toportico, attraverso la soluzione di impegnativi problemi tecnici e formali, acutamente interpretati da Luciano Re nella lucida razionalità esecutiva dimo- strata dal progetto originario. Tra le proposte alfieriane di pregnante significato urbanistico volte a preci- sare il ruolo assoluto della reinterpretazione della centralità urbana settecente- sca, va considerato il duplice progetto alfieriano – non realizzato – di radicale ridefinizione dell’area del Duomo di Torino, discusso tra il 1748 e il 1753, anni che intercorrono tra la fine della guerra di successione austriaca e l’avvio da parte dello stesso architetto dei lavori di trasformazione e ammodernamento del palazzo dei duchi del Chiablese in piazza San Giovanni. Solo menzionati nel presente volume, i progetti si misurano con i precedenti modelli delle grandiose e inattuate proposte juvarriane conseguenti alla firma del concorda- to (1727) tra il re di Sardegna Vittorio Amedeo II e il pontefice Benedetto XIII che sancisce la fine dei difficili rapporti tra Stato sabaudo e Chiesa romana. I disegni dell’Alfieri presenti nella Raccolta di disegni di varie fabriche R.i fatti
ARCHITETTURA E ARCHITETTI DI CORTE IN EUROPA 21 in tempi diversi d’ordine di S.M da me suo gentil’uomo di cam.a e p.o a.o Conte Alfieri MDCCLXIII (conservata presso l’Archivio di Stato di Torino) sviluppano infatti due ipotesi alternative per la collocazione della chiesa in rapporto con la cappella guariniana della Sindone, ma soprattutto prefigurano la creazione di una grande piazza rettangolare nell’addensato tessuto cittadino mediante consistenti opere di demolizione dei fabbricati esistenti. La riflessione del Pri- mo Architetto si focalizza sullo studio della composizione urbana, con appro- fondimento del sistema delle reciproche relazioni spaziali, oltre che sulla desti- nazione funzionale della piazza, destinata ad accogliere un nuovo palazzo vescovile, un seminario e residenze per le gerarchie ecclesiastiche configuran- do, in particolare nel secondo progetto, una sorta di centro direzionale del potere religioso accanto a quello politico. Se Torino capitale si pone dunque negli anni centrali del Settecento come luogo privilegiato di sperimentazione e innovazione urbana oltre che architet- tonica, si riconoscono numerosi e paralleli percorsi di confronto e penetrazio- ne dei modelli nell’intero territorio dello Stato. In una scenografia complessiva che considera il Piemonte sabaudo nell’estensione raggiunta in seguito agli ac- cordi stabiliti dal trattato di Utrecht del 1713, le Alpi diventano la grande fron- tiera stabile ad occidente, mentre verso la Lombardia gli accordi vedono l’an- nessione del Monferrato e di Casale, della Lomellina, del Vigevanasco e Ales- sandrino: una fascia territoriale continua che affianca e rafforza il ruolo di avamposto del Vercellese, cui si integrano, con il trattato di Vienna (1738) il Novarese e la città di Tortona. In questo contesto politico, in particolare nei cosiddetti “territori di nuovo acquisto”, assume un ruolo determinante la considerazione del rapporto che si stabilisce tra le direttive e gli orientamenti del potere centrale e le consolidate matrici proprie delle diverse culture locali. Protagonisti sono ancora i commit- tenti, accanto agli architetti e alle maestranze, a fianco dello stesso Alfieri. Ad Alessandria esemplare il riferimento alle complesse vicende costruttive del maestoso palazzo che la nobile famiglia filosabauda Ghilini innalza, affidando- ne il progetto al giovane Alfieri; nell’attento percorso di ricerca di Annalisa Dameri è ben evidenziato il ruolo di “tirocinio” che il cantiere del palazzo, in- sieme a quello della stessa cittadella, «svolge per un’intera generazione di ar- chitetti e maestranze» alessandrini, che negli anni seguenti seguiranno l’Alfieri nella capitale, partecipando ai lavori nella “zona di comando”, ossia al Teatro Regio e Regie Segreterie di Stato; tra questi ritroviamo i nomi di Domenico Caselli, Francesco Trolli e Giovanni Battista Gianotti. Il riferimento al territorio del Monferrato e alla città di Casale rimanda ai rapporti con l’ambito culturale e professionale che ruota intorno all’interes- sante figura – analizzata da Chiara Devoti e Antonella Perin – di Francesco Ottavio Magnocavalli conte di Varengo, nobile architetto “dilettante” ed espo- nente di spicco nel governo cittadino, impegnato nell’architettura ecclesiastica sui modi che oscillano tra soluzioni tardobarocche e aperture al Classicismo. I rapporti con l’Alfieri riguardano, oltre la collaborazione nel palazzo Magnoca- valli, il tema a lungo discusso della nuova cappella di patronato comunale nella
22 PAOLO CORNAGLIA, ELISABETH KIEVEN, COSTANZA ROGGERO cattedrale casalese di Sant’Evasio, prima delle scelte esecutive operate (1764) dall’architetto Luigi Michele Barberis, sotto la supervisione dello stesso Alfieri. Frequenti nel profilo biografico e professionale dell’architetto astigiano so- no peraltro gli incarichi relativi a edifici religiosi che gli vengono conferiti da parte di committenze diverse. Alle opere giovanili di un Alfieri venticinquenne appartengono gli interventi nel convento delle monache cistercensi di Sant’An- na e Santo Spirito, ora sede dell’Archivio di Stato nel quartiere di San Martino ad Asti. Dagli studi consolidati, cui si aggiunge la citazione di una lunga rela- zione di Alfieri e del capomastro Avanzino accanto all’interpretazione critica dei molteplici disegni, si giunge alla conferma dell’attribuzione dei tre elementi «campanile, coro e cappella di Santo Spirito», mentre a latere emergono sug- gestioni e confronti interpretativi proposti da Maria Carla Visconti di fronte ai dati suggeriti dalla complessa stratificazione della stessa fabbrica. Un complesso iter progettuale, documentato dal copioso corpus di disegni puntualmente analizzati da Alberto Bologna, Mauro Bonetti e Gabriele Neri nell’attenta lettura delle quattro proposte progettuali delineate e maturate in corso d’opera, segna la vicenda costruttiva (1755-1764) della celebre chiesa par- rocchiale di Carignano, dedicata ai Santi Giovanni e Remigio. Anche in questo caso il dibattito che si apre sulla scelta di un nuovo orientamento del fabbrica- to nell’isolato di San Giovanni, al centro dell’abitato, documenta a metà Sette- cento il divergere delle posizioni tra il Consiglio cittadino, committente dell’o- pera, e il principe Luigi Savoia-Carignano. L’interessante soluzione urbanisti- ca alfieriana interpreta il desiderio dei notabili cittadini di «tradurre in un’im- magine urbana nuovi equilibri: al polo costituito dal nesso castello-chiesa si sa- rebbe sostituito quello chiesa-piazza-palazzo del Comune». Con la complessità dell’attiguo cantiere della reggia di Venaria Reale e in di- retta collaborazione con le maestranze presenti, tra cui l’architetto Giovanni Giacinto Baijs, si misura la ricostruzione da parte di Benedetto Alfieri della chiesa parrocchiale castellamontiana al centro del borgo, dopo il crollo rovino- so (1753) della navata, che risparmia parte del coro e sacrestia e la stessa faccia- ta sulla piazza. Disegni inediti, qui proposti da Maria Grazia Vinardi, attestano il percorso delle scelte compositive, mentre emergono nello studio interessanti confronti sui materiali e sui tecnici coinvolti, attestando «l’esperta capacità di Alfieri e dei suoi collaboratori di rapportarsi con spazi predefiniti» e con nuo- ve soluzioni progettuali di forte solidità, riconoscibili anche nella struttura del nuovo campanile di forma ottagona interna con semplice scala. L’architettura di una torre campanaria vede impegnato ancora il Primo Ar- chitetto regio, quando gli viene affidato (1753) dai «Fabbricieri della Veneran- da Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio», esponenti della nobiltà novarese, il compito di portare a compimento la struttura già prevista da Pellegrino Tibal- di nel cinquecentesco progetto originario, ancora incompiuto. Affrontata da Marika Mangosio, Caterina Mele e Paolo Piantanida, l’attenta ricostruzione delle fasi del cantiere, diretto dall’Alfieri, ma controllato sul luogo dal suo col- laboratore Francesco Martinez e quindi da Luigi Michele Barberis accanto al capomastro Paolo Falcone, argomenta in dettaglio l’esistenza di una parte se-
ARCHITETTURA E ARCHITETTI DI CORTE IN EUROPA 23 centesca in elevazione del basamento del campanile antecedente l’intervento alfieriano, che si pone come forte condizionamento materico e strutturale per le stesse scelte costruttive a partire dalla conformazione dello zoccolo, di un manufatto della straordinaria altezza di novantadue metri. Emerge in questo caso l’elevato grado di specializzazione tecnologica e la padronanza del mestie- re, anche nel riferimento ai fornitori dei materiali lapidei e scalpellini in gran parte provenienti dalla zona dei laghi lombardi, mentre l’interpretazione delle tecniche costruttive adottate rende ragione della solidità strutturale. Il tema della valorizzazione della cattedrale nella città, non solo attraverso la creazione di un maestoso prospetto «monumentale e classicheggiante» ma con il suo inserimento entro un moderno piano urbanistico di razionalizzazione del tessuto urbano, è quanto discute ancora il progetto alfieriano per il Sant’Eusebio a Vercelli. La «generale Idea» espressa dal fondamentale disegno elaborato (1760) dallo studio torinese del Primo architetto, secondo l’attenta analisi e interpretazione critica di Cecilia Castiglioni, suggerisce una visione unitaria dello spazio urbano aperta a modelli internazionali. In una zona peri- ferica in prossimità dei bastioni la prevista rete di strade e ampi viali alberati di collegamento tra la grande piazza e i fulcri delle rotonde, propone una «tra- ma coerente» in grado di dar vita ad una nuova area urbana, in cui trovano la loro collocazione funzionale le diverse architetture dei preesistenti complessi del seminario, della chiesa di Sant’Andrea e dello stesso ospedale. Alla realtà di Ginevra, città dichiaratamente inserita negli anni centrali del Settecento in una dimensione internazionale animata dal vivace intreccio tra «architettura, politica e potere» guarda infine la suggestiva ricostruzione sto- riografica e interpretativa, qui offerta da Edoardo Piccoli del controverso di- battito sull’attribuzione alfieriana del progetto di completamento (1748-1756) del tempio di Saint Pierre. Il viaggio oltre le Alpi del Primo architetto sabaudo, la stretta corrispondenza intrattenuta con Jean-Louis Calandrini e il suo milieu culturale, la serie dei disegni relativi alle due proposte progettuali redatte a Torino e inviate ai suoi diretti interlocutori, ma soprattutto la sapiente declina- zione personale dei modi architettonici e tecnici rispetto al modello “all’anti- ca” proposto, consente di riconoscere la mano dell’architetto «per il modo raf- finato e autorevole con cui sa rispondere a un tema dato», declinandolo sia nel disegno del portico sia nel “virtuosistico” completamento dell’interno gotico, nella consapevole e simultanea attenzione all’antico e al moderno. Disegno, rappresentazione e rilievo Chiude la raccolta degli atti una sezione che riunisce i contributi dell’area del disegno all’interpretazione dell’opera alfieriana. In occasione del convegno si è pensato di valorizzare alcune competenze presenti presso il Politecnico di Torino accettando la proposta di una lettura attraverso il criterio delle tecni- che di rappresentazione. In primo luogo si pone il “modello immateriale” in 3D realizzato da Anna Marotta e Mauro Fassino. Forte era stata l’attenzione nel Settecento alla diffusione – per mezzo di incisioni – del volto della sala: è
24 PAOLO CORNAGLIA, ELISABETH KIEVEN, COSTANZA ROGGERO
quindi sembrato interessante corredare le analisi storico-critiche offerte in al-
tra sessione con una ricostruzione virtuale che si propone come ulteriore stru-
mento – ancora implementabile – per leggere e comprendere l’antica fabbrica
oggi distrutta e quindi maggiormente bisognosa di tutti gli strumenti per rico-
struirne il volto. Due altri contributi si occupano invece di piazze e porticati:
quello di Roberta Spallone in merito alla piazza Palazzo di Città e quello di
Pia Davico principalmente in merito ai portici non realizzati della piazza del
Duomo e a quelli, eseguiti, della piazza Palazzo di Città. Nel primo si analizza
l’uso effettivo della piazza nel Settecento con il posizionamento dei banchi
mercatali analizzando i rapporti fra il costruito e le strutture di vendita effime-
re, sulla base delle letture già proposte da Mario Passanti. Emergono così rico-
struzioni tridimensionali che ripropongono lo spazio oltre alla sua dimensione
aulica oggi visibile ma nel cuore del suo uso concreto. Nel secondo si pone
l’attenzione al ruolo giocato dai portici in ogni “brano di città” progettato da
Alfieri, ovvero la loro articolazione come «soluzione estetica in grado di risol-
vere complesse problematiche distributive». Nei due progetti per il Duomo
Nuovo e la sua piazza – analizzati attraverso l’enfasi su sulla lettura degli spazi,
dei ritmi e delle assialità – i portici assumono il ruolo di connettere elementi
diversi (disassamenti, allineamenti assenti), ma al contempo di garantire per-
meabilità tra spazi e inedite viste diagonali. Anche nella piazza Palazzo di Città
i portici celano i punti critici di connessione con la trama viaria preesistente,
sottolineando nuovamente la capacità di Alfieri nel gestire la complessità degli
spazi urbani nella zona più antica di Torino.
NOTE
1
Pur nella comune discussione e impostazione, a Paolo Cornaglia si devono la sezione riguardante
Alfieri architetto per la corte e quella relativa a Disegno, rappresentazione e rilievo, a Elisabeth Kieven
si deve la sezione riguardante Architettura e architetti di corte in Europa tra Tardobarocco, Rococò e
Classicismo, a Costanza Roggero quella su Alfieri architetto della città, dei nobili, del clero.
2
BELLINI 1978.
3
Benedetto Alfieri 1992.
4
RABREAU 2008, p. 92; Correspondance de madame de Pompadour 1878, p. 34.
5
Correspondance de madame de Pompadour 1878, p. 36.
6
CORNAGLIA 2011.
7
ERIKSEN 1974, pp. 233-250.
8
DARDANELLO 2005.Puoi anche leggere