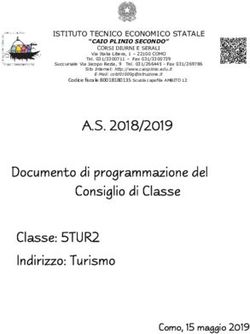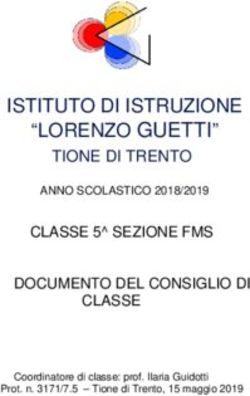OSSERVAZIONE DIRETTA DEL COMPORTAMENTO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
First published as :
BEAUGRAND, J.P. (1989). Observazione diretta del comportamento. En: La ricerca scientifica in psicologia, a cura di
Robert, Roma: Biblioteca Universale Laterza, pp. 187-243.
OSSERVAZIONE DIRETTA DEL COMPORTAMENTO
Jacques P. Beaugrand
Da qualche anno, l'osservazione diretta del comportamento, talvolta chiamata arbitrariamente etologica, è
ridiventata uno strumento d'uso corrente in psicologia, particolarmente nei seguenti settori: lo sviluppo cognitivo e
sociale, la valutazione psicopatologica nonché l'apprendimento animale, l'interesse anche per gli altri tipi di
comportamento adottati durante l'acquisizione di una risposta strumentale determinata. L'osservazione diretta non fu
inventata dagli etologi, poiché è stata fondamentale nello sviluppo della psicologia come scienza. Prima della comparsa
dei laboratori americani, la psicologia comparata e sperimentale era praticata esclusivamente sul campo e procedeva,
molto spesso, per osservazione diretta: per esempio, Watson, il padre stesso del comportamentismo americano,
pubblicò nel 1908 quelli che oggi sono chiamati etogrammi delle sterne (Sterna stalidus e Sterna fuscata) nel loro
habitat della Florida. Tuttavia, quando la giovane disciplina psicologica cominciò a preoccuparsi innanzitutto
dell'oggettività e della fedeltà delle sue misure anziché della loro ricchezza e della loro validità esterna, l'osservazione
diretta fu trascurata. Fu sostituita dall'osservazione strumentale o indiretta (grazie a strumenti, questionari, test). Dopo
brevissimo tempo, meno dell'8% dei lavori pubblicati in psicologia dell'età evolutiva e in psicologia sociale si rifaceva
ancora all'osservazione diretta (Bickman 1977).
Lo sviluppo recente dell'etologia, la branca della zoologia che si basa sull'osservazione diretta del
comportamento, sembra aver ridato fiducia ai ricercatori in psicologia per quanto concerne la pertinenza di questa
modalità di comprensione dei comportamenti oggetto di studio. Esistono alcuni esempi recenti dell'applicazione
dell'osservazione diretta al comportamento umano in McGrew (1972), Sackett (1978) e Blurton Jones (1972). Altre
utilizzazioni sono state fatte in etologia circa il comportamento degli animali domestici, per migliorare la produzione
alimentare industriale e il benessere degli animali allevati dall'uomo (Danczer e Mormede 1979; Kiley-Worthington
1977; Zayan 1981). A tale approccio etologico aderiscono sempre più gli psicologi, come si vedrà nel presente
capitolo.
L'obiettivo è di familiarizzare il lettore con la difficoltà e le tecniche relative all'osservazione diretta del
comportamento. Ciò può essere definito come allenare la produzione di osservazioni del comportamento, senza l'aiuto
di strumenti che traducono in modo fisico gli avvenimenti. Una bilancia, un termometro, una leva, un elettrocardiografo oanche un questionario o un calcolatore programmato per il riconoscimento di pattern, sono strumenti capaci di rendere
la registrazione dei risultati meno discutibile e meno soggetta alle fluttuazioni introdotte da differenze percettive
concettuali e tecniche, che possono esistere negli osservatori umani. Ora, la tecnologia e le conoscenze teoriche non
permettono sempre di mettere a punto tali strumenti. La ricerca deve allora progredire attraverso l'osservazione dirètta
da parte di osservatori, i quali registrano direttamente le informazioni fornite dai loro sensi e interpretate in riferimento a
concetti teorici. L'osservazione diretta del comportamento consiste nell'identificare, nominare, confrontare e infine de-
scrivere il comportamento stesso. Dominare le tecniche di campionamento è certo importante. Tuttavia, l'osservazione
diretta del comportamento non si riduce a queste tecniche; la loro applicazione rigorosa resta secondaria se le unità di
osservazione e i campi di esplorazione non sono dall'inizio accuratamente e chiaramente definiti, in modo da costituire
delle regolarità che l'osservatore può riconoscere fedelmente.
ASSENZA DI UNA TERMINOLOGIA UNIVOCA
L'assenza di una terminologia univoca genera tre tipi di confusione quando si parla dell'osservazione diretta del
comportamento. Il primo, oppone tra loro metodo sperimentale e accesso ai fenomeni per osservazione diretta. Ora,
come si è visto nel capitolo quarto, è possibile e anche frequente che l'osservazione diretta intervenga nel quadro della
manipolazione di una o più variabili indipendenti. Per esempio, per determinare gli effetti della densità di popolazione sul
comportamento sociale, si possono creare gruppi equivalenti di individui, messi in luoghi chiusi le cui rispettive
dimensioni sono manipolate sperimentalmente. Il piano di ricerca stabilisce di volta in volta il livello della variabile
indipendente e le modalità d'osservazione. Le differenti unità comportamentali da analizzare costituiscono altrettante
variabili dipendenti. Questa situazione differisce dalle situazioni sperimentali più comuni, nelle quali poche variabili
dipendenti sono registrate. Essa caratterizza piuttosto lo studio delle interazioni sociali (Cairns 1979).
Si è portati ad assimilare le ricerche che ricorrono all'osservazione diretta a quelle che procedono senza ipotesi.
Innanzitutto, vi è il ricorso all'osservazione diretta in una ricerca sperimentale, in cui le ipotesi sono almeno implicite. In
secondo luogo, è possibile l'enunciazione di ipotesi nel quadro di una ricerca non sperimentale, basata sull'osservazione
diretta dei comportamenti. Queste ipotesi possono basarsi sugli effetti di variazioni che si producono naturalmente, sia
nell'ambiente, sia negli individui. Raccogliendo sistematicamente le osservazioni relative all'una e all'altra delle condizioni,
o anché selezionando le osservazioni concomitanti all'una e all'altra, per confrontarle in seguito, si realizzano quelle che
Tinbergen (1953) chiamava esperienze naturali. Le variabili climatiche e stagionali, i tipi di ambienti, le caratteristiche
personali degli individui e altre variabili collegate ai soggetti, possono essere selezionate per confrontarle con
comportamenti concomitanti (caso degli studi ex post facto, capitolo secondo). In terzo luogo, le ipotesi poste dairicercatori possono condurre anche all'esistenza di regolarità nei fatti stessi o tra i fatti. Per esempio, una teoria più o
meno sviluppata può predire l'esistenza di un certo comportamento nel repertorio di una specie non ancora studiata.
L'osservazione diretta può fornire dati verificando l'esistenza di una certa regolarità.
Infine, si confonde spesso l'osservazione diretta del comportamento con l'osservazione naturalistica o etologica.
Come si è già visto nel capitolo quarto, è possibile applicare l'osservazione diretta al di fuori di ogni preoccupazione
etologica. Rifacendosi all'osservazione diretta, l'osservazione naturalistica consiste nello studiare, con meno interferenze
possibili, il comportamento: la preoccupazione essenziale è allora di rispettare le condizioni dell'ambiente fisico e sociale
che hanno un significato biologico e adattativo per l'organismo.
UN CONCETTO MOLTO GENERALE: IL COMPORTAMENTO
Osservare il comportamento in modo diretto richiede innanzitutto una definizione di comportamento. Questa
definizione riguarda tutta l'attività caratteristica di un organismo vivente, con un sistema nervoso individuale, che provoca
modificazioni spazio-temporali osservabili. Il sistema nervoso in questione può essere molto semplice, come quello dei
protozoi. L d'uso comune definire «comportamenti» anche le attività molto particolari, quali la scarica di organi elettrici,
la secrezione dei feromoni e il cambio di colore (per esempio, il fatto di arrossire nell'uomo). II concetto di compor-
tamento è dunque estremamente vasto. Esso ingloba talvolta sottili livelli di comportamento, come quello dell'attività dei
neuroni che controllano le contrazioni muscolari e la percezione dei colori, e talvolta livelli meno sottili come quelli che
riguardano attività di interi gruppi di individui (per esempio, le migrazioni).
Si può studiare il comportamento in rapporto a diversi livelli di organizzazione, i quali vanno dal più molecolare
al più molare. La gamma comprende: le basi neurologiche, fisiologiche e anatomiche; le componenti degli schemi motori
(lo schema motorio è considerato come un'unità globale); gli atti individuali che sono coordinazioni motorie causate da
più schemi motori; le interazioni individuali con l'ambiente fisico e sociale; le interazioni sociali tra due e più individui; il
comportamento di gruppi interi (per esempio, l'organizzazione gerarchica); i comportamenti di intere popolazioni e di
specie (per esempio, le strategie riproduttive di una specie); e i comportamenti di gruppi di specie, di famiglie e di generi
(per esempio, la riproduzione degli insetti che hanno una organizzazione sociale).CRITERI DI DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE
Il comportamento di un organismo in interazione con il suo ambiente si inserisce nel quadro di un sistema molto
complesso di eventi. II ricercatore deve innanzitutto descrivere le proprietà più importanti sulle quali si basa l'analisi delle
unità comportamentali. Osservare è astrarre (Hinde 1970), ma è anche classificare. Bisogna distinguere la classificazione
fatta al momento dell'osservazione da quella fatta dopo, quando il ricercatore, a partire dalle osservazioni di base,
ordina i dati pertinenti e comparabili con quelli implicati nelle sue ipotesi di ricerca. In questo secondo caso, il
ricercatore
ricorre a classi più globali, più interpretative o più teoriche che possono essere definite a posteriori; la
classificazione è allora provvisoria e modificabile. Se è invece determinata a priori, è irrimedia bilmente definitiva, a
meno che il ricercatore non abbia conservato gli eventi negli archivi magnetoscopici, cinematografici o altri, che
permettano di rivedere e di ridescrivere il fenomeno. La classifica zione a priori può essere fatta sulla base di criteri
concreti o descrit
tivi, oppure di criteri teorici o interpretativi.
Criteri concreti
I criteri concreti riguardano le proprietà formali, topologiche o cinetiche dei comportamenti, o anche i loro effetti
fisici sull'ambiente.
Classificazione secondo la forma. Un'azione o una postura possono essere descritti a partire dalla loro forma
o dalle loro caratteristiche plastiche o cinetiche. Le caratteristiche formali sono identificabili a partire dalle contrazioni
muscolari implicate, e dalla posizione di certi membri e di certe strutture anatomiche visive o uditive. Per esempio, si può
riconoscere una melodia dalla sua struttura sonora. La maggior parte degli atteggiamenti, dei gesti, degli schemi motori,
delle espressioni facciali o delle reazioni specifiche possono essere descritte a partire da tali criteri. Di solito si fa
riferimento all'organizzazione o alla struttura plastica. In effetti, non è sempre necessario enumerare tutti i muscoli o tutte
le strutture anatomiche implicate, né il loro stato di contrazione più o meno parziale a meno che lo studio non si interessi
specificamente a questi dettagli.
L'uso di un criterio formale può essere molto laborioso se il comportamento è complesso e rapido. La
descrizione approfondita del comportamento è inutile nella maggior parte dei casi, poiché richiede la costruzione di unità
comportamentali più globali e più facilmente intellegibili. Questo livello di sintesi dipenderà chiaramente dagli interessi delricercatore e dalle domande che si pone. Se può essere difficile applicare criteri formali alla registrazione stessa del
comportamento, questi criteri sono tuttavia essenziali al riconoscimento visivo dei modelli di base che servono a
costruire ulteriormente delle unità più globali e più facili da annotare.
Ogni modello di comportamento può essere caratterizzato da diverse dimensioni, che Drummond (1981) ha
identificato in modo relativamente arbitrario: la localizzazione nello spazio, l'orientamento, la topografia concreta e le
proprietà intrinseche. L'autore suggerisce di esaminare innanzitutto questi quattro campi per coglierne regolarità formali.
Le situazioni statiche, o i cambiamenti sopraggiunti in uno o più di questi settori forniscono i criteri di riconoscimento dei
modelli di comportamento descritti, nominati e definiti di seguito.
Innanzitutto, la localizzazione dello spazio si riferisce al luogo in cui si trova l'individuo, verso il quale si sposta o
per il quale passa la sua traiettoria. Questo luogo è definito in rapporto agli elementi dell'ambiente; perciò caricare,
avvicinare, arrampicarsi su un albero e covare, si riferiscono a un luogo. I primi tre casi implicano cambiamenti di luogo
più o meno rapidi; l'ultimo implica invece un luogo fisso in rapporto al nido o al suo contenuto.
In secondo luogo, l'orientamento concerne le posizioni delle strutture dell'individuo, in relazione con altre
strutture, organiche e non, dell'ambiente. Può trattarsi di indirizzare le strutture verso oggetti (per esempio, puntare o
guardare). Così, nel pesce Lebistes reticulatus, due schemi motori formalmente identici possono essere classificati
diversamente secondo il loro orientamento. Il primo è effettuato parallelamente alla femmina (galoppo parallelo e
nuotata laterale parallela), mentre il secondo è compiuto direttamente davanti a essa, in modo da sbarrarle la strada
(sbarramento).
Quindi, la topografia tridimensionale dell'individuo è una fonte importante di regolarità che rende possibile la
caratterizzazione e il riconoscimento degli schemi motori. Pertanto, possono essere colte regolarità dei movimenti di
certe membra (gambe o ali) o di certe strutture (capelli, ciuffi, piume, code o sopracciglia), così come la loro
configurazione statica (gonfiamento di parti anatomiche, piloerezione, spiegamento di ali o sfoltimento di sopracciglia).
Le regolarità sono annotate in riferimento a queste strutture individuali o ad altre strutture.
Infine, molti organismi sono in grado di modificare alcune proprietà intrinseche del loro corpo e della loro
epidermide. Per esempio, certi animali possono cambiare il colore, la temperatura; la loro capacità di riflettere la luce
incidente può variare. Poiché questi stati sono osservabili, servono a riconoscere le componenti essenziali dei modelli di
comportamento.
Classificazione secondo gli effetti. Si può del resto procedere alla descrizione, partendo dagli effetti fisici del
comportamento, i quali colpiscono gli oggetti circostanti e i congeneri. Si tiene pure conto delle conseguenzespazio-temporali prodotte. Molti comportamenti hanno effetti diretti sull'ambiente: spostano, deformano, sezionano
consumano, distruggono o costruiscono certe componenti dell'ambiente. I cambiamenti fisici d'origine meccanica,
chimica o elettronica fanno parte di questa categoria, ma non le risposte dei congeneri. Tuttavia, l'effetto fisico di un
comportamento rappresenta solo una dimensione; intervengono anche, per esempio, le espulsioni, i depositi, le
emissioni di suoni, odori e veleni.
Più sinteticamente, questo modo di descrivete a partire dagli effetti fisici, presenta parecchi vantaggi. Una sola
espressione riassume in effetti una descrizione che altrimenti renderebbe necessaria la descrizione di molte contrazioni
muscolari sequenziali. Quindi, un solo termine può designare molti tipi di azioni o di schemi motori, poiché questi
possono essere descritti a partire dalle loro conseguenze. Si può costruire una linguistica gerarchizzata del com-
portamento. Per esempio, aggredire può raggruppare molte azioni: correre, volare, nuotare, dirigersi verso un
congenere o spostarsi rapidamente verso di esso per poi far seguire questo comportamento da un morso o da un
pugno. Si possono anche definire le unità comportamentali obiettivamente, in termini che implicano solo i cambiamenti
nell'ambiente fisico. Così, mangiare o copulare hanno conseguenze immediate che è ben difficile contestare. Per
esempio, mangiare comporta il fatto di portare gli alimenti alla bocca e gli alimenti scompaiono. Questa definizione non
implica semplicemente una descrizione di ciò che fa l'individuo, quali che siano i meccanismi di controllo sottostanti e i
mezzi, locomotori o altri, che provocano questi effetti. Infine, descrivere partendo dalle conseguenze oggettive degli atti
permette di includere, nella descrizione, certe relazioni tra l'individuo iniziatore e il contesto spazio-temporale che implica
luoghi, oggetti, congeneri e altri comportamenti anteriori o posteriori. È più facile, in questo modo, stabilire delle
regolarità.
Al contrario, questo tipo di descrizione presenta qualche svantaggio. Prima di tutto la perdita dei dettagli. In
effetti, se le situazioni e gli schemi motori sono descritti a un livello relativamente molare, l'informazione sulle particolarità
più sottili di queste stesse unità è sacrificata. In secondo luogo, c'è una perdita di informazioni concernenti tutto quanto è
consecutivo al comportamento, e che può far parte di una catena di posizioni e di schemi motori ed esserne la
conseguenza. Per esempio, quando un bambino si avvicina rapidamente a un altro, si tratta di un attacco diretto verso
quest'ultimo o di una fuga in risposta a un terzo individuo? Infine, esiste un rischio grave di eccessiva interpretazione. In
effetti, la descrizione del comportamento a partire dai suoi effetti immediati, conduce facilmente a una descrizione delle
conseguenze adattative o della funzione del comportamento.
Criteri teorici e astrattiI criteri teorici e astratti sono interpretazioni di indici concreti con l'aiuto di postulati, di ipotesi o anche di teorie.
Questi criteri sfociano dunque, per esempio negli etologi, in classificazioni causali e funzionali e teleonomiche. Sotto
questa stessa rubrica, si possono includere le classificazioni che si fondano sulle intenzioni concesse agli attori, o anche
una interpretazione psicoanalitica; tuttavia, queste classificazioni non scientifiche non saranno qui trattate.
Classificazione secondo le cause. I comportamenti che hanno le stesse cause sono raggruppati sotto la stessa
etichetta secondo i fattori che sembrano responsabili della loro apparizione. Questi fattori comprendono tanto i
meccanismi e i processi fisiologici e neurologici comuni, quanto gli stimoli esogeni comuni. Così, quei comportamenti che
variano di frequenza o intensità in relazione ai cambiamenti ormonali sessuali, possono essere raggruppati nella categoria
dei comportamenti sessuali, mentre quelli indotti dalla presenza dei bambini possono essere raggruppati nella categoria
dei comportamenti materni. Allo stesso modo, tutte le attività influenzate o indotte dalla presenza di un maschio rivale,
possono essere raggruppate nella categoria dei comportamenti agonistici. Questo modo di classificare è essenziale per
la comprensione e la spiegazione del comportamento. Sebbene questa classificazione sia spesso molto pratica, essa
solleva in compenso problemi concernenti l'analisi causale etologica, tra cui quello di dimostrare prima di tutto che
l'identificazione delle cause è valida.
Classificazione secondo la funzione. I comportamenti possono essere raggruppati secondo la loro presunta
funzione comune. Per esempio, i comportamenti diretti a ottenere la nutrizione sono raggruppati nella categoria dei
comportamenti alimentari, mentre quelli che portano in un tempo più o meno lungo alla riproduzione individuale, sono
raggruppati nella categoria dei comportamenti riproduttivi. I comportamenti spigamici hanno la funzione di sincronizzare
due partner sessuali. Invece, quelli che conducono al consolidamento di relazioni di dominanza e di sottomissione
gerarchica appartengono alla categoria dei comportamenti agonistici.
In alcuni casi, è possibile stabilire sperimentalmente la funzione di un comportamento. Pruscha e Maurus (1975)
sono arrivati a classificare i segnali sociali (crisi e posture) trasmessi dalla scimmia scoiattolo (Saimiri sciureus), a partire
dai loro effetti immediati sui comportamenti degli individui di un gruppo. I segnali provengono da individui di cui sono
state stimolate, attraverso la telemetria, certe zone del cervello responsabili della loro emissione. Tuttavia, in assenza di
dimostrazioni sperimentali, classificare il comportamento a partire dalla sua funzione presunta comporta una buona parte
di speculazione.In pratica, quando si considera anche una stessa specie animale, le classificazioni causali e funzionali si
sovrappongono considerevolmente. Ciò è normale in una certa misura, poiché dal punto di vista evoluzionista, i
meccanismi sottostanti al comportamento adattativo sono molto meno complessi quando le attività legate sul piano
funzionale hanno le stesse cause rispetto a quando ciascuna delle attività ha cause differenti (Hinde 1970). È così che
alcune categorie funzionali, come quelle dei comportamenti sessuali e riproduttivi, designano categorie causali. Nella
maggior parte dei casi, questi modi di classificazione sono pure riconoscibili dal fatto che i comportamenti hanno gli
stessi effetti fisici sull'ambiente.
SCELTA E DEFINIZIONE DELLE UNITÀ
Prima di intraprendere l'osservazione stessa, un'attenzione speciale deve essere diretta alle scelte delle unità di
comportamento da riconoscere e da notare, così come alla loro definizione.
Scelta delle unità
Nella scelta delle unità devono essere rispettate sei condizioni in modo che tali unità possano essere riconosciute
secondo criteri concreti o astratti, o secondo i due tipi di criteri contemporaneamente. In primo luogo, le unità devono
essere discrete ed esclusive. Tutti i comportamenti appartenenti a una di esse o a una categoria, devono avere certe
proprietà che li distinguano molto nettamente da quelli appartenenti ad altre unità. In secondo luogo, ogni unità deve
costituire una categoria omogenea. Creando una unità, il ricercatore deve avere buone ragioni per credere che tutti i
comportamenti che vi si presentano siano equivalenti sul piano della loro forma, dei loro effetti immediati, delle loro
cause o delle loro funzioni. Se alcuni comportamenti non omogenei sono inclusi in una categoria, è molto probabile che,
al momento dell'analisi, le regolarità saranno assenti o artificiali. In terzo luogo, sarà meglio moltiplicare le unità anziché
fonderle. Se due comportamenti sono estremamente simili sul piano formale, ma esiste almeno un criterio oggettivo e
fedele per distinguerli, è preferibile associarli a unità differenti. In effetti un'analisi potrà rivelare, dopo la compilazione dei
dati, che queste due unità sono realmente differenti. Altrimenti il ricercatore potrà anche raggrupparle nella stessa unità.
Se tutti i comportamenti, al contrario, sono stati assegnati a una stessa categoria, non sarà più possibile scinderle in
sottocategorie. Questo principio si applica particolarmente in una situazione esploratrice, nella quale il ricercatore non ha
ipotesi precise da provare. Egli deve allora permettere l'emergenza di regolarità, nel momento in cui procede all'esame
dei suoi dati (Kirk 1968). Quando, al contrario, verifica ipotesi precise, non è necessario che faccia troppe osservazioni
inutili la cui analisi potrebbe solo, nel migliore dei casi, fornire altre ipotesi da verificare.In quarto luogo, bisogna evitare di utilizzare, nello stadio d'osservazione, classificazioni astratte. Queste sono in
effetti suggerite da una teoria data e il ricercatore deve riservarsi la possibilità di reinterpretare le sue osservazioni di
base alla luce di altre teorie. Tuttavia, gli stessi nomi delle categorie hanno una connotazione causale o funzionale. Così,
parlare di un «nuoto di minaccia» con riferimento a un pesce, suggerisce una funzione, mentre parlare di «ondulazione
laterale» designa lo stesso schema motorio, ma senza una connotazione funzionale. Che una espressione della faccia sia
qualificata come «sorriso», è accettabile quando si tratta di descrivere il comportamento di ragazzi, anche se il termine
«sorriso» ha una connotazione funzionale. A1 contrario, non converrà applicare lo stesso termine a un'altra specie di
primati, tanto che la funzione dell'espressione facciale consistente nel mostrare i denti in silenzio non sarà riconosciuta sul
piano funzionale come analoga ed equivalente al sorriso umano. Inoltre bisogna conoscere bene preliminarmente la
funzione del sorridere negli uomini. Il ricercatore deve dunque sforzarsi di impiegare solo termini oggettivi, rispondenti il
più possibile alle configurazioni, alle forme, o agli effetti fisici dei modelli di base o delle posture implicate. In quinto
luogo, è necessario definire, precisare e giustificare sempre ogni unità comportamentale. Non bisogna contare sul fatto
che tutti i ricercatori di uno stesso campo accettino ciò che uno di loro intende, per esempio, per nuoto laterale o per
carica: quando si tratta di un attacco e quando di un avvicinamento? Torneremo più avanti sul problema della definizione
delle unità.
Infine, il ricercatore deve osservare un numero limitato di unità, che dipendono dagli obiettivi della ricerca. Non
è facile lavorare con un numero elevato di loro, anche se gli apparecchi facilitano la codificazione e la registrazione degli
avvenimenti, e anche se 1'analisi dei dati è effettuata con l'aiuto di un calcolatore. È estremamente difficile osservare e
classificare sistematicamente il comportamento, in modo continuo e durante lunghi periodi, se il numero delle unità è
molto elevato. L'addestramento è allora molto lungo, i tempi di reazione sono elevati, gli errori frequenti e l'attenzione
centrata più sull'aspetto tecnico che sui fatti da osservare. Nel momento in cui il ricercatore procede alla riduzione e
all'analisi dei dati, le osservazioni devono essere raggruppate in unità più globali, da costituire a posteriori, se vuole
ricavare in esse qualche regolarità. In alcuni casi, può essere più efficace raggrupparle al momento stesso
dell'osservazione. D'altra parte, più il numero delle unità ottenute è elevato, più lo è (relazione esponenziale) il numero
delle osservazioni richieste per rispettare i postulati di base di certe prove statistiche. In compenso, se le unità sono
troppo poco nume rose o troppo vaghe, è molto probabile che i risultati siano grossolani.
Generalmente, bisogna prendere in considerazione solo le unità direttamente associate agli obiettivi della ricerca.
A conti fatti, è più efficace mettere in piedi una nuova ricerca destinata a classificare sistematicamente le unità trascurate
e ipoteticamente pertinenti, che analizzare i dati raccolti essenzialmente per un altro scopo. Gli archivi dei laboratori di
tutto il mondo traboccano di dati ammassati inutilmente. Quando questi sono analizzati dopo alcuni anni, il ricercatore hadimenticato le condizioni spesso poco rigorose nelle quali sono stati raccolti e ha la tendenza a sopravvalutare la loro portata.
Definizione delle unità
Una volta scelta, una unità comportamentale deve essere definita in modo da assicurare la fedeltà sia per
l'osservatore sia tra gli osservatori. I comportamenti devono essere definiti chiaramente, con l'aiuto di criteri precisi. La
definizione di uno schema di comportamento trascura, nella sua formulazione, una gran parte dell'informazione
disponibile a partire da una descrizione. Essa si limita a criteri necessari e sufficienti perché un avvenimento sia
riconosciuto e classificato in uno schema. Per esempio, un morso può essere così definito: il contatto della bocca tra un
congenere e un altro congenere. Non si tratta evidentemente della descrizione di un morso tipico. Sono quindi registrati
solo quegli elementi strettamente necessari e sufficienti perché l'osservatore riconosca la maggior parte degli avvenimenti
individuali designati abitualmente come morsi. Ciò vuol dire che nella specie considerata e nelle condizioni studiate,
l'applicazione del modello di esplorazione su ciò che è definito morso è sufficiente, mentre il resto dell'informazione ri-
dondante o superfluo. Seppure comuni in etologia, tali definizioni non vanno al di là della semplice identificazione degli
schemi di comportamento.
Lo scopo della definizione è di assicurare la fedeltà e la costanza dello strumento di misura - per l'osservatore -
e la fedeltà inter-osservatori. La definizione deve comprendere almeno un criterio netto e preciso al quale si fa
riferimento per dichiarare se un comportamento è presente o assente. II criterio può essere formale (topologico e
cinetico); può designare azioni da compiere o effetti da ottenere; può esigere che criteri relativi a due o più di questi
aspetti siano soddisfatti. La definizione è detta allora operazionale; essa non si basa sulle operazioni di misura o di messa
in evidenza, ma su quelle da compiere e sugli effetti da ottenere per mezzo dell'azione degli individui osservati; è a
questo prezzo che l'osservatore è autorizzato a dichiarare che tale o tal altro evento appartiene a questa o a quella
categoria.
Definire consiste dunque nell'assegnare una etichetta o un termine che riunisca varie informazioni essenziali. Hutt
e Hutt (1970), McGrew (1972), insieme a Strayer e Strayer (1976) propongono alcune definizioni di comportamento di
bambini. Si troverà in appendice qualche esempio di definizioni di modelli di comportamenti agonistici utilizzati nelle
nostre ricerche sul pesce spada verde.
II ricercatore definisce anche alcune unità arbitrarie tenendo conto, per esempio, degli spostamenti e della
posizione spaziale degli individui osservati. Così, in una delle nostre ricerche, abbiamo previsto una unità denominata
«cambiamento di comportamento», la quale implica l'annotazione di ogni passaggio da un compartimento dell'acquario a
un altro, in rapporto ai settori di partenza e di destinazione. In questo tipo di definizione, sono stati combinati dei criteri
formali, relativi dunque alla topologia e alla cinetica degli schemi (per esempio, posizione o stato delle pinne, o traietto-ria) e altri relativi ai loro effetti (per esempio, contatto della bocca o allontanamento rapido). Spesso sono introdotti
anche alcuni elementi contestuali come criteri essenziali. Così, la presenza (preliminare, concomitante o anche in una
postura particolare) del congenere in prossimità, è racchiusa nella definizione della maggior parte dei comportamenti
sociali individuali. È anche frequente che uno schema di comportamento sia designato e definito differentemente da un
altro, unicamente a partire dal contesto sociale nel quale è adottato. Pertanto, il dispiegamento laterale e la parata
laterale, in alcuni pesci ciclidi, comportano sul piano visivo gli stessi componenti morfologici e cinetici. Tuttavia, il primo
sarà chiamato agonistico perché è emesso di fronte ad un rivale o durante una disputa territoriale, e il secondo
epigamico perché si osserva in un contesto in cui il maschio e la femmina si sincronizzano sessualmente.
Ogni definizione deve anche essere il più possibile chiara e netta, in modo da non provocare né interpretazioni
né applicazioni troppo variabili a seconda degli osservatori. Tuttavia, molte dimensioni, spesso essenziali per la
definizione delle unità da osservare, sono molto difficili da valutare in assenza di strumenti di misura. Quindi, le distanze
tra gli individui, la loro velocità di spostamento o alcuni dettagli poco percettibili perché si producono troppo rapi-
damente o fuori del campo di visione dell'osservatore, possono portare all'aleatorio e all'arbitrario, Come in tutte le
operazioni di misura, il ricercatore spera che gli errori di misura si distribuiscano per caso e non sistematicamente a
favore o a sfavore delle sue ipotesi. Se vi è un numero considerevole di unità differenti da registrare, è senz'altro
preferibile non conservare i comportamenti la cui classificazione è dubbia. Bisogna anche verificare che la registrazione
di certe unità non sia più difficile di quella di altre unità; altrimenti, nel respingere le osservazioni dubbie in modo ineguale
si introduce una alterazione sistematica dei risultati.
Le unità di superficie ben definite servono a costruire unità più profonde. Nelle nostre ricerche, alcuni concetti e
alcune super-categorie comportamentali furono definite a partire dalle unità di superficie presentate in appendice. Come
mostra la figura 9.1, la definizione dei metaconcetti comportamentali deve somigliare idealmente a una arborizzazione, le
cui foglie o unità terminali sono costituite dagli schemi di comportamento che rappresentano l'oggetto dell'osservazione
diretta, mentre i rami e i ramoscelli sono dati dai metaconcetti che sono costruiti a partire da queste unità primitive. Così,
un comportamento agonistico potrà comprendere, per definizione, ogni comportamento aggressivo, o anche ogni
comportamento difensivo, poiché quest'ultimo è costituito, sempre per definizione, da schemi motori di fuga o da
posture di ripiegamento. Ciò accade in un comportamento aggressivo, il quale potrà, ancora per definizione,
comprendere in un primo momento i comportamenti di minaccia (raggruppanti essi stessi due schemi osservabili,
l'ondulazione laterale e il dispiegamento laterale), e in un secondo momento i comportamenti offensivi (questi ultimi sono
stati classificati sulla base degli attacchi e dei morsi). Si vede dunque come si può costruire, a partire dalle unità primitivedirettamente osservabili, tutta una serie di concetti globali e teorici, pur restando legati a quanto è osservabile..Molto spesso, diventa necessario definire pure delle unità che implichino interazioni tra gli individui. Le definizioni possono allora essere sensibili al contesto spazio-temporale nel quale i comportamenti sono adottati. Per esempio, il comporta- mento aggressivo di un individuo può corrispondere alla definizione di comportamento che consiste nel dare la caccia a un altro individuo (che noi chiamiamo preda) se quest'ultimo risponde con un comportamento difensivo (fuga o postura di ripiegamento). Al contrario, lo stesso schema motorio aggressivo può portare a una replica se il congenere aggredito risponde a sua volta con un comportamento aggressivo. Una replica è stata definita come un comportamento aggressivo di un primo individuo in risposta al comportamento aggressivo di un secondo individuo. Le interazioni (caccia, replica) possono a loro volta fornire gli elementi necessari alla definizione di altri concetti ancora più globali. Il criterio di domi- nanza gerarchica tra due individui può essere pertanto definito come la riuscita di cinque cacce (concetto definito sopra) del primo individuo contro il secondo, mentre quest'ultimo a sua volta non è riuscito in nessuna. A partire da questi concetti, se ne possono definire altri più profondi, come quelli della gerarchia di dominanza in un gruppo determinato, o quelli di un'organizzazione sociale con harem. Uno sforzo di formalizzazione può essere egualmente realizzato con l'utilizzazione di un linguaggio come quello del BNF (Naur, 1963) o quello del calcolo proporzionale di cui si troverà un'introduzione in Kimball (1973).
Ripetizioni e transizioni
Alcuni comportamenti hanno la tendenza a prodursi in modo concentrato e ripetuto. Si deve allora registrare una
sola apparizione del comportamento o tante apparizioni differenti? Per esempio, supponiamo che un'unità inglobi tutte le
attività ludiche alle quali si dedica un bambino. L'osservatore annoterà una manifestazione ogni volta in cui il soggetto
manipolerà uno stesso oggetto, o ogni volta che passerà ad un altro? O considererà piuttosto il gioco come uno stato
con una durata e che si interrompe solo con l'adozione di un comportamento appartenente a un'altra unità (per esempio,
la sollecitazione dell'attenzione di un adulto)?
Questo problema dell'identificazione del principio e della fine dei comportamenti, così come quello del loro
raggruppamento e del loro trattamento come eventi indipendenti, è estremamente importante. L'inizio e la fine di un
comportamento possono essere specificati nel momento della definizione degli schemi di comportamento: la definizione
indica allora se un comportamento o uno schema di comportamento possono avere una durata o sono considerati un
evento puntuale. Essa indica anche, se è il caso, il criterio che determina la fine di un modello di comportamento e l'inizio
di un altro nella stessa unità. Il ricercatore può definire due tipi di unità comportamentali, a seconda che egli consideri o
meno la loro durata. Se gli eventi sono unità di cui non gli interessa la durata, sono considerati come aventi una durata
puntuale. Per esempio, in un pollo, un morso, una beccata, o il bere sono comportamenti distinti, spesso considerati
come eventi puntuali o senza durata. A1 contrario, per un ricercatore interessato al grado di stereotipia di un
comportamento come il bere nel pollo, ogni bevuta è considerata come avente una durata significativa. Questo
ricercatore fa allora un'analisi particolareggiata dei movimenti implicati, rallentandoli, per esempio, con (aiuto di un
processo cinematografico. Un evento con durata significativa è talvolta chiamato stato (Altmann 1974; Sackett 1978):
si tratta di un comportamento nel quale un organismo è implicato. Gli stati possono sempre, al momento dell'analisi,
essere trasformati in eventi senza durata. A1 contrario, agli eventi puntuali non si può, a tale stadio, attribuire una durata,
poiché questa informazione è irrimediabilmente persa. Si devono quindi effettuare analisi distinte a seconda che si tratti
di eventi o di stati. Infine, una serie di eventi apparsi una sola volta in una unità di comportamento costituisce una attività
(bout in inglese).
Determinare la fine dell'unità, dello stato o dell'attività è una questione delicata. Applicabili isolatamente o in
combinazione, i criteri di interruzione sono di tre ordini. In primo luogo, ci può essere la messa in atto di un altro
comportamento. Per esempio, tutte le azioni di un bambino che manipola un oggetto sono registrate come una sola
apparizione del gioco, fino a quando non sono interrotte da un comportamento agonistico. In secondo luogo, (in-
terruzione può consistere in una pausa o un intervallo più lungo di quello ritenuto come necessario e sufficiente perseparare due insiemi di comportamenti. In terzo luogo, un'attività può essere interrotta da un cambiamento di oggetto
(per esempio, un nuovo giocattolo) o di luogo (per esempio, una nuova parte del corpo da pulire).
Si possono applicare criteri simili alle transizioni di comportamenti tra gli individui. Molto spesso, il ricercatore
vuole conoscere la probabilità di successione di due comportamenti. Il calcolo delle probabilità transizionali o
condizionali fa parte di ciò che si è convenuto chiamare l'analisi delle sequenze di comportamenti. Infatti, si tratta
dell'analisi delle transizioni nelle sequenze, dove ogni sequenza è considerata come una frase di cui bisogna fissare le
regole sintattiche. Il problema è il seguente: si devono considerare tutte le transizioni tra due comportamenti di due
individui come appartenenti a una serie stimolo-risposta, o si deve fissare un limite temporale al di là del quale un
comportamento non è più considerato come determinato da quello che lo precede? La questione può essere risolta con
una valutazione etologica, come hanno fatto Dane e Van Ber Kloot (1964) nel loro studio sulle sequenze del comporta-
mento epigamico nell'anitra quattrocchi (Bucephalo elangula). A partire dalle osservazioni preliminari, questi autori
hanno considerato che, quando le attività di due individui non sono separate da più di cinque secondi, fanno parte di una
transizione stimolo-risposta.
Al contrario, è possibile esaminare i risultati attentamente e mettere in evidenza criteri più obiettivi. Si può così
esaminare la distribuzione degli intervalli temporali e del logaritmo della sopravvivenza degli eventi di una stessa unità, in
uno stesso individuo, o di due unità, in individui differenti (Machlis 1977; Slater 1974). Nel nostro studio sulle regole di
scambio agonistico nel pesce ciprinodonte (Xipbophorus helleri, Poeciliidae), uno scambio agonistico tra due duellanti
implicava la successione di due modelli di comportamento in un certo intervallo; per esempio, nel caso di morsi,
l'intervallo era di 0,05 minuti (Beaugrand e Zayan 1985). Altrimenti, la transizione non era conservata e vi era
obbligatoriamente una pausa inserita tra i due comportamenti. Questa decisione fu presa dopo l'esame delle distribuzioni
degli intervalli che separano tutti i comportamenti, così come delle curve del logaritmo della loro sopravvivenza.
Idealmente, il criterio scelto deve riflettere l'organizzazione o la struttura dei comportamenti stessi (Slater 1974);
un'analisi di queste curve può inoltre svelare i processi sottostanti. Un istogramma degli intervalli che separano gli eventi
che si producono a caso si conforma a una distribuzione esponenziale negativa, retta dalla legge di Poisson (Cox e
Lewis 1966), e caratteristica delle distribuzioni nelle quali le misure sono indipendenti nel tempo. La figura 9.2(a)
presenta un istogramma degli intervalli osservati tra le ferite causate da due duellanti durante i combattimenti pianificati. È
evidente che la grande maggioranza degli intervalli non supera gli 0,04 minuti. AI contrario è ben difficile decidere sul
criterio di interruzione unicamente a partire da questi dati.
Si può ottenere una curva del logaritmo di sopravvivenza stabilendo, per ogni intervallo, il numero totale degli
intervalli osservati che gli sono ancora superiori. II logaritmo naturale di questo numero rimpiazza allora nell'istogrammala frequenza osservata per l'intervallo corrispondente: per esempio, in 133 occasioni l'intervallo misurato tra le ferite provocate da due individui supera gli 0,04 minuti, e il logaritmo di 133 è 4,8903. Si troveranno in Fagen e Young (1978) i dettagli dell'applicazione di questa procedura. In principio se tutte le misure sono indipendenti e distribuite a caso, il logaritmo della frequenza delle sopravvivenze si deve tradurre in una retta. Nella figura 9.2(c), ogni linea tracciata tra due punti dimostra una pendenza direttamente proporzionale alla probabilità che una ferita si produca dopo un dato intervallo. Ogni cambiamento delle probabilità sottostanti si deve manifestare con un cambiamento brusco nell'aspetto della curva, il che suggerisce l'esistenza di processi differenti prima e dopo il cambiamento. Così si constata, per le transizioni tra le ferite provocate da due individui, una diminuzione della pendenza tra 0,04 e 0,06 minuti, dunque un abbassamento subito dalla probabilità. Ciò porta a considerare come transizioni da una ferita a un'altra, unicamente quelle associate a intervalli che non superano gli 0,05 minuti, e a considerare le altre come obbligatoriamente interrotte da una pausa e non dipendenti dallo stesso processo. La stessa trasformazione può essere applicata alle transizioni tra ferite in uno stesso individuo (figura 9.2, d-f).
Figura 9.2 Frequenze, percentuali delle frequenze cumulate e logaritmi, della entità di intervalli che separano due comportamenti emessi sia da due individui differenti (a, h, c), sia dallo stesso individuo (d, e, f). Tale entità corrisponde alla frequenza di intervalli che hanno una durata superiore a una durata data.
Esiste una tecnica più esatta che permette di stabilire se il ricercatore è in presenza di una sola distribuzione o di
più distribuzioni che si accavallano parzialmente. Si tratta di mettere a confronto la distribuzione osservata con una serie
di distribuzioni teoriche di tipo gamma (Derman e coll. 1973), e di trovare un punto di separazione ottimale tra due o più
di esse che si prestano meglio alle osservazioni. Questo approccio fu sperimentato da Doré e coll. (1977) e Lefebvre
(1978). Altre tecniche oggettive sono descritte da Law e Kelton (1982).
Durante l'analisi delle transizioni nelle sequenze, è raro che ci si preoccupi dello scarto temporale tra gli elementi
consecutivi. È pertanto essenziale che le transizioni costruite rispettino la distribuzione naturale degli eventi. Così, per
ogni tipo di transizione comportamentale che avviene in uno stesso individuo o in due individui, si devono studiare le
curve del logaritmo delle sopravvivenze degli intervalli temporali, al fine di stabilire un criterio temporale al di là del quale
due comportamenti sono considerati come indipendenti sui piani statistico ed etologico. Le analisi delle transizioni che
rispettano un tale criterio forniscono un'immagine più chiara dei processi implicati.
PIANO DI OSSERVAZIONE
La registrazione dei comportamenti, effettuata con l'osservazione diretta, deve essere rigorosamente pianificata.
Allo scopo di assicurare la validità, il piano di osservazione indica le modalità secondo le quali le misure e le osservazioni
sono registrate, come pure il modo di controllare alcune variabili. La costruzione del piano tiene conto dei seguenti tre
tipi di considerazioni: gli obiettivi della ricerca, come pure la presenza e la natura delle ipotesi da provare; la possibilità di
procedere a osservazioni, la quale possibilità dipende dal numero di unità comportamentali registrate e dalla presenza di
tecniche complementari; infine, la precisione, la potenza e l'efficacia cui si aspira. Nel momento in cui mette a punto il
suo piano di osservazione, il ricercatore prende una serie di decisioni concernenti otto aspetti che esamineremo di
seguito.
Scelta di una tassonomia
Quali comportamenti, appartenenti al repertorio dei soggetti, saranno osservati? La risposta a questa domanda
è il più delle volte dettata dagli obiettivi del ricercatore, che registra unicamente i comportamenti che sono più pertinenti.
In assenza di domande e di ipotesi precise, è difficile giudicare questa pertinenza. Quali comportamenti dovranno essere
riconosciuti nell'insieme dei comportamenti osservabili e quali saranno registrati o codificati? La distinzione tra quanto è
riconosciuto e quanto è registrato non è artificiale. 1 modelli di comportamento di una specie costituiscono la tassonomia
di superficie a partire dalla quale il ricercatore può costruire una tassonomia più molare, più profonda. Poiché ilricercatore ha enunciato domande precise, è in effetti molto raro che i comportamenti registrati siano le unità costituenti
la tassonomia di superficie della specie, a meno, ben inteso, che queste domande non la riguardino espressamente.
Spesso, l'annotazione è più molare. Così, si classifica unicamente un comportamento aggressivo al posto di annotare
l'unità specifica compresa in questa sopracategoria (per esempio, una ferita o un colpo procurato); si può anche
registrare solamente l'asimmetria risultante da uno scambio tra due adolescenti, l'uno avente il sopravvento sull'altro.
II livello di codificazione dipende ugualmente dal margine di sicurezza che si riserva il ricercatore allo scopo di
ridefinire successivamente la categorizzazione. Se la codificazione è molto precisa, i rischi di errore aumentano e la
ricerca manca di efficacia. Essa incoraggia anche la mescolanza compulsiva dei dati, in assenza di una qualche ipotesi.
A1 contrario, il ricercatore può essere interessato a riprendere in parte la classificazione, per mettere in evidenza
regolarità ipotetiche da verificare in seguito. Se, al contrario, la codificazione è troppo molare c'è il pericolo di una
perdita di sensibilità. Comunque la sensibilità si misura in rapporto alle ipotesi della ricerca, e non in modo assoluto. Il
ricercatore deve anche decidere se le unità registrate sono eventi puntuali o eventi che hanno una durata significativa.
Registrazione di elementi temporali
Il ricercatore deve, oltre ad annotare l'identità di ogni modello di comportamento, registrare il momento in cui
viene prodotto? Deve limitarsi a registrare l'ordine di apparizione dei comportamenti, o deve pure enumerare i
comportamenti per stabilire la loro frequenza? Anche qui tutto dipende dalle domande poste e dalle considerazioni
pratiche e tecnologiche che presiedono alla ricerca. La decisione si accorda con la scelta delle tecniche di
campionamento e degli apparecchi ausiliari. È evidente come le conclusioni che si potranno trarre saranno differenti, a
seconda che le analisi che sono loto soggiacenti abbiano portato a frequenze o a durate. Il continuum sul quale varia la
durata dei comportamenti è diverso da quello relativo alla loro frequenza; ci si può dunque aspettare che la durata sia
più sensibile alle differenze rispetto alla frequenza, ma più difficile da interpretare. Conviene dunque, quando si può,
registrare allo stesso tempo la frequenza e la durata dei comportamenti. Ciò è possibile ai nostri giorni, grazie ai
microprocessori concepiti per registrare le osservazioni codificate (chiameremo questi apparecchi etografi). La maggior
parte degli etografi messi sul mercato registrano automaticamente elementi temporali. Questa registrazione, e quella delle
sequenze durante il campionamento continuo del comportamento, sfociano in numerose misure supplementari che non
possono essere fornite dalla sola registrazione limitata alle apparizioni o anche alle sequenze di apparizione. Alcune di
queste misure sono presentate nella tavola 9.1.Modalità di registrazione
La qualità e la rappresentatività delle osservazioni dipendono anche dalle modalità di registrazione. Le
osservazioni devono essere realizzate dal vivo, nel momento in cui si svolge l'azione, o in differita, a partire da
registrazioni magnetoscopiche, cinematografiche o anche sonore? La risposta dipende sempre dagli obiettivi della
ricerca. In certi casi, può essere necessario conservare il materiale per un'ulteriore decodificazione; è il caso, per
esempio, di quando l'analisi deve utilizzare il rallentamento cinematografico. L'utilizzazione del nastro magnetoscopico, o
del film, consente evidentemente la ripresa delle osservazioni secondo parecchi criteri di osservazione, e un'analisi
dettagliata e molto approfondita del comportamento. Essa comporta in compenso qualche inconveniente. In primo
luogo, queste modalità di registrazione non forniscono che una rappresentazione bidimensionale e a volte monocroma.
Necessitano anche, spesso, di luci artificiali e di forti spese. Salvo quando si ricorre a obiettivi grandangolari molto
sensibili, si verifica la perdita dell'informazione. Inoltre, la presenza di tutto l'equipaggiamento necessario rischia di
turbare i soggetti, soprattutto se si tratta di individui umani. L'ultimo dei pericoli, ma non il minore, è quello che riguarda
il rimescolamento compulsivo dei dati, incoraggiato dai chilometri di registrazioni effettuati troppo facilmente, al di fuori
di una qualsiasi domanda pertinente.
Sistema di codificazione e di annotazione
Non è sempre necessario appesantirsi di apparecchi complessi per realizzare valide osservazioni. Basta spesso
avere carta e penna, soprattutto se gli obiettivi della ricerca sono chiari e se ciò che deve essere annotato è
sufficientemente molare. Ci si può servire, allora, di liste di controllo (ebecklists), di matrici, di contatori, di registratori,
o anche di un poligrafo. Al contrario, l'utilizzazione di apparecchi direttamente compatibili con un calcolatore accresce
molto le possibilità di indagine.Tavola 9.1 Confronto tra modi diversi di registrare il comportamento. La registrazione degli elementi temporali (durata, momento) e dell'ordine delle sequenze (dati del tipo III, IV e V) dà luogo a numerose misure supplementari che non possono essere date dalle registrazioni che si limitano ad annotare l'apparizione e l'identità dei comportamenti, o anche le loro sequenze di apparizione (tipi I e II). Cosi, la tecnica che consiste nell'annotare soltanto l'identità dell'iniziatore e quella del comportamento emesso e anche la sequenza in cui sono emessi i comportamenti (tipo II) non dà informazioni sulla durata, la latenza e gli intervalli tra le apparizioni.
In tutti i casi, è impiegato un sistema di codici. Composto da segni e simboli alfanumerici o da grafici che
rappresentano le unità pertinenti, esso aumenta la velocità e l'efficacia della registrazione delle osservazioni, della loro
validità, del loro trasferimento al calcolatore, come pure della loro analisi. Se ben fatta può essere direttamente trattata
dal calcolatore. In questo modo, più il codice è breve, più può essere rapidamente registrato e meno spazio occupa
nell'apparecchio registratore o sul disco del calcolatore. Se il codice è un buon evocatore visivo, uditivo o mnemonico
del comportamento al quale è associato, l'osservatore ha minori problemi nel codificare questo comportamento e sono
commessi meno errori. La codifica ha lo scopo di facilitare l'osservazione e non di ostacolarla. Dipende, evidentemente,
dalle regole e dalle convenzioni esplicite sulle quali si poggia la classificazione delle osservazioni. A ogni classe o unità
pertinente che si desidera registrare, deve corrispondere un codice specifico, unico ed esclusivo. La codificazione va di
pari passo con la tecnica di campionamento scelta e con le dimensioni da registrare (durata, scopo, fine, intensità,
origine, destinazione e orientamento). Si troverà nella tavola 9.2 il sistema di codificazione che abbiamo utilizzato per il
campionamento per identificazioni successive di parecchi membri di un gruppo. Se è richiesta la durata di alcuni
comportamenti, possono essere impiegati certi codici speciali come prefisso o suffisso ai codici comportamentali, (uno
indicante (inizio di un comportamento e (altro la sua fine. Se un tale sistema è ben impiegato, si può notare che i
comportamenti si producono in modo concorrente o simultaneo. Golani (1976) ha sviluppato un vocabolario particolare
per descrivere i comportamenti concorrenti. Si troverà un buon riepilogo del suo lavoro in Lehner (1979 ).
Osservazione continua e completa (in opposizione al campionamento)
A meno che non voglia registrare il comportamento al completo, il ricercatore deve, oltre che scegliere i
comportamenti da registrare, decidere il periodo di tempo durante il quale queste osservazioni saranno effettuate. Dal
campionamento temporale dipendono la validità delle osservazioni, la loro utilità e la loro capacità di fornire risultati
generalizzabili. II campionamento può avere una base temporale regolare o irregolare. Può essere determinata dagli
eventi che interessano particolarmente l'osservatore o anche da alcune circostanze che egli desidera mettere in
opposizione (cambiamenti di ambiente o di stato).Puoi anche leggere