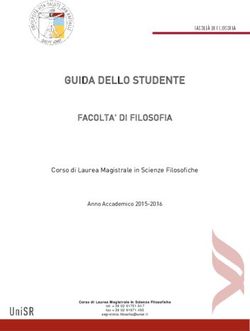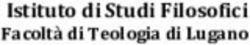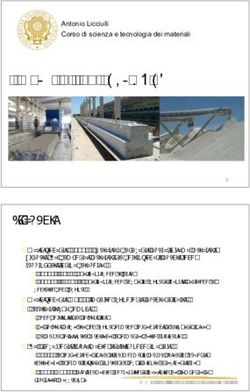Metafilosofia e filosofia della scienza - di - Syzetesis
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Metafilosofia e filosofia della scienza
di
Fabio Sterpetti
Abstract: Metaphilosophy and Philosophy of Science. The aim of this paper is
twofold: 1) to shed light on the relevance of metaphilosophy to the philoso-
phy of science, and the relevance of one’s view of science to the development
of one’s metaphilosophical stance. It will be argued that metaphilosophical
reflection is indispensable for the definition of one’s conception of philoso-
phy of science, and that different metaphilosophical views lead to different
conceptions of philosophy of science. It will also be argued that one’s adop-
tion of a certain view of science and its method is relevant to the definition
of one’s metaphilosophical stance, and that different views of science and
its method lead to different metaphilosophical stances; 2) to clarify how to
understand “metaphilosophy” and the relation between the philosophical
reflection about philosophy and the theoretical reflection that is internal to
non-philosophical disciplines, such as the sciences.
Keywords: Metaphilosophy, Philosophy of Science, Epistemology, Naturalism
Abstract: L’obiettivo di questo articolo è duplice: 1) mettere in luce la rile-
vanza della metafilosofia per la filosofia della scienza e della concezione
della scienza che si adotta per l’elaborazione della propria posizione meta-
filosofica. Si cercherà di mostrare come la riflessione metafilosofica sia
indispensabile per la definizione della propria concezione della filosofia
della scienza e come visioni metafilosofiche diverse conducano a diverse
concezioni della filosofia della scienza, nonché di mostrare come l’ado-
zione di una determinata concezione della scienza e del suo metodo, tra le
diverse possibili, sia rilevante per la definizione della propria concezione
metafilosofica e come concezioni della scienza e del suo metodo diverse
conducano a diverse concezioni metafilosofiche; 2) contribuire a chiarire
cosa debba intendersi per “metafilosofia” e quale relazione debba ritenersi
sussista tra la riflessione filosofica sulla filosofia e la riflessione teorica che
avviene nelle discipline non filosofiche, come quelle scientifiche.
Keywords: metafilosofia, filosofia della scienza, epistemologia, naturalismo
Syzetesis VIII (2021) 163-208 / Articoli
ISSN 1974-5044 - http://www.syzetesis.it
DOI: 10.53242/syzetesis/10 163Fabio Sterpetti
1. Introduzione 1
La riflessione filosofica sulla scienza, ovvero la filosofia della scienza,
è di norma considerata una disciplina filosofica contigua all’episte-
mologia, ovvero a quella disciplina filosofica che si occupa di stu-
diare la conoscenza 2. Dato che la scienza rappresenta una forma di
acquisizione di conoscenza, la vicinanza tra la filosofia della scienza
e l’epistemologia appare naturale. Eppure, temi e problemi affrontati
nei due ambiti disciplinari non sempre sono sovrapponibili. Diversi
autori lamentano che negli ultimi decenni le ricerche nei due settori
non abbiano tenuto adeguatamente conto del lavoro che si svolgeva
nel settore contiguo e auspicano che in futuro possa esservi una mag-
giore compenetrazione di tali ambiti disciplinari 3.
Qui si cercherà di mettere in luce, invece, la contiguità che sussiste
tra la filosofia della scienza e la riflessione metafilosofica, contiguità
meno indagata di quella che sussiste tra la filosofia della scienza e
l’epistemologia, ma non per questo meno rilevante per la compren-
sione di entrambe queste discipline filosofiche4. Ad esempio, una
delle cause della difficoltà di comunicazione tra i settori della filoso-
fia della scienza e dell’epistemologia può essere individuata proprio
nella diversa sensibilità metafilosofica che caratterizza la maggioran-
za degli studiosi in ciascuno di tali ambiti disciplinari 5. La predomi-
1
Dove non altrimenti indicato la traduzione dei testi citati è mia.
2
La letteratura sull’epistemologia è molto ampia. Per una prima introduzione
all’epistemologia analitica contemporanea, cui qui si farà principalmente riferi-
mento, si vedano: M. Steup-R. Neta, Epistemology, in E. N. Zalta (ed.), The Stanford
Encyclopedia of Philosophy, 2020, https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/
epistemology/ [20.09.2021]; P. K. Moser (ed.), The Oxford Handbook of Epistemology,
Oxford University Press, Oxford 2002; R. Audi, Epistemology: A Contemporary
Introduction to the Theory of Knowledge, Routledge, New York 2003, 2nd ed.; N.
Rescher, Epistemology: An introduction to the Theory of Knowledge, State University
of New York Press, Albany (NY) 2003; L. BonJour, Epistemology: Classic Problems and
Contemporary Responses, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham (MD) 2010.
3
Si vedano, ad esempio, O. Bueno, Epistemology and Philosophy of Science, in P.
Humphreys (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Science, Oxford University
Press, Oxford 2016, pp. 233-251; N. Ballantyne, Knowing Our Limits, Oxford University
Press, New York 2019, cap. 1, spec. §§ 1-3.
4
Sul rapporto tra metafilosofia e filosofia della scienza, si veda C. A. Hooker,
Philosophy and Meta-Philosophy of Science: Empiricism, Popperianism and Realism,
«Synthese» 32 (1975), pp. 177-231.
5
Su questo, si vedano: K. P. Stanford, So Long, and Thanks for All the Fish: Metaphysics
and the Philosophy of Science, in M. Slater-Z. Yudell (eds.), Metaphysics and the
164Metafilosofia e filosofia della scienza
nanza in un certo ambito della filosofia di una certa concezione della
filosofia, infatti, contribuisce a delineare i temi, i problemi e i metodi
che caratterizzano le ricerche in tale ambito filosofico, rendendo
così tali ricerche più o meno permeabili ai contributi provenienti
da un diverso ambito filosofico a seconda che la concezione della
filosofia che informa di sé quest’ultimo sia più o meno distante dalla
concezione della filosofia che informa di sé l’ambito filosofico cui
appartengono tali ricerche. L’epistemologia è tradizionalmente con-
siderata una disciplina normativa, ovvero una disciplina non votata
esclusivamente a descrivere come avvengano i processi conoscitivi,
ma votata a stabilire cosa dobbiamo considerare conoscenza e come
dobbiamo procedere nel nostro ragionare per potere acquisire cono-
scenza genuina. In tale prospettiva, l’indagine epistemologica viene
svolta dai filosofi a priori, ovvero indipendentemente dall’esperienza,
attraverso il loro solo ragionare e facendo affidamento sulle proprie
intuizioni (si veda, infra, § 4). Dato che, in quest’ottica, gli epistemolo-
gi indagano a priori la conoscenza in generale, si deve ritenere o che
questi occupino una posizione sovraordinata a quella di coloro che
si occupano di specifiche modalità conoscitive, come gli scienziati, o
che comunque si occupino di qualcosa di completamente distinto da
ciò di cui si occupano gli scienziati, il lavoro dei quali, a differenza di
quello dei filosofi, non può che trovare una giustificazione a posterio-
ri, per cui molti autori ritengono che in ogni caso gli epistemologi non
debbano necessariamente interessarsi a ciò che accade nella scienza,
a quanto teorizzano o scoprono gli scienziati 6. Molti di coloro che
Philosophy of Science: New Essays, Oxford University Press, New York 2017, pp. 127-
140; N. Ballantyne, Knowing Our Limits, cit., cap. 1.
6
Su come la dimensione normativa dell’epistemologia sia trattata nell’episte-
mologia analitica attuale, si vedano, ad esempio, C. McHugh-J. Way-D. Whiting,
Introduction, in C. McHugh-J. Way-D. Whiting (eds.), Metaepistemology, Oxford
University Press, Oxford 2018, pp. 1-8; C. Kyriacou-R. McKenna, Introduction, in C.
Kyriacou-R. McKenna (eds.), Metaepistemology: Realism and Anti-Realism, Palgrave
Macmillan, Cham 2018, pp. 1-14; R. A. Fumerton, Metaepistemology and Skepticism,
Rowman & Littlefield Publishers, Lanham (MD) 1995. Questi sono tutti testi dedicati
alla metaepistemologia, ovvero all’indagine filosofica dell’epistemologia, quella
indagine filosofica in cui si indagano questioni come se l’epistemologia sia una
disciplina normativa o meno. Per chiarire la dimensione normativa dell’epistemo-
logia è ormai invalso l’uso di istituire un’analogia tra l’epistemologia e l’etica, così
come tra la metaepistemologia e la metaetica. Sull’analogia tra etica ed epistemolo-
gia, cfr. C. McHugh-J. Way-D. Whiting, Introduction, cit., p. 1: «L’epistemologia è, al-
meno in parte, una disciplina normativa. Proprio come l’etica si occupa di questioni
165Fabio Sterpetti coltivano l’epistemologia, sebbene certamente non tutti, inclinano verso una tale concezione razionalista e fortemente non naturalista della filosofia proprio perché tale concezione della filosofia è quella più compatibile con la tesi della natura normativa e a priori della loro disciplina 7. Vi è qui una sorta di resistenza al cambiamento. La con- come ‘che cosa dovrei fare?’, ‘che cosa sarei giustificato a fare?’ e ‘per fare che cosa avrei delle buone ragioni?’, l’epistemologia si occupa di questioni come ‘che cosa dovrei pensare?’, ‘che cosa sarei giustificato a pensare?’ e ‘per pensare che cosa avrei delle buone ragioni?’». Sull’analogia tra metaetica e metaepistemologia, cfr. R. A. Fumerton, Metaepistemology and Skepticism, cit., p. 1: «Sebbene questa terminologia sia relativamente nuova, è sempre stato possibile distinguere due tipi di questioni abbastanza differenti in epistemologia: le questioni metaepistemologiche e le que- stioni di epistemologia normativa. Tale terminologia è presa in prestito dalla (e tale distinzione per molti versi è sovrapponibile alla) più familiare distinzione che vi è in etica tra metaetica ed etica normativa. Proprio come in metaetica si ha principal- mente a che fare con l’analisi dei concetti fondamentali del discorso etico, così in metaepistemologia si ha principalmente a che fare con l’analisi dei concetti fonda- mentali del discorso epistemologico. Proprio come in etica normativa si presuppone una certa comprensione dei concetti etici e si cerca di rispondere a questioni generali o specifiche che riguardano quali azioni siano giuste, quali cose siano buone e come le persone dovrebbero comportarsi, così in epistemologia normativa si presuppone una certa comprensione dei concetti epistemologici e si cerca di determinare cosa si conosce e cosa si crede razionalmente o giustificabilmente». Sulla metaepistemolo- gia, cfr. C. Kyriacou-R. McKenna, Introduction, cit., p. 1: «La metaepistemologia è, in estrema sintesi, quella branca dell’epistemologia che si interroga sull’esistenza, sulla natura e sull’autorità dei fatti e delle ragioni epistemici». 7 Le concezioni naturaliste rifiutano infatti di norma la conoscenza a priori e l’esi- stenza di fatti normativi irriducibili ai fatti naturali. Sulla centralità del rifiuto della possibilità della conoscenza a priori per il naturalismo, cfr., ad esempio, M. Devitt, Naturalism and the A Priori, «Philosophical Studies» 92 (1998), pp. 45-65, p. 45: «c’è un solo modo di conoscere, il modo empirico che è la base della scienza […]. Per que- sto io rifiuto la “conoscenza a priori”». Sulla difficoltà di coniugare il naturalismo con una concezione realista della normatività, ovvero con l’accettazione della tesi dell’esistenza di fatti normativi indipendenti e irriducibili ai fatti naturali inda- gati dalle scienze naturali, si veda M. De Caro-D. Macarthur, Introduction: Science, Naturalism, and the Problem of Normativity, in M. De Caro-D. Macarthur (eds.), Naturalism and Normativity, Columbia University Press, New York 2010, pp. 1-19. Sul naturalismo come posizione metafilosofica e sulla sfida che il naturalismo rappre- senta per l’epistemologia tradizionale, si vedano D. Papineau, Naturalism, in E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021, https://plato.stanford.edu/ archives/sum2021/entries/naturalism/ [20.09.2021]; K. J. Clark (ed.), The Blackwell Companion to Naturalism, Blackwell, Oxford 2016. Per una breve e recente mappa- tura delle principali posizioni naturaliste, si veda L. Perissinotto, Il naturalismo oggi: Abbozzo di una mappa e alcune riflessioni, in G. Bagnati-M. Cassan-A. Morelli (a cura di), Le varietà del naturalismo, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia 2019, pp. 11-29. 166
Metafilosofia e filosofia della scienza
cezione della filosofia che consente la preservazione della concezione
tradizionale di un dato ambito disciplinare è di norma quella mag-
giormente diffusa tra gli appartenenti a tale ambito disciplinare. E gli
appartenenti a tale ambito disciplinare, a parità di argomenti, saran-
no maggiormente restii ad abbandonare tale posizione metafilosofica
in favore di una diversa posizione metafilosofica di quanto sarebbero
se tale posizione non fosse direttamente connessa alla preservazione
della loro concezione del proprio ambito disciplinare.
Ecco, dunque, che può succedere che, nonostante gli epistemo-
logi coltivino un ambito di indagine per molti versi affine a quello
della filosofia della scienza, la concezione della filosofia adottata da
molti epistemologi, almeno in ambito analitico, sia molto più vicina
alla concezione della filosofia adottata dalla maggior parte di coloro
che coltivano la metafisica che alla concezione della filosofia adottata
da coloro che coltivano la filosofia della scienza. Nonostante, quindi,
l’epistemologia sembri maggiormente distante dalla metafisica che
dalla filosofia della scienza quanto a oggetto di indagine, l’insistenza
sulla natura normativa e sulla metodologia a priori, che caratteriz-
zerebbero l’epistemologia secondo la concezione tradizionale della
disciplina, accomuna quest’ultima più alla metafisica che non alla
filosofia della scienza. Coloro che si formano nella tradizione della
filosofia della scienza hanno, infatti, spesso maggiore pudore nell’ab-
bracciare una concezione della filosofia tanto epistemicamente “spa-
valda” quanto quella adottata da molti epistemologi e metafisici con-
temporanei, dato che la loro disciplina ha assunto un profilo accade-
mico riconoscibile nell’ambito dell’empirismo logico, che rifuggiva
una tale forma di razionalismo in quanto caratteristico di quel pen-
siero metafisico che cercava di espungere dalla propria concezione
scientifica del mondo 8. A differenza di molti epistemologi, i filosofi
della scienza ritengono di norma molto rilevante per il loro lavoro
quanto avviene nella scienza e i risultati ottenuti dagli scienziati,
specialmente ciò che questi scoprono in merito ai modi in cui intera-
giamo col mondo e al funzionamento della nostra cognizione, motivo
8
Su quanto l’afflato antimetafisico della filosofia della scienza delle origini abbia
caratterizzato in maniera profonda la disciplina, nonostante anche nell’ambito
della filosofia della scienza si sia assistito negli ultimi anni a un ritorno in auge
della metafisica, con la fioritura di numerosi studi dedicati alla cosiddetta metafi-
sica della scienza, si veda K. P. Stanford, So Long, and Thanks for All the Fish, cit., che
contiene anche una pungente critica della metafisica della scienza.
167Fabio Sterpetti
per cui tali filosofi ritengono spesso che sia impossibile elaborare
una concezione adeguata della conoscenza scientifica e degli esseri
umani in quanto soggetti epistemici che non tenga in debita conside-
razione quanto scoperto dagli scienziati.
Una tale divergenza nella concezione filosofica della filosofia che
caratterizza un dato ambito disciplinare, insieme alla specializzazio-
ne e compartimentazione istituzionale crescente della ricerca, anche
filosofica 9, è perciò in grado di spiegare perché epistemologi e filosofi
della scienza di stampo analitico, i quali coltivano settori a prima
vista tanto vicini del sapere filosofico e si muovono nel solco della
stessa tradizione filosofica, abbiano ignorato e continuino a ignorare,
salvo rare eccezioni, il lavoro gli uni degli altri.
2. Metafilosofia della scienza
La riflessione metafilosofica svolge un ruolo cruciale, seppure spesso
non sufficientemente messo in evidenza, nella definizione delle diver-
se concezioni di una data disciplina filosofica che possono rintracciar-
si in letteratura. Se, ad esempio, si intende indagare filosoficamente
cosa sia la filosofia della scienza, bisogna preliminarmente indagare
filosoficamente a) cosa sia la filosofia e b) cosa sia la scienza in gene-
rale, ovvero cosa definisca la scienza in quanto fenomeno unitario al
di là delle caratteristiche peculiari delle singole discipline scientifiche.
L’indagine filosofica della filosofia è ciò che caratterizza la meta-
filosofia in quanto disciplina filosofica (si veda, infra, § 3). L’indagine
filosofica della scienza in generale è ciò che caratterizza la filosofia
della scienza generale in quanto sotto-disciplina di quella disciplina
filosofica che è la filosofia della scienza (si veda, infra, §§ 5-6). È forse
opportuno ribadire che questo articolo non intende certo fornire una
risposta alle domande “Che cos’è la filosofia?” e “Che cos’è la scienza
in generale?”, ma solo mettere in evidenza la relazione che intercorre
tra le proprie convinzioni metafilosofiche e la propria concezione
della filosofia della scienza, affinché sia possibile valutare la posizione
difesa da un dato autore anche valutando se ciò che asserisce in ambi-
to metafilosofico è coerente con la concezione della filosofia della
scienza che professa. Per potere rispondere filosoficamente alla doman-
da su cosa sia la scienza in generale, infatti, bisogna avere comunque
9
N. Ballantyne, Knowing Our Limits, cit., cap. 1.
168Metafilosofia e filosofia della scienza
già risposto filosoficamente alla domanda su cosa sia la filosofia, sep-
pure in modo abbozzato. Solo a partire da una certa idea di filosofia
sarà possibile rispondere filosoficamente alla domanda se esista o
meno qualcosa come la scienza in generale. A seconda di quale sia la
propria idea di filosofia, diverse risposte a tale domanda sono possibi-
li. E a seconda della risposta che si dà a tale domanda, la concezione
della filosofia della scienza che si può coerentemente adottare varia
corrispondentemente. Se si ritiene che qualcosa come la scienza in
generale esista, ad esempio, allora avrà senso parlare di filosofia della
scienza generale come di una legittima sotto-disciplina della filosofia
della scienza. Se, di contro, si ritiene che non esista qualcosa come
la scienza in generale, allora la filosofia della scienza non potrà che
ridursi alla sommatoria delle singole filosofie delle diverse discipline
scientifiche, come la filosofia della biologia, la filosofia della chimica,
la filosofia della matematica, ecc., che hanno assunto una fisionomia
disciplinare riconoscibile negli ultimi decenni 10.
La riflessione metafilosofica è quindi indispensabile per definire
la propria concezione della filosofia della scienza, ovvero per cerca-
re di rispondere alla domanda su cosa sia la filosofia della scienza.
L’indagine metafilosofica applicata a tale ambito della filosofia,
ovvero l’indagine filosofica volta a indagare cosa sia la filosofia della
scienza, può essere perciò definita “metafilosofia della scienza”.
Se dobbiamo ritenere che ci siano dei tratti comuni a tutte le disci-
10
Se la filosofia della scienza generale possa ancora essere ritenuta un ambito legit-
timo della ricerca filosofica è tema assai dibattuto nell’ambito della filosofia della
scienza. A partire dalla fine del predominio dell’empirismo logico, infatti, l’idea
che possa parlarsi di “scienza” come di un fenomeno unitario e omogeneo è stata
messa sempre più in discussione. Si veda, ad esempio, J. Dupré, Miracle of Monism,
in M. De Caro-D. Macarthur (eds.), Naturalism in Question, Harvard University Press,
Cambridge (MA) 2004, pp. 36-58. Parallelamente, anche l’idea che possa svolgersi
una riflessione filosofica adeguata sulla scienza in generale è stata messa in discus-
sione. Si veda, ad esempio, P. Kitcher, Toward a Pragmatist Philosophy of Science,
«Theoria» 77 (2013), pp. 185-231, in cui Kitcher critica la filosofia della scienza gene-
rale come inadeguata e sostiene la necessità di condurre ricerche filosofiche solo
nell’ambito delle filosofie delle discipline scientifiche particolari. Contro questa
prospettiva, si vedano, ad esempio, i seguenti due scritti di Psillos: S. Psillos, What
is General Philosophy of Science?, «Journal for General Philosophy of Science» 43
(2012), pp. 93-103; S. Psillos, Having Science in View: General Philosophy of Science and
its Significance, in P. Humphreys (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Science,
Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 137-160, in cui vengono difese l’utilità e
l’indispensabilità della ricerca nell’ambito della filosofia della scienza generale.
169Fabio Sterpetti
pline scientifiche, così che si possa legittimamente parlare di scienza
in generale, è questione che pertiene alla filosofia della scienza. Se
dobbiamo ritenere che per rispondere a tale questione si debba pre-
liminarmente rispondere alla domanda su cosa sia la filosofia e su
quale relazione sussista tra la filosofia e la scienza, è questione che
pertiene alla metafilosofia della scienza. Ad esempio, se si ritiene
che la filosofia e la scienza non siano continue, ma anzi che siano
nettamente distinte per ciò che riguarda oggetti e metodi di indagine,
come di norma ritengono coloro che adottano una concezione meta-
filosofica non naturalista (su cui si veda, infra, § 3), allora è possibile
che esistano le filosofie delle diverse discipline scientifiche e qual-
cosa come la filosofia in generale, senza che esista qualcosa come la
scienza in generale. Di contro, se si ritiene che la filosofia e la scienza
siano continue e non nettamente distinguibili in quanto a oggetti e
metodi di indagine, come di norma ritengono coloro che adottano
una concezione metafilosofica naturalista (su cui si veda, infra, § 3),
allora è più difficile difendere la tesi secondo cui esistono le filosofie
delle diverse discipline scientifiche e qualcosa come la filosofia in
generale, ma non esiste qualcosa come la scienza in generale.
Nell’ambito della ricerca in merito all’esistenza della scienza in
generale assume un ruolo centrale la ricerca sul metodo della scien-
za 11, dato che determinare se sia uno stesso metodo che viene utiliz-
zato da tutte le discipline scientifiche o meno è stato da sempre visto
come il modo più immediato di determinare se sia possibile parlare
in termini unitari di scienza o meno. Ma la ricerca sul metodo non è
rilevante solo in relazione alla questione se esista qualcosa come la
scienza in generale. Assumendo che la continuità tra la filosofia e la
scienza possa essere determinata dall’identità del metodo che viene
utilizzato nella filosofia e nella scienza 12, per potere rispondere filo-
soficamente alla domanda se la scienza e la filosofia siano continue
o meno, bisogna avere già risposto filosoficamente alla domanda su
quale sia il metodo della scienza, altrimenti sarebbe impossibile com-
parare il metodo della scienza e il metodo che si ritiene sia il metodo
11
Sulla rilevanza della riflessione sul metodo per determinare se la scienza possa
essere considerata un fenomeno unitario, si veda B. Hepburn-H. Andersen,
Scientific Method, in E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021
https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/scientific-method/ [20.09.2021].
12
È questa la tesi difesa, ad esempio, dalla concezione euristica della conoscenza, su
cui si veda C. Cellucci, Rethinking Knowledge: The Heuristic View, Springer, Cham 2017.
170Metafilosofia e filosofia della scienza
della filosofia e valutare se tale metodo sia lo stesso metodo o meno.
Quale risposta si dà a domande come quella circa quale sia il metodo
della scienza ha perciò un’estrema rilevanza per la definizione della
propria concezione metafilosofica, dato che la tesi della continuità
tra la scienza e la filosofia, seppure possa essere specificata in modi
diversi, è di norma comunque ritenuta una tesi caratteristica di quel-
le concezioni metafilosofiche che possono essere definite, in senso
ampio, naturaliste 13. Rispondere alla domanda su quale sia il metodo
della scienza svolge quindi un ruolo chiave nelle valutazioni delle
affermazioni fatte in merito alla continuità o alla discontinuità tra la
filosofia e la scienza, ovvero in merito a una delle distinzioni metafi-
losofiche fondamentali.
La ricerca in merito a questioni come quale sia il metodo della
scienza e se vi sia un solo metodo valido per tutte le scienze, è di
norma ritenuta essere appannaggio della filosofia della scienza
generale. È difficile, quindi, stabilire una priorità teorica assoluta
tra metafilosofia e filosofia della scienza, dato che la definizione di
alcune questioni centrali per ognuna di esse svolge un ruolo cruciale
nella definizione di alcune questioni centrali per l’altra. È importan-
te, dunque, far procedere la riflessione su cosa sia la scienza e su cosa
sia la filosofia della scienza di pari passo con la riflessione metafilo-
sofica, così come pure tenere conto della relazione che sussiste tra la
metafilosofia e la concezione che si adotta della filosofia della scienza
nel momento in cui si procede all’analisi di una data proposta teorica
nell’ambito della filosofia della scienza.
3. Che cos’è la metafilosofia?
Prima di cercare di chiarire, nei prossimi paragrafi, come la risposta
alla domanda su cosa sia la filosofia della scienza non possa che pas-
sare dall’analisi delle risposte che si danno alle domande “Che cos’è
la filosofia?” e “Che cos’è la scienza?”, basandoci su alcune delle prin-
cipali risposte che a tali domande sono state fornite nel XX secolo 14,
13
Sulla tesi quiniana della continuità tra scienza e filosofia come tesi caratteriz-
zante il naturalismo, si veda, ad esempio, M. Morganti, Naturalism and Realism in
the Philosophy Science, in K. J. Clark (ed.), The Blackwell Companion to Naturalism,
Blackwell, Oxford 2016. pp. 75-90.
14
In questo articolo, il cui scopo principale è mostrare la rilevanza reciproca della
171Fabio Sterpetti
è opportuno soffermarsi in questo paragrafo a chiarire alcuni aspetti
relativi a cosa debba intendersi per metafilosofia. Una definizione
classica della metafilosofia è quella fornita da Rescher, secondo cui
la «metafilosofia è l’esame filosofico della pratica stessa del filosofare.
Il suo scopo ultimo è quello di studiare i metodi della disciplina nel
tentativo di chiarirne l’impegno e le prospettive» 15.
Secondo Rescher, la metafilosofia ha due dimensioni, non del
tutto separabili: una dimensione “storica”, che si occupa di quello
che i vari filosofi hanno detto sulla natura e il metodo dell’indagine
filosofica, e una dimensione “normativa”, che dovrebbe occuparsi di
giudicare in modo sistematico e da una prospettiva teoretica quale
sia il modo corretto di definire la natura dell’indagine filosofica e il
suo metodo 16. Di recente, però, alcuni autori, come Williamson, per
indicare il medesimo ambito della riflessione filosofica preferiscono
parlare di “filosofia della filosofia”. Secondo Williamson, «il com-
pito primario della filosofia della filosofia è quello di comprendere
metafilosofia per la filosofia della scienza e della filosofia della scienza per la
metafilosofia, ci limiteremo a considerare solo alcune delle risposte che sono state
date alle domande “Che cos’è la filosofia?” e “Che cos’è la scienza?” nel XX secolo
nell’ambito della tradizione analitica, sia per ragioni di spazio e di competenza, sia
perché la filosofia della scienza ha acquisito una sua autonomia disciplinare solo
nel XX secolo e perché cruciale per il suo sviluppo è stato l’empirismo logico, che
appartiene a tale tradizione. Sull’origine novecentesca della filosofia della scienza,
cfr., ad esempio, J. Pfeifer-S. Sarkar, The Philosophy of Science: An Introduction, in S.
Sarkar-J. Pfeifer (eds.), The Philosophy of Science: An Encyclopedia, Routledge, New
York 2006, pp. xi-xxvi, p. xi: «La filosofia della scienza è emersa come una sotto-
disciplina della filosofia riconoscibile solamente nel XX secolo. La possibilità di
una tale sotto-disciplina è il risultato della separazione disciplinare e istituzio-
nale della filosofia dalle scienze successiva all’Illuminismo». Su questo, si veda
anche P. Machamer, A Brief Historical Introduction to the Philosophy of Science, in P.
Machamer-M. Silberstein (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science,
Blackwell, Oxford 2002, pp. 1-17.
15
N. Rescher, Philosophical Dialectics: An Essay on Metaphilosophy, State University of
New York Press, Albany (NY) 2006, p. 1. Per una recente introduzione alla metafilo-
sofia, si veda S. Overgaard-P. Gilbert-S. Burwood, An Introduction to Metaphilosophy,
Cambridge University Press, Cambridge 2013.
16
Cfr. N. Rescher, Metaphilosophy: Philosophy in Philosophical Perspective, Lexington
Books, Lahnam (MD) 2014. I filosofi hanno da sempre riflettuto sulla natura della
filosofia, almeno fin dai tempi di Platone, ma è negli ultimi decenni del Novecento
che la metafilosofia si è venuta configurando come una disciplina filosofica speciali-
stica in ambito accademico ed editoriale, al pari della filosofia della biologia o della
filosofia della matematica. Ad esempio, nel 1970 vede la luce la prima rivista intera-
mente dedicata a tale disciplina, ovvero Metaphilosophy. Su questo, si veda ibidem.
172Metafilosofia e filosofia della scienza
la filosofia» 17, non quello di svolgere un ruolo normativo nei con-
fronti della filosofia, nello stesso modo in cui il compito primario
della filosofia della scienza è comprendere la scienza, non impartire
prescrizioni alla scienza e agli scienziati. Ciò spinge Williamson a
rifiutare «la parola “metafilosofia”. La filosofia della filosofia è auto-
maticamente parte della filosofia, proprio come la filosofia di ogni
altra cosa, mentre metafilosofia suona come se si potesse cercare di
guardare alla filosofia dall’alto verso il basso» 18.
Questo tipo di preoccupazione è spesso condivisa da coloro che
ritengono che l’appartenenza alla filosofia della riflessione sulla filo-
sofia sia un tratto del tutto peculiare della filosofia 19. La tesi per cui
la filosofia della filosofia non possa che far parte della filosofia viene
di solito ricondotta all’argomento fornito nel Protreptico da Aristotele,
per cui se dobbiamo filosofare, dobbiamo filosofare e se non dobbia-
mo filosofare, dobbiamo ugualmente filosofare, perché per argomen-
tare a favore della tesi per cui non si deve filosofare non potremmo
che filosofare. E questo perché ogni indagine argomentata e raziona-
le non può che essere filosofia 20. A maggior ragione non può, quindi,
che essere filosofia ogni indagine argomentata e razionale sulla filo-
sofia 21. Tale posizione, sia pure a prima vista condivisibile, rischia di
essere problematica nella misura in cui sembra riconoscere una sorta
di unicità alla filosofia senza fornire una giustificazione realmente
17
T. Williamson, The Philosophy of Philosophy, Blackwell, Oxford 2007, p. ix.
18
Ibidem. Tale rifiuto dell’idea che la metafilosofia sia una sorta di filosofia di ordine
superiore può essere fatto risalire a Wittgenstein. Cfr., ad esempio, L. Wittgenstein,
Ricerche filosofiche, trad. it. di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1967, p. 69: «121. Si
potrebbe pensare: se la filosofia parla dell'uso della parola “filosofia”, dev’esserci
una filosofia di secondo grado. Ma non è affatto così; il caso corrisponde piuttosto
a quello dell'ortografia, la quale deve occuparsi anche della parola “ortografia”,
ma non per questo è una parola di secondo grado». Su questo, si veda D. Marconi,
Introduzione, in L. Wittgenstein, La filosofia, a cura di D. Marconi, trad. it. di M.
Andronico, Donzelli, Roma 2006 2, pp. vii-xxxviii, spec. pp. xxv-xxvi.
19
Si veda, ad esempio, F. Laudisa, Naturalismo: Filosofia, scienza, mitologia, Laterza,
Roma-Bari 2014, p. 5, n. 1.
20
Per il noto argomento aristotelico, si veda Aristotele, Protreptico, in Id., Opere, a
cura di G. Giannantoni, vol. XI, Laterza, Roma-Bari 1973, pp. 133-168, specialmente
il frammento n. 4 (p. 135), che traduce la formulazione dell’argomento riportata da
Elia di Alessandria, su cui si veda Elia di Alessandria, Eliae in Porphyrii Isagogen
et Aristotelis Categorias commentaria, edidit A. Busse, in Commentaria in Aristotelem
Graeca, vol. XVIII, p. 1, Reimer, Berlin 1900, p. 3, 19-23.
21
Per un esempio di tale linea argomentativa, si veda N. Rescher, Metaphilosophy, cit.
173Fabio Sterpetti
adeguata di tale unicità. Brutian, ad esempio, scrive che «mentre la
metapsicologia non è psicologia, la metasociologia non è sociologia, e
la metastoria non è storia, e così via, non è così nel caso della filosofia.
La metafilosofia è filosofia» 22, e questo perché la filosofia «differisce
dalle altre teorie anche perché è una teoria autoriflessiva» 23. Allo
stesso modo, Rescher scrive che un tratto peculiare della metafilo-
sofia «è che essa costituisce una parte della stessa filosofia. Questa è
una caratteristica unica di tale attività: la filosofia della biologia non
è parte della biologia, la filosofia della matematica non è una parte
della matematica» 24. Ma perché la capacità di riflettere su di sé di una
disciplina, di riflettere cioè sui propri fondamenti o sul proprio meto-
do, dovrebbe essere appannaggio esclusivo della filosofia? E perché
dovrebbero essere proprio i filosofi a stabilirlo?
Il punto delicato dell’argomento illustrato sopra con cui di norma
i filosofi sostengono la tesi dell’unicità della capacità della filosofia di
riflettere su sé stessa, è il passaggio apparentemente innocuo con cui
si connette l’argomento del Protreptico, per cui anche chi intendesse
negare la filosofia starebbe così facendo filosofia, alla tesi per cui solo
la filosofia sarebbe capace di riflettere su sé stessa. Chi compie tale
manovra tralascia il fatto che ai tempi di Aristotele, e fino almeno
alla Rivoluzione scientifica, la filosofia non era separata dall’inda-
gine scientifica nel modo in cui si ritiene lo sia adesso 25. Utilizzare,
quindi, l’argomento del Protreptico, teso a difendere l’ineludibilità
dell’indagine argomentata e razionale nel senso più ampio, tale cioè
da includere quella che oggi chiameremmo l’indagine scientifica, per
sostenere la tesi secondo cui oggi la filosofia, intesa come disciplina
accademica professionalizzata ben distinta dalle scienze, sarebbe la
sola disciplina capace di riflettere su sé stessa, appare più un’abile
manipolazione retorica, basata sullo slittamento di significato che
22
G. Brutian, Metaphilosophy in the Systems of Metatheories, «Metaphilosophy» 43 (2012),
pp. 294-305, p. 305.
23 Ibidem.
24
N. Rescher, Metaphilosophy, cit., p. xi.
25
Cfr., ad esempio, S. Overgaard-P. Gilbert-S. Burwood, An Introduction to Metaphilos-
ophy, cit., p. 19: «Platone e Aristotele […] consideravano come paradigmaticamente
filosofiche alcune domande che oggi non sarebbero affatto considerate essere di
pertinenza del filosofo. […]. ‘Filosofia’ aveva grosso modo lo stesso significato che i
termini ‘indagine razionale’ o ‘scienza’ hanno oggi per noi»; H.-G. Gadamer, La ragio-
ne nell’età della scienza, trad. it. di A. Fabris, Il Melangolo, Genova 1999, p. 27: «I Greci
designarono col nome generico di filosofia ogni sorta di sapere teorico».
174Metafilosofia e filosofia della scienza
il termine “filosofia” ha subito nel tempo, che non un argomento
davvero cogente a difesa della tesi per cui solo la filosofia attuale può
legittimamente riflettere su sé stessa 26. Sembra perciò del tutto pos-
sibile ribadire oggi l’ineludibilità del filosofare lungo le linee dell’ar-
gomento aristotelico, senza che questo implichi accettare la tesi
secondo la quale la filosofia come è attualmente intesa e praticata sia
l’unica disciplina che possa legittimamente riflettere su sé stessa. Non
è ben chiaro, infatti, perché dovremmo pensare che chi riflette, ad
esempio, sulla biologia stia necessariamente facendo “filosofia della
biologia”, ovvero filosofia e non biologia, dato che la filosofia della
biologia è “automaticamente” una parte della filosofia e non della
biologia. Non potremmo pensare piuttosto che chi riflette sulla filo-
sofia stia facendo filosofia nello stesso modo in cui chi riflette sulla
26
Si potrebbe obiettare che tale argomento non è corretto perché ciò che «noi oggi
chiamiamo ‘scienza’ in gran parte non sarebbe potuto affatto rientrare nell’uso
che i Greci facevano della parola philosophia», ma sarebbe stato piuttosto da loro
rubricato come «istoria, cioè un insieme di cognizioni acquisito con l’esperienza», o
tutt’al più equiparato a quel «sapere che rende possibile una produzione, la poietike
episteme, o techne» (H.-G. Gadamer, La ragione nell’età della scienza, cit., p. 32). Ora, è
vero che se la scienza odierna non fosse accomunabile a quel tipo di indagine razio-
nale che i Greci ritenevano fosse la filosofia, allora l’argomento qui proposto non
sarebbe corretto. Ma è tutt’altro che ovvio che una concezione della scienza come
quella gadameriana, secondo cui la gran parte della scienza attuale non sarebbe
che mera techne, sia da condividere. La riduzione delle scienze naturali all’elemento
osservativo o sperimentale, e la loro assimilazione alle applicazioni tecniche che
rendono possibili, non rende infatti affatto giustizia del rilevante e ineliminabile
portato teorico che invece caratterizza ogni disciplina scientifica, come è oramai
largamente riconosciuto non solo dalla stragrande maggioranza dei filosofi della
scienza, ma anche da tutti quei filosofi che, pur operando in altri domini dell’in-
dagine filosofica, intrattengono un rapporto non pregiudizialmente ostile col
pensiero scientifico. Per una breve introduzione al dibattito sull’irriducibilità delle
teorie scientifiche al piano dell’esperienza, si veda N. M. Boyd-J. Bogen, Theory and
Observation in Science, in E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
2021, https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/science-theory-observa-
tion/ [20.09.2021]. Per un esempio di filosofo non ostile al pensiero scientifico, si
veda P. Parrini, Fare filosofia oggi, Carocci, Roma 2018. Una concezione come quella
gadameriana, secondo cui la maggior parte delle scienze naturali non sarebbe che
mera techne, è quindi più sintomatica del modo in cui una parte rilevante dei filo-
sofi del Novecento ha guardato alla scienza, che realmente capace di supportare la
tesi per cui le conoscenze fornite dalle attuali scienze naturali non sarebbero state
ritenute dai Greci assimilabili alle conoscenze che secondo loro la filosofia ambiva
ottenere. L’obiezione in esame, quindi, non sembra essere adeguata.
175Fabio Sterpetti biologia stia facendo biologia? 27 Ciò non significa negare che esista la filosofia della biologia in senso accademico e disciplinare, con il suo insieme caratteristico di temi, problemi e autori di riferimento, né si intende negare che chi pratica la filosofia della biologia stia facendo filosofia. Quel che si intende sottolineare è che la concezione secondo cui ogni riflessione teoretica su una qualunque disciplina, anche se sviluppata del tutto internamente a tale disciplina, ovvero ogni meta- teoria, sia ipso facto filosofia non può che apparire come il retaggio di una postura arrogante assunta per secoli dalla filosofia nei confronti delle discipline scientifiche che si venivano da lei differenziando, una postura che, alla luce dei contributi fondamentali forniti da coloro che praticano discipline non filosofiche alla definizione della nostra attuale visione del mondo – basti solo pensare ai lavori dei fisici teori- ci, dei matematici, dei genetisti e dei neuroscienziati del XX secolo –, risulta oggi sempre più inadeguata e difficile da giustificare. Si tratta, in fondo, della perpetuazione del pregiudizio heideggeriano secondo cui la scienza non pensa, perché la ragione scientifica è meramen- te calcolistica e meccanica, mentre il pensiero riflessivo e creativo è appannaggio esclusivo del filosofo, per cui se qualcuno pensa in modo teoretico e originale non può che farlo all’interno della filoso- fia 28. Ciò che appare sempre più difficile da giustificare è l’asimme- tria che una concezione del genere instaura a favore della filosofia rispetto alle altre discipline: dato che spesso i mutamenti concettuali fondamentali per l’elaborazione di nuove teorie scientifiche nascono proprio da un’analisi metateorica dei concetti fondamentali di una data disciplina, se quando si conduce una tale analisi metateorica si fa automaticamente filosofia, ciò significa che gli avanzamenti così prodotti andranno imputati alla filosofia, e che colui che li ha prodot- 27 Non si vuole qui riproporre la tesi di O. Neurath, Fisicalismo, in Id., La fisica del mondo, trad. it. di N. Zippel, Castelvecchi, Roma 2015, pp. 38-47 (ed. or. 1931), secondo cui la fondazione concettuale di ogni disciplina scientifica è compito esclusivo degli scienziati e non già appannaggio esclusivo dei filosofi (come sostenuto invece, ad esempio, da M. Schlick, Tra realismo e neopositivismo, trad. it. di E. Picardi, Il Mulino, Bologna 1974), e che quindi nulla resti alla filosofia di sensato da dire in merito, ma solo ribadire che la riflessione sui fondamenti concettuali di una disciplina scien- tifica non è appannaggio esclusivo dei filosofi. Sullo scientismo di Neurath, si veda P. Parrini, Crisi del fondazionalismo, giustificazione epistemica e natura della filosofia, «Iride» XIII (2000), pp. 237-258. 28 P. Parrini, Fare filosofia oggi, cit., cap. 2. 176
Metafilosofia e filosofia della scienza
ti potrà e dovrà essere detto “filosofo” 29, indipendentemente dalla sua
formazione e appartenenza accademica o professionale. Il “bilancio”
del contributo fornito dalla filosofia al progresso della conoscenza
umana risulterebbe così sempre in attivo in un modo che potremmo
definire “parassitario”, ovvero non dovuto esclusivamente ai meriti
di coloro che praticano professionalmente la disciplina. La filosofia
potrebbe intestarsi, infatti, i risultati più innovativi di ogni disciplina
anche qualora nessuno di coloro che la praticano professionalmente
vi avesse fornito alcun contributo reale. E, soprattutto, potendo la
filosofia come disciplina in questo modo rivendicare un contributo
costante all’avanzamento della conoscenza, coloro che la praticano
professionalmente potrebbero non sentire l’esigenza di rispondere,
a sé stessi e al resto della comunità, degli eventuali esigui progressi
imputabili al loro diretto contributo all’avanzamento della conoscen-
za, e non sentire, quindi, l’esigenza di problematizzare il modo in cui
la filosofia negli ultimi decenni si è venuta configurando come discipli-
na accademica e come professione.
Il rischio che la riflessione condotta dagli attuali filosofi di profes-
sione sul contributo offerto dalla filosofia attuale al progresso della
conoscenza possa prendere questa china autoassolutoria e “asimme-
trica” appare evidente quando si guardi a quali siano i presunti pro-
gressi ottenuti dalla filosofia che quei filosofi che hanno una visione
ottimistica dello “stato di salute” della filosofia attuale portano come
esempi a sostegno della loro visione. A sostegno di un tale ottimismo,
infatti, spesso si portano risultati che non sono in realtà frutto del
lavoro di filosofi di professione in senso stretto. Ad esempio, Marconi
sostiene che uno dei più grandi successi ottenuti dalla filosofia ana-
litica nel Novecento sia stato quello di aver stabilito che la verità non
coincide con la dimostrabilità 30. Ma, come scrive Cellucci, un tale
notevole risultato, che non è altro che il primo teorema di incom-
pletezza di Gödel 31, è forse più correttamente da ascrivere alla logica
29
Si pensi, ad esempio, al lavoro di revisione e raffinamento concettuale di concetti
come “spazio”, “tempo”, “simultaneità”, operato da Einstein nell’elaborazione della
teoria della relatività, su cui si vedano A. Fine, The Shaky Game: Einstein, Realism,
and the Quantum Theory, The University of Chicago Press, Chicago 1986; F. Laudisa,
Albert Einstein e l’immagine scientifica del mondo, Carocci, Roma 2015.
30
D. Marconi, Il mestiere di pensare, Einaudi, Torino 2014, p. 90.
31
Sulla dimostrazione della non coincidenza tra verità e dimostrabilità, cfr. C.
Cellucci, Perché ancora la filosofia, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 89: «il concetto di
verità come dimostrabilità è inadeguato perché, in base a esso, un enunciato del
177Fabio Sterpetti matematica del Novecento, che è «una branca convenzionale, anche se un po’ marginale, della matematica» 32, piuttosto che alla filosofia analitica 33. Che i filosofi di professione che intendono indicare dei grandi successi della filosofia attuale citino risultati non ascrivibili a filosofi di professione, non è un segnale rassicurante della fecon- dità del lavoro teoretico svolto dagli attuali filosofi di professione. Ovviamente, non si intende affatto qui sostenere che “veri” filosofi siano solo coloro che praticano la filosofia professionalmente, e che i risultati davvero filosofici siano solo quelli prodotti dai filosofi di professione, e che quindi dovremmo considerare come non filosofici i contributi prodotti da coloro che non sono filosofi di professione, tutt’altro 34. Né si intende sminuire il lavoro svolto dagli attuali filosofi linguaggio dell’aritmetica, per esempio, è vero se e solo se ne esiste una dimostra- zione, dove che cosa può contare come sua dimostrazione è specificato dalla teoria del significato per il linguaggio dell’aritmetica. Ora, la teoria del significato per tale linguaggio deve specificare il significato del concetto di numero naturale, e questo è specificato dagli assiomi dell’aritmetica di Peano del secondo ordine perché essi sono categorici, cioè hanno, a meno di isomorfismi, un unico modello – appunto, i numeri naturali. Ma, sebbene il significato del concetto di numero naturale sia specificato dagli assiomi dell’aritmetica di Peano del secondo ordine, per il primo teorema di incompletezza di Gödel esiste un enunciato dell’aritmetica che è vero ma non è dimostrabile a partire dagli assiomi dell’aritmetica di Peano del secondo ordine. Tale enunciato fornisce un esempio di proposizione che è vera ma per la quale non esiste una dimostrazione del tipo specificato dalla teoria del significato per il linguaggio a cui appartiene la proposizione. Dunque la verità non coincide con la dimostrabilità». 32 C. Cellucci, Philosophy at a Crossroads: Escaping from Irrelevance, «Syzetesis» V (2018), pp. 13-53, p. 47. 33 Anche qualora si sostenesse che la logica matematica è tanto legittimamente parte della matematica quanto della filosofia, poiché la logica matematica può essere con- siderata parte della logica e la logica è parte della filosofia, comunque ciò non giusti- ficherebbe l’attribuzione del risultato di Gödel alla filosofia analitica, per come questa è intesa e praticata dai filosofi di professione, dato che Gödel non può essere certo considerato un filosofo analitico di professione, né egli ha mai mostrato eccessiva stima per tale tradizione filosofica. Si veda C. Cellucci, Philosophy at a Crossroads, cit. 34 Sull’idea che il filosofo non possa essere davvero un professionista, ma debba rimanere, in un certo senso, un dilettante, cfr. C. Cellucci, Perché ancora la filosofia, cit., p. 33: «Il filosofo non è un professionista nel senso in cui lo sono il matematico, il fisico o il biologo, perché non ha un campo suo specifico da indagare. Né è un professionista nel senso in cui lo sono il medico, l’avvocato o l’ingegnere, perché non ha tecniche sue specifiche da applicare. La sua indagine si muove su un terreno inesplorato, su cui non esiste ancora un sapere consolidato. Nel far ciò egli non ha alcuna professionalità ereditata su cui contare. Perciò egli è, e sempre rimarrà, un grande dilettante». Per una visione della filosofia del tutto opposta, si veda D. Marconi, Il mestiere di pensare, cit. 178
Metafilosofia e filosofia della scienza
di professione. Ma solo si intende sostenere che non ci si può appro-
priare del lavoro filosofico o metateorico svolto dai non filosofi per
giustificare una concezione “egemonica” della filosofia attuale rispetto
alle altre discipline. In altre parole, il lavoro dei non filosofi non può ser-
vire ai filosofi di professione per innalzarsi “senza sforzo” al di sopra
di tutti coloro che praticano altre discipline. Soprattutto se si pensa
che normalmente i filosofi di professione ritengono che nessuno
tranne i filosofi stessi possa valutare il loro lavoro, secondo l’idea per
cui, dato che la metafilosofia è parte della filosofia, e che per valutare
la filosofia si fa della metafilosofia, valutare la filosofia è un lavoro
filosofico, che può quindi essere svolto solo da filosofi di professione,
gli unici attrezzati per svolgere un tale lavoro; e che, di contro, dato
che il pensiero teoretico è appannaggio dei filosofi, e che se qualcuno
riflette su una qualsiasi disciplina non filosofica sta comunque facen-
do filosofia, solo il filosofo di professione sia titolato a valutare se una
determinata riflessione metateorica di un non filosofo possa o meno
essere qualificata come genuinamente filosofica. Continuare ancora
oggi ad autoassegnarsi una tale posizione di supremazia, senza pote-
re addurre una giustificazione teoretica di tale presunta supremazia
davvero convincente, o senza potere esibire risultati teorici tali da sur-
classare in valore quelli di ogni altra disciplina, ma potendo spesso
quasi solo ammantarsi del prestigio della grande tradizione filosofica
del passato e appropriarsi in modo “automatico” dei risultati teorici
ottenuti da coloro che praticano altre discipline, non solo non riesce
a restituire un’immagine adeguata dell’indagine filosofica e del lavo-
ro svolto quotidianamente con impegno dai filosofi di professione
attuali, ma rischia anche di non riuscire a trasmettere il tormento
interiore e intellettuale con cui molti filosofi di professione vivono le
difficoltà che incontrano nel cercare di giustificare, prima di tutto a
sé stessi, la legittimità e la bontà del proprio lavoro, l’incertezza con
cui guardano all’affidabilità degli esiti delle proprie ricerche, che li
spinge a continuare a cercare di capire quale davvero sia, o dovrebbe
essere, il metodo e l’oggetto del proprio ricercare, nonché di esporli
alle critiche di coloro che praticano le discipline non filosofiche,
come gli scienziati 35, che ovviamente mal tollerano la supremazia teo-
35
Sulle critiche mosse da molti scienziati alla filosofia contemporanea, si vedano,
ad esempio, C. Cellucci, Philosophy at a Crossroads, cit.; S. Overgaard-P. Gilbert-S.
Burwood, An Introduction to Metaphilosophy, cit.; C. Rovelli, Physics Needs Philosophy.
Philosophy Needs Physics, «Foundations of Physics» 48 (2018), pp. 481-491.
179Fabio Sterpetti
retica che viene rivendicata da alcuni filosofi, ma da questi di norma
non adeguatamente giustificata.
Di fronte a tali critiche, spesso tanto aspre quanto ingenuamente
argomentate, o meglio, non argomentate in modo tanto sofisticato
quanto quello di cui sarebbe capace un professionista della filosofia
attuale, che vede, specialmente in ambito analitico, nella costruzione
di argomentazioni sottili e intricate quasi la caratteristica peculiare
della propria attività intellettuale, l’atteggiamento dominante tra i
filosofi è di chiusura e di spostamento del fuoco della discussione: si
cerca quasi sempre di smontare le critiche mosse alla filosofia attuale
dai non filosofi concentrandosi sulle ingenuità filosofiche riscontra-
bili nelle argomentazioni proposte contro la filosofia attuale, e quasi
mai di confrontarsi o con la tesi che tali critiche sostengono, ovvero
l’irrilevanza del lavoro filosofico attuale per la riflessione scientifica e
per l’avanzamento della conoscenza più in generale, o con la motiva-
zione di fondo che spinge alcuni scienziati a sostenere tale tesi 36. Tale
tesi dell’irrilevanza della filosofia attuale viene sostenuta da alcuni
scienziati, infatti, proprio a causa della discrepanza che percepiscono
tra quelle che sono le pretese teoriche avanzate dai filosofi attuali e i
contributi che vengono effettivamente offerti da questi all’avanzamen-
to della conoscenza. E una tale tesi e una tale motivazione meritereb-
bero, invece, di essere meditate a fondo dai filosofi di professione, poi-
ché investono la stessa ragion d’essere della filosofia come disciplina
accademica. Una difesa corporativa di corto respiro potrà forse sbef-
feggiare lo scienziato critico della filosofia di turno nei circoli ristretti
dei filosofi di professione, seppellendolo sotto una serie di obiezioni
argute e sofisticate che stigmatizzino l’ingenuità di alcuni punti della
sua argomentazione, o sotto una valanga di erudizione che metta in
luce le lacune della sua formazione umanistica e della sua conoscenza
storica, ma non risolverà certo il problema della percezione ampia e
diffusa dell’irrilevanza della filosofia attuale tra molti di coloro che
attualmente contribuiscono al progresso della conoscenza e all’ela-
borazione della nostra visione del mondo, un problema che non può
che essere grave per una disciplina che porta iscritto l’amore per la
sapienza e la sete di conoscenza nel suo stesso nome.
Si pensi, ad esempio, al modo in cui molti filosofi della scienza
rispondono alla tesi dell’irrilevanza della filosofia per la scienza. Si cita
il caso di un grande scienziato che ha riconosciuto un debito intellet-
36
C. Cellucci, Philosophy at a Crossroads, cit.
180Puoi anche leggere