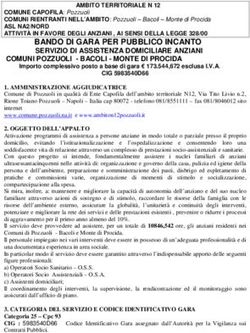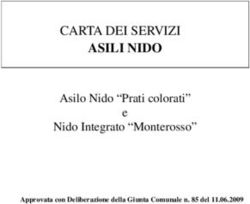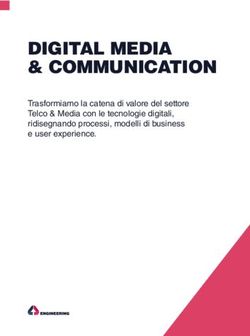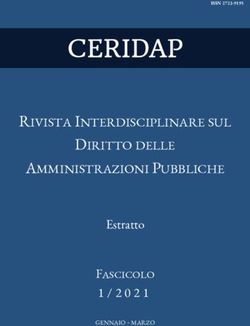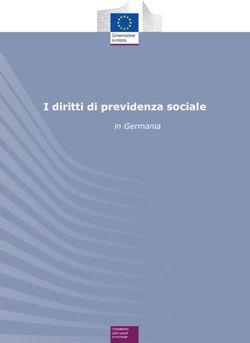LA NATURA GIURIDICA DELLA CONCESSIONE E L'INCIDENZA DEL DIRITTO EUROPEO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Capitolo 1
LA NATURA GIURIDICA DELLA CONCESSIONE
E L’INCIDENZA DEL DIRITTO EUROPEO
SOMMARIO: 1. Il dibattito sulla natura giuridica dell’istituto: provvedimento o contratto? – 2. Il ser-
vizio pubblico nel diritto italiano: concezione soggettiva e oggettiva. – 3. Servizi pubblici e ser-
vizi di interesse generale. – 3.1. Il servizio come categoria generale del Trattato sulla Unione
Europea. – 3.1.1. Il concetto di servizio nel diritto comunitario e italiano. – 3.1.2. La categoria
del servizio nel diritto comunitario: servizi di interesse generale economico e non economico. –
3.1.3. La nozione di rete nel diritto comunitario. – 3.1.4. I servizi sociali e i servizi pubblici es-
senziali. – 3.1.5. Il servizio universale. – 3.2. La recente evoluzione e liberalizzazione dei servizi
nel mercato interno: la direttiva comunitaria del 12 dicembre 2006, n. 123. – 3.2.1. Attuazione
della direttiva in Italia: il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. – 4. Progressiva emersione del problema
della concessione di servizi nel diritto europeo.
1. Il dibattito sulla natura giuridica dell’istituto: provvedimento o con-
tratto?
L’espressione «concessione» è stata utilizzata nei secoli in moltissimi signifi-
cati, alcuni dei quali anche impropri e, anche se ridotta al significato tecnico, in-
dica varie figure di provvedimenti.
Il «carattere comune di tali provvedimenti è l’effetto, che è loro proprio, di
conferire a una o più persone estranee all’amministrazione nuove capacità o nuovi
poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica» 1.
1
Per questa espressione, G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958, p. 261. Si
veda anche F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, in Le con-
cessioni di servizi a cura di F. ROVERSI MONACO, Rimini, 1988, p. 25, passim. Nel testo si osserva
(p. 28), che quando si parla di provvedimenti amministrativi e, in particolare, di concessione, non si
fa riferimento a un «tipo» provvedimentale ma, bensì a una «intera categoria di fattispecie, differenti
per oggetto, per contenuto e per effetto, caratterizzata unitariamente solo per il fatto che l’Ammi-
nistrazione arricchisce di utilità la sfera giuridica del concessionario, o, secondo una diversa e più
esatta interpretazione, costituisce o trasferisce nel patrimonio giuridico del concessionario nuovi
status, nuove legittimazioni, nuove qualità o nuovi diritti». In un recente scritto, F.G. SCOCA, Il
provvedimento amministrativo, in F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2008, p.
274, l’Autore sostiene: «le condizioni in presenza delle quali si possono avere provvedimenti con-2 La concessione dei servizi
È stato talora ritenuto che i diritti derivanti dalla concessione debbano essere
propri dello Stato, o in genere della pubblica amministrazione concedente: la con-
cessione consisterebbe, in altre parole, in un trasferimento di facoltà dall’ente
pubblico al privato 2 (Zanobini).
La natura giuridica della concessione è stata a lungo dibattuta e, in dottrina,
sono state sostenute tesi differenti che hanno, di volta in volta, attribuito maggiore
rilevanza all’aspetto pubblicistico o privatistico dell’istituto.
Le principali teorie hanno definito la concessione in termini di contratto, prov-
vedimento o provvedimento-contratto; la diversa natura giuridica è legata all’evo-
luzione storica italiana e alla necessità che si è rappresentata nel corso dei secoli
di costruire un ordinamento giuridico indipendente e permanente che permettesse
al nuovo Stato unitario di consolidarsi e rafforzarsi.
L’influenza sull’istituto delle esigenze di autorità, sorte dopo l’unificazione,
può essere riscontrata nelle ricostruzioni giuridiche dei teorici del diritto i quali
formularono una teoria dello Stato posto in posizione di indipendenza, prevalenza
e sovranità rispetto ai cittadino.
La concessione amministrativa, costituendo uno strumento importante di ge-
stione della «cosa pubblica», non rimase indifferente alla trasformazione ma co-
stituì uno dei principali “campanelli di allarme” della evoluzione normativa che
passò dall’utilizzo di strumenti privatistici alla creazione di figure pubblicistiche.
Le teorie precedenti alla unificazione d’Italia infatti ricostruirono la concessio-
ne amministrativa nei termini di un contratto.
Le distinzioni tra le varie teorie non furono tuttavia mai nette 3; il passaggio da
una costruzione all’altra fu lento e diverse impostazioni si trovarono a convivere
nel medesimo periodo storico, sia perché sostenute da diversi illustri studiosi, sia
perché le diverse fattispecie di concessioni erano oggettivamente disciplinate in
modo difforme.
L’istituto della concessione nacque nella prassi delle amministrazioni pubbliche
centrali e locali come un contratto che istituiva e regolava il rapporto tra le parti.
cessori sono le seguenti: l’amministrazione è titolare di beni, di attività, ovvero di poteri esclusivi.
In ogni caso si tratta di utilitas di cui solo l’amministrazione può disporre; il privato a sua volta, ha
interesse ad acquisire tali utilitas, e pertanto ne deve fare richiesta all’amministrazione la quale si
orienterà secondo le esigenze dell’interesse pubblico».
2
Il rinvio è nuovamente a G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 261.
3
Prova della difficoltà di definire l’istituto e della convivenza di diverse teorie sono le parole di
Benvenuti il quale, spiegando la soluzione ottocentesca proposta da Otto Mayer di assorbimento del
privato nel pubblico e della «sussunzione del negozio privatistico nel così chiamato negozio di dirit-
to pubblico fondato sull’atto di imperio», utilizza proprio la concessione come esempio di istituto
emblematico. Afferma l’autore che è «tipica la ipotesi della concessione la cui comprensione ancora
oggi è incerta e finisce anche per approdare alla così detta concessione-contratto, talora costruita
come un concetto unitario, talora spezzata in due atti, l’uno autoritativo e l’altro convenzionale», F.
BENVENUTI, Il ruolo dell’amministrazione nello Stato democratico contemporaneo, in G. MARON-
GIU-G.C. DE MARTIN (a cura di), Democrazia e amministrazione, Milano, 1992, p. 13 ss. e, in parti-
colare, p. 21.La natura giuridica della concessione e l’incidenza del diritto europeo 3
La prassi ebbe origine e si diffuse in un periodo storico antecedente alla codi-
ficazione e conseguente emanazione di una normativa specifica e fu determinata
dalla capacità negoziale che era attribuita alle parti contraenti, pubbliche e private.
Pertanto, agli albori dell’istituto, non vi fu un provvedimento unilaterale di con-
cessione, ma esso veniva adottato (solo) successivamente rispetto alla stipulazio-
ne del contratto che approvava, incidentalmente, conferendogli efficacia.
La consuetudine, nata alla fine dell’800, continuò a essere seguita anche nei
primi anni del ’900, dopo la nascita della teoria delle persone giuridiche pubbli-
che. Pertanto, anche quando si iniziò a stabilire un nesso tra disposizione delle co-
se e attività pubbliche e adozione di atti amministrativi unilaterali, le pubbliche
amministrazioni e, in particolare, i Comuni continuarono ad utilizzare la prassi or-
mai consolidata, ritenendosi sufficiente approvare con un provvedimento ciò che
era già contrattato 4.
Il legislatore del novecento legiferò in materia ma non adottò atti normativi
che qualificassero tecnicamente il rapporto o contenessero determinazioni specifi-
che in ordine alla struttura degli atti costituitivi dei rapporti concessori.
La dottrina successiva (Sandulli) 5 pensò si potesse dare rilievo al provvedi-
mento – che veniva adottato in un secondo momento – che approvava il contratto
già concluso, applicando la teoria degli atti a formazione progressiva o procedi-
mentale.
Le concessioni comprendevano però rapporti assolutamente eterogenei e non
sempre interveniva un vero provvedimento di approvazione. Potevano aversi le
seguenti fattispecie: emanazione del decreto approvativo, la stipula di un atto di
sottomissione, l’inizio dello svolgimento dell’attività concessa, la consegna dei
beni demaniali oggetto di concessione, l’approvazione del progetto delle opere da
realizzare, la notifica dell’aggiudicazione 6.
Proprio l’eterogeneità dei metodi utilizzati rendeva difficile ritenere che un at-
to successivo potesse avere un ruolo determinante nella creazione degli effetti
giuridici derivanti dal contratto. Pertanto, la fonte del rapporto contrattuale fu ri-
tenuta il contratto stesso, il quale costituiva il rapporto e lo disciplinava intera-
mente poiché in esso erano contenuti la clausola concessoria, nonché i precetti di
regolazione patrimoniale e organizzativa.
Nel ricostruire la natura giuridica dell’istituto della concessione non può non
farsi riferimento, ancora una volta, al fondamentale lavoro del Ranelletti 7, pubbli-
cato alla fine del 1800, poiché costituì, come detto, il primo tentativo di costru-
zione sistematica della materia. L’Autore, utilizzando un metodo induttivo, appro-
4
M. D’ALBERTI, Concessioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, 1988, VII, ad vocem, p. 2 ss.
5
A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, (1940), Milano 1964, p. 183 ss. e p. 260 ss.
6
L’elencazione esemplificativa è tratta da M. D’ALBERTI, Concessioni amministrative, cit., p. 2 ss.
7
O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Con-
cetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., LVI, 1894, IV, p. 25.4 La concessione dei servizi
fondì l’istituto della concessione e della autorizzazione amministrativa 8.
Preliminarmente approfondì le costruzioni teoriche proposte dalla dottrina e, in
particolare, rinviò all’importante opera del Giorgi 9, non condividendone tuttavia
l’impostazione. Infatti, il Giorgi, nel proprio lavoro, analizzò diverse fattispecie di
concessione e, tra le altre, le concessioni in materia di demanio stradale 10 (es. edi-
ficare opere o lasciare depositi, anche temporanei, sulle strade, costruire dirama-
zioni dalle strade o accessi da queste ai fondi e fabbricati laterali), ed il relativo
iter procedimentale 11.
Le concessioni erano considerate come istituti aventi natura giuridica differen-
te: atti autoritari (concessioni di occupazione del suolo pubblico stradale) o atti
con carattere contrattuale (attraversamento delle strade nel soprassuolo, ponti, o
nel sottosuolo, acquedotti sotterranei). L’elemento di distinzione tra i due tipi di
concessione venne individuato «nella stipulazione per atto pubblico, sotto condi-
zioni corrispettive e per tempo determinato» 12 che caratterizzava gli atti autorita-
tivi, infatti in questo caso vi era una forma solenne di stipulazione che conferiva il
carattere pubblicistico. Pertanto, la categoria delle concessioni-contratto sarebbe
stata estesa, per il Giorgi, a tutti quei casi in cui «l’atto di concessione è accompa-
gnato da un contratto o capitolato che, imponendo obblighi e diritti reciproci, mu-
ta l’indole giuridica della concessione» 13.
La concessione venne inquadrata, in questo caso, in una figura mista, che si po-
neva tra l’atto autoritativo e il contratto, in quanto la presenza del contratto stesso
modificherebbe la «purezza» 14 dell’atto autoritativo di concessione.
8
Nella propria opera Ranelletti distingue i provvedimenti favorevoli in autorizzazioni e conces-
sioni. Osserva al riguardo F.G. SCOCA, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 270, che sulla base
della tesi di Ranelletti formulate all’inizio del diciannovesimo secolo: «con le autorizzazioni si ri-
muove un ostacolo che impedisce l’esercizio di diritti di cui il privato è già titolare; con le conces-
sioni si conferiscono al privato nuovi diritti. La distinzione è semplice e chiara, ma non è del tutto
soddisfacente, perché non è sempre vero che il privato, prima di chiedere l’autorizzazione, e per po-
terla chiedere, sia (già) titolare di un diritto soggettivo, e perché la concessione non crea sempre
nuovi diritti; ma determina l’acquisto di utilità diverse (si pensi alle onorificenze)».
9
La dottrina delle persone giuridiche, Firenze, vol. I, II, III e IV, 1890.
10
Il rinvio normativo è al regolamento di polizia stradale, R.D. 10 marzo 1881, n. 124.
11
Il procedimento per ottenere la concessione può essere così sintetizzato: presentazione della
domanda (corredata di disegni e altri documenti): l’autorità amministrativa se accorda la concessio-
ne stabilisce nel medesimo atto le condizioni e le norme a cui dovrà essere assoggettata, oltre, se-
condo i casi, il prezzo dell’occupazione o dell’uso concesso o canone annuo.
12
O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, cit., p. 44.
GIORGI propone la medesima distinzione, tra concessioni-licenze e concessioni-contratto, anche in
tema di concessioni sul demanio marittimo, in La dottrina delle persone giuridiche, III, nn. 184-186
e 371-376.
13
In merito a tale aspetto si veda, O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e con-
cessioni amministrative, cit., p. 37.
14
La citazione è tratta da O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni
amministrative, cit., p. 37.La natura giuridica della concessione e l’incidenza del diritto europeo 5
Ranelletti non riscontrò, nell’analisi del regolamento, la medesima distinzione
rilevata dal Giorgi e anzi osservò come il regolamento utilizzasse indistintamente
i termini «licenza e concessione» e che gli obblighi imposti al concessionario fos-
sero dallo stesso denominati “condizioni”.
Alla luce di queste premesse il Ranelletti ricostruì tutte le concessioni in ter-
mini di atti unilaterali, posti in essere “dalla sola attività dell’autorità che li ema-
na”, in seguito alla domanda del privato.
Il privato, con la propria dichiarazione di «valersi della concessione» o con la
partecipazione all’atto pubblico o con il «dare la cauzione», accetta la concessio-
ne con il conseguente obbligo di «rispettare tutte le condizioni» 15, ma non muta la
natura giuridica dell’istituto.
La diversa impostazione del Giorgi nella ricostruzione dell’istituto della con-
cessione può essere riscontrata anche analizzando la normativa relativa al dema-
nio fluviale 16. In ipotesi, la pubblica amministrazione propone, all’esito del pro-
cedimento, un disciplinare che è un atto «contenente le condizioni alle quali deb-
ba essere vincolata la concessione», in cui trovano un contemperamento gli inte-
ressi contrapposti. Proprio la presenza del disciplinare o contratto permise al
Giorgi di ravvedere nella concessione la presenza di due elementi, uno autoritario,
la licenza, ed uno economico, il disciplinare, che si attenuavano reciprocamente 17.
L’elemento contrattuale tempererebbe, pertanto, l’autorità del provvedimento.
Le tesi del Giorgi si fondarono su una attenta analisi della realtà e della situa-
zione economica del paese e cercarono di contemperare il metodo rigidamente
dogmatico con le «faccende di tutti i giorni» 18; tuttavia, in considerazione del pe-
riodo storico in cui furono elaborate, le teorie non ebbero largo seguito e vennero
successivamente abbandonate.
Come detto il Ranelletti non aderì alla ricostruzione elaborata dal Giorgi, poi-
ché ritenne che nell’istituto non si verificasse questo contemperamento tra gli atti,
ma permanesse una distinzione, rimanendo l’atto di concessione un atto a sé 19.
Ranelletti ritenne che proprio dall’analisi del regolamento 20 non potessero es-
15
In tal senso O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministra-
tive, cit., p. 45.
16
In particolare la concessione di derivazione di acque o di stabilire mulini sulle stesse, attività vie-
tate in assenza di concessione dell’autorità competente, legge 10 agosto 1884, n. 2644. Nell’importante
lavoro Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, il Ranelletti (p. 45), spiega
l’iter procedimentale che deve essere seguito per ottenere il rilascio della concessione e analizza in par-
ticolare il contemperamento tra l’interesse del richiedente la concessione e gli interessi dei soggetti che
sono già titolari della medesima concessione, il pubblico interesse e gli interessi dei terzi.
17
GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche, III, nn. 171 e 173, p. 352 ss.
18
Si tratta sempre di nozioni tratte dal lavoro di M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative,
Napoli, 1981, pp. 88 e 89.
19
Si veda, O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative,
cit., p. 46.
20
Regolamento per l’esecuzione del codice di marina mercantile, 20 novembre 1879, n. 5166.6 La concessione dei servizi
sere desunte fattispecie distinte, ma solo due modi differenti di nascita della con-
cessione a seconda che le condizioni di fatto da disciplinare fossero di maggiore o
minore importanza. È proprio la necessità di disciplinare queste condizioni di fat-
to e la necessità di imporre maggiori o minori obblighi al concessionario che de-
terminò l’utilizzo di una fattispecie rispetto all’altra; nel primo caso concessione-
licenza e nel secondo concessione-contratto.
La natura giuridica dell’istituito restò però invariata. Il Ranelletti ritenne infatti
che, in entrambi i casi, nella ipotesi di concessione di demanio marittimo le «con-
cessioni sono di una sola natura giuridica e questa è quella contrattuale» 21.
L’analisi del Ranelletti riguardò anche altri tipi di concessioni 22 e l’Autore
concluse il proprio studio affermando che non fosse possibile distinguere tra con-
cessione e concessione, ma che bisognasse prendere atto della difficoltà di identi-
ficare la natura giuridica dell’atto di concessione stesso che risultava di dubbio
genere; l’incertezza derivava dal fatto che, in alcuni casi le fonti portassero a rite-
nere si trattasse di atti unilaterali e, in altri, che fossero atti bilaterali di natura
contrattuale; la prima impostazione trova il proprio fondamento giuridico in leggi
mentre la seconda solo in disposizioni regolamentari 23.
In ogni concessione «che porti con sé degli obblighi pel concessionario» 24 vi
sono due negozi giuridici. I due negozi si caratterizzano per il fatto di nascere in
momenti diversi ed avere ognuno una propria vita ma per essere tra loro intima-
mente uniti e compenetrati.
Il primo 25 si caratterizza per la specificazione degli obblighi del privato e diritti
dell’ente pubblico e produce tutti i relativi effetti giuridici; il secondo, l’atto di con-
cessione, crea tutti gli effetti, con gli obblighi dell’ente pubblico e i diritti del privato.
La causa obligationis del privato può essere riscontrata nella concessione, men-
tre l’obbligazione del privato non può costituire la causa della concessione. Bisogna
infatti tenere presente la diversa natura giuridica dei due soggetti e gli scopi da essi
perseguiti. La concessione è un atto di imperio che trova la propria «causa negli
scopi di interesse generale che l’ente concedente deve raggiungere» 26.
21
In merito a tale aspetto: O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni am-
ministrative, cit., p. 51.
22
Concessioni di lavori pubblici, di ferrovie pubbliche, miniere, esercizio dei telefoni e di aree
nei cimiteri per la costruzione di sepolture private o di famiglie.
23
O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, cit., p. 56.
24
L’espressione è di O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni ammi-
nistrative, cit., p. 63.
25
In tal senso afferma O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni ammini-
strative, cit., p. 63: «La dichiarazione di volontà del privato, che può consistere o solo nella domanda
per le sole condizioni generali; o solo nell’accettazione espressa o tacita della concessione, o solo
nell’atto di obbligazione per le sole condizioni particolari; o nella domanda e nell’accettazione insieme,
oppure nella domanda e nell’atto di obbligazione insieme per le condizioni generali e particolari».
26
Cfr. O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, cit., p.La natura giuridica della concessione e l’incidenza del diritto europeo 7
L’obbligazione del privato è a volte un mezzo necessario per il raggiungimen-
to dello scopo principale, mentre è sempre un mezzo per il raggiungimento dei
fini secondari e concomitanti.
Nella concessione vi sono pertanto due negozi giuridici, entrambi unilaterali;
uno di diritto pubblico necessario e un secondo, di diritto privato (eventuale), che
può coesistere con il primo o non esistere.
I due negozi giuridici, pur essendo così connessi e compenetrati, tuttavia non
si uniscono a formare un unico atto di natura contrattuale 27.
Ranelletti ritenne, pertanto, le concessioni “atti amministrativi ad effetti bilate-
rali” 28 e negò la possibilità di contratti di diritto pubblico in queste ipotesi.
La dottrina successiva (D’Alberti), non ha mancato di osservare che il Ranelletti
nel proprio lavoro, pur partendo dal dato letterale, giunse tuttavia a conclusioni for-
malistiche. È vero, infatti, che la normativa in tema di concessioni ferroviarie utiliz-
zava il termine «convenzione», termine che il Ranelletti affermò essere indetermina-
to e pertanto inutile per qualsiasi ricostruzione, ma è altrettanto vero, come osserva il
D’Alberti, che il termine convenzione era utilizzato in realtà in modo preciso nel co-
dice civile, in quanto era chiaramente utilizzato quale sinonimo di contratto 29.
L’utilizzo di concetti privatistici nell’opera del Ranelletti è più formale che so-
stanziale. La disciplina sostanziale dell’atto amministrativo viene condizionata
solo in minima parte dal richiamo degli istituiti e delle nozioni privatistiche 30.
La dottrina successiva sviluppò le tesi unilateralistiche della concessione am-
ministrativa.
Un’importante ricostruzione dogmatica si riscontra nell’opera del Cammeo 31;
69. L’Autore afferma inoltre (pp. 60 e 61) che: «Il privato si obbliga a rispettare tutti gli oneri, che a lui
impone l’ente pubblico, per ottenere la concessione, la quale altrimenti non sarebbe accordata; sicché
lo scopo della sua obbligazione, la causa obligationis è ottenere e valersi della concessione. L’ente
pubblico però non trova la causa, lo scopo del suo atto e dei conseguenti suoi obblighi, direttamente
nella obbligazione del concessionario: esso fa la concessione per procurarsi o per dare ad altri i mezzi
di raggiungere determinati scopi, nei quali l’ente, che concede, vede degli scopi di pubblica utilità, o
per raggiungere direttamente tali scopi di interesse generale. E gli obblighi del concessionario o sono
imposti per raggiungere uno scopo di garanzia, come tutti quelli, che tendono a salvaguardare gli inte-
ressi pubblici o i diritti dei terzi; o per raggiungere uno scopo di giustizia distributiva, come tutti gli
obblighi, che hanno un carattere di corrispettività, quali sono tutti i canoni e prezzi – vere tasse pagate
dal privato concessionario pel vantaggio speciale, che a lui dà la concessione – o infine per raggiungere
lo scopo stesso, pel quale è fatta la concessione, come tutti quegli obblighi, che costituiscono l’oggetto,
il contenuto medesimo di questa; così nelle concessioni di lavori pubblici il fare quelle date opere, che
costituisce insieme il diritto creato nel concessionario e l’obbligo da questo contratto».
27
Nozione tratta ancora da O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni
amministrative, cit., p. 72.
28
M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 435.
29
Artt. 1104, 1110, 1111 e 1126 c.c.
30
M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 97.
31
F. CAMMEO, I monopoli comunali, l’opera fu pubblicata nel biennio 1895-1896, nell’Archivio
giuridico Serafini.8 La concessione dei servizi
l’Autore sembrò dare maggiore importanza agli interessi del concessionario ri-
spetto all’amministrazione e pertanto ricostruì il rapporto concessorio in termini
più stabili, riconoscendo anche diritti del concessionario (e non solo interessi o
interessi legittimi come il Ranelletti) nei confronti della amministrazione 32.
Tuttavia l’impostazione prospettata era volta a tutelare la posizione della Pub-
blica Amministrazione e ad evitare che la stessa rimanesse vincolata al rispetto di
concessioni preesistenti senza poter recedere unilateralmente.
La teoria riconobbe la possibilità che, per tutti i tipi di concessione ammini-
strativa, comprese quelle sui beni pubblici, potessero derivare «diritti soggettivi di
natura pubblica per il concessionario» 33.
Il passaggio successivo, compiuto dalla giurisprudenza e dalla pratica, incise
proprio su questo elemento, in quanto la qualificazione delle «obbligazioni pub-
bliche della pubblica amministrazione» dovette cedere di fronte alle «obbligazioni
contrattuali» 34; passaggio che portò con sé fondamentali conseguenze anche sotto
il profilo delle norme applicabili: infatti si passò dalla applicazione di alcune
norme civilistiche sui contratti alle regole del codice civile sui contratti.
Nell’analisi delle teorie della concessione amministrativa non può non accennarsi
al lavoro del Forti 35. Nel proprio scritto lo studioso esaminò la possibilità di applica-
re alla concessione amministrativa la categoria concettuale del contratto di diritto
pubblico 36, tuttavia i tempi erano prematuri per poter utilizzare questa costruzione
teorica che si sarebbe sviluppata in un secondo tempo, intorno agli anni trenta.
Nella propria elaborazione il Forti definì la concessione di pubblico servizio e
differenziò l’istituto rispetto alla concessione di lavori pubblici. L’Autore osservò
come potesse essere fonte di incertezze definire “concessione di lavori pubblici”
una concessione concernente per esempio: «il solo esercizio di una ferrovia di
proprietà dello Stato, o del peso pubblico o di un teatro comunale» 37.
Il Forti fu il primo a utilizzare espressamente la locuzione «concessione di ser-
32
M. D’ALBERTI Le concessioni amministrative, cit., p. 112. Sono interessanti le conclusioni
dell’Autore in tema di indennizzo spettante al concessionario per esempio nel caso di cessazione
unilaterale della concessione anteriore alla scadenza. Infatti, «la discrezionalità, per Cammeo, non
consente che dall’atto discrezionale sorgano obbligazioni contrattuali a carico dell’amministrazione;
ma da esso possono sorgere obbligazioni dell’amministrazione il cui adempimento comporta un ob-
bligo di indennizzare il “privato” nei limiti del danno emergente». Pertanto, la costruzione prospet-
tata, pur apparendo più garantista per il privato rispetto alla teorica di Ranelletti in realtà riconosce
un diritto all’indennizzo minore rispetto a quest’ultimo. Ranelletti infatti, quando ritiene esistere un
diritto al lucro, nel caso di estinzione unilaterale del rapporto (soprattutto in materia di concessioni
ferroviarie), riconosce il diritto ad ottenere l’indennizabilità anche del profitto cessante (e non solo
del danno emergente).
33
M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 117.
34
Su questo aspetto il rinvio è ancora a M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 118.
35
U. FORTI, Natura giuridica delle concessioni amministrative, in Giur. it., 1900, IV, p. 369 ss.
36
La ricostruzione è compiuta da M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 126.
37
L’esempio è tratto da U. FORTI, Natura giuridica delle concessioni amministrative, cit., p. 380.La natura giuridica della concessione e l’incidenza del diritto europeo 9
vizi» attribuendogli un preciso significato, anche se l’istituto esisteva ed era cono-
sciuto e utilizzato dai tempi remoti.
Un passaggio fondamentale nella elaborazione della concessione amministrava
si evince proprio nella analisi della concessione di pubblico servizio. In fattispe-
cie, infatti, si riscontra sempre l’obbligazione del concessionario di esercitare un
pubblico servizio.
Nelle concessioni di pubblico servizio è sempre presente un capitolato di ap-
palto mediante il quale la pubblica amministrazione impone al concessionario tut-
ti gli obblighi che ritiene opportuni nella attribuzione della concessione; obblighi
che il concessionario accetta insieme alle condizioni ivi previste. In ipotesi, per-
tanto, e soprattutto nel caso di concessione di pubblici servizi comunali, gli obbli-
ghi e le condizioni formano oggetto di vere e proprie trattative tra le parti. Tra gli
obblighi pattuiti ne esiste uno, in capo al privato, che non manca mai ed è un «ob-
bligo di fare, che si concreta nel pubblico servizio oggetto del rapporto» 38, ele-
mento considerato dal Forti caratteristico dell’istituto. Pertanto, in tutti i tipi di
concessione amministrativa, da cui derivino obblighi di fare per il concessionario,
può ritrovarsi un «fondo contrattuale» 39.
Negli anni trenta nacquero e si diffusero le teorie del contratto di diritto pub-
blico che interferirono con l’istituto della concessione. Lo scopo fu quello di di-
mostrare la possibilità di elaborare criteri di distinzione sufficientemente precisi
tra provvedimento amministrativo e contratto di diritto pubblico e tra quest’ultimo
e il contratto meramente privatistico della pubblica amministrazione 40.
Nel diritto amministrativo, secondo la teoria che fu elaborata dal Miele 41, esi-
sterebbero «atti contrattuali uguali», cioè atti autenticamente bilaterali e dotati di
«contenuto diverso ma corrispondente e reciprocamente integrativo» e di «causa
diversa e corrispondente».
La fattispecie ricorrerebbe quando la PA non opera con provvedimenti unilate-
rali e, in particolare, nel caso di talune singole ipotesi di rapporto di impiego (non
nel rapporto di impiego in generale) o nel caso delle convenzioni accessive ai
rapporti concessori relativi ai pubblici servizi. In termini più generali vi sarebbe la
possibilità di un atto convenzionale, che deve essere ascritto al diritto pubblico,
ogni qual volta il diritto positivo non preveda esplicitamente l’emanazione di un
provvedimento amministrativo e senza che, in fattispecie, possa essere concluso
un uguale atto contrattuale. Il problema fondamentale dei presupposti e ragioni
del carattere pubblicistico dell’atto viene risolto dall’Autore facendo riferimento
38
La citazione è tratta direttamente da U. FORTI, Natura giuridica delle concessioni amministra-
tive, cit., p. 393.
39
M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 129.
40
In tal senso il rinvio è all’opera di G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e
caratteri, Milano, 1984, p. 88.
41
G. MIELE, La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo, Roma, 1931,
citato da G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., p. 89.10 La concessione dei servizi
alla natura pubblicistica di una delle due parti e non in termini di perseguimento
dell’interesse pubblico da parte della amministrazione 42.
Il contratto di diritto pubblico fu ricostruito in termini differenti; furono origi-
nali le teorie del Bodda e Gallo che, seppure con differenti sfumature, attribuirono
importanza all’elemento causale.
Il contratto privato e pubblico si distinguevano per la “causa”. In tal senso non
diveniva rilevante il perseguimento dell’interesse pubblico da parte della Pubblica
Amministrazione, che sicuramente doveva persistere, quanto piuttosto la posizio-
ne specifica che l’interesse pubblico ricopriva rispetto al negozio 43.
Nella elaborazione della teoria del contratto di diritto pubblico un punto di vi-
sta completamente antitetico fu quello dell’Amorth 44, il quale nel proprio lavoro
partì dall’attività di diritto privato della pubblica amministrazione per valutare gli
effetti che potessero derivare dalla presenza dell’elemento pubblicistico nell’ordi-
nario svolgersi della fattispecie 45. Tra le costruzioni autorevoli non può, poi, esse-
re dimenticata quella del Carnelutti, che cercò di comporre gli elementi provve-
dimentali e contrattuali in una fattispecie più complessa.
Il contratto di diritto pubblico continuò ad essere una figura incerta e tormenta-
ta anche nell’opera dello Zanobini.
L’istituto ebbe cittadinanza nel sistema amministrativistico italiano, tuttavia si
trattò sempre di una «ben fragile e superficiale presenza, di poco più che una
semplice apparenza» e ciò proprio per la constatazione che l’agire contrattuale
della pubblica amministrazione deve essere qualificato in determinati casi quale
agire amministrativo e, pertanto, quale agire «normativamente vincolato al pub-
blico interesse e giuridicamente rilevante come tale» 46. Sono proprio questi ele-
menti pubblicistici a limitare fortemente l’agire contrattuale dell’amministrazione
che perde il carattere sostanziale e diviene un mero elemento formale, un involu-
cro esterno 47.
42
Si veda, G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., p. 90 e 92; afferma l’Autore che: «Il
contratto di diritto pubblico nella versione del Miele è così un contratto (o più precisamente nel cauto
linguaggio dell’Autore, un “atto contrattuale”) che incide su un rapporto da qualificare pubblicistico, in
quanto è disciplinato da regole di diritto pubblico”. Si tratta di una prospettiva “oggettivistica”, che
tuttavia comprende non certo irrilevanti momenti “soggettivi” dal momento che regole di diritto pub-
blico sono poi quelle istitutive di rapporti aventi come parte necessaria lo Stato o i suoi ausiliari».
43
Le dottrine causalistiche si caratterizzerebbero pertanto per il fatto che l’interesse pubblico
non rimarrebbe nella soggettività dell’amministrazione quale motivo presupposto del negozio ma,
proprio come nel contratto di diritto privato, si presenterebbe come connaturato al negozio e con
esso compenetrato, in modo da caratterizzarne la causa. In tale senso, G. FALCON, Le convenzioni
pubblicistiche, cit., p. 94.
44
A. AMORTH, Osservazioni sui limiti dell’attività amministrativa di diritto privato, Ach. Dir.
Pubbl., 1938, p. 455.
45
G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., p. 102.
46
Espressione tratta da G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., p. 114.
47
Si rinvia a G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit., p. 115.La natura giuridica della concessione e l’incidenza del diritto europeo 11
Nella tesi del Falcon «l’atto di adesione al contratto è dunque esso stesso atto
amministrativo discrezionale» 48, il consenso è unico e si esprime con l’atto ammi-
nistrativo 49.
Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento si assistette alla pubblicizza-
zione pressoché integrale dei rapporti della pubblica amministrazione. Si è osser-
vato che il processo di pubblicizzazione produsse importanti conseguenze in tema
di concessioni che vennero qualificate come atti amministrativi unilaterali; si e-
stese la sfera della discrezionalità amministrativa, le situazioni giuridiche nascenti
in capo al concessionario vennero qualificate come interessi legittimi e non diritti
soggettivi; ciò condusse alla possibilità di revocare la concessione ad nutum con
l’assenza o la forte limitazione degli indennizzi a favore del concessionario in se-
guito alla cessazione unilaterale del rapporto, e con l’attribuzione della giurisdi-
zione al giudice amministrativo, sotto il profilo degli aspetti essenziali della con-
cessione e del rapporto giuridico da esso costituito 50.
La municipalizzazione dei servizi pubblici ad opera della legge di Giolitti sulle
municipalizzazioni costituì una importante smentita per l’impostazione pubblici-
stica 51; la legge prevedeva infatti la possibilità per i Comuni non solo di mantene-
re, ma di costituire nuove concessioni. Pertanto, sul piano strettamente interpreta-
tivo, la legge non solo non escludeva lo strumento della concessione – presuppo-
nendolo, anzi come incondizionatamente possibile – ma neanche conteneva tracce
di avversione per tale istituto, né lo riduceva a «strumento di ripiego o comunque
sussidiario o meno opportuno rispetto alla gestione diretta» 52. Inoltre, come già
accennato, la legge prevedeva una disciplina in tema di revoca delle concessioni
preesistenti più favorevole rispetto a quella elaborata dalle teorie pubbliciste 53.
Pertanto, la situazione giuridica soggettiva del concessionario poteva a questo
punto essere ricostruita in termini di diritto soggettivo piuttosto che di interesse
legittimo.
L’elaborazione teorica dell’istituto della concessione doveva tenere conto de-
gli orientamenti delle Corti, impegnate quotidianamente nella decisione di casi
concreti, le cui sentenze avevano non solo una fondamentale rilevanza sul piano
giuridico ma anche, per la materia trattata, sul piano economico.
La Corte di Cassazione di Roma, con la sentenza del 12 gennaio 1910, affermò
48
A. LOLLI, L’atto amministrativo nell’ordinamento democratico, Milano, 2000, p. 115.
49
Il rinvio è ancora a G. FALCON, Le convenzioni pubbliche, cit., p. 301.
50
L’analisi è tratta da M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 176.
51
Un altro importante evento non in linea con la ricostruzione in termini pubblicisti fu la statiz-
zazione delle ferrovie. M. D’ALBERTI, nel proprio scritto, Le concessioni amministrative, analizza
approfonditamente la normativa in tema di ferrovie in quanto costituì uno dei settori di intervento
più importante e fonte di spunti interessanti in tema di concessioni.
52
F.G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei servizi pubblici, cit., p. 26.
53
Veniva riconosciuto un diritto all’indennizzo che prevedeva il riconoscimento sia del danno
emergente che del lucro cessante.12 La concessione dei servizi
un principio fondamentale che costituì il punto di partenza per tutta la successiva
evoluzione dell’istituto della concessione. Decidendo una controversia relativa
alla concessione di un’aria demaniale marittima per uso industriale, in cui il con-
cessionario aveva violato i limiti di costruzione imposti dalla concessione, la Cas-
sazione affermò che nella concessione sono presenti due negozi giuridici i quali,
pur essendo nella loro essenza distinti, sono però congiunti. Infatti, il primo nego-
zio era attuato e si realizzava con il secondo; tuttavia, in alcuni casi il secondo ne-
gozio, il contratto, poteva anche mancare. Il consenso del concessionario costitui-
sce la condizione che permette all’atto amministrativo unilaterale di perseguire il
proprio effetto, mentre nel secondo atto vi è il consenso delle parti in ordine al re-
golamento convenzionale, che regola le modalità di attuazione e svolgimento del-
la concessione 54.
La tesi proposta dalla Corte di Cassazione non smentisce apertamente la rico-
struzione pubblicistica, infatti il negozio continua a essere di diritto pubblico, non
poteva non darsi prevalenza all’atto amministrativo al quale il contratto aggiunti-
vo «accedeva», era «complementare» o «dipendente» 55.
La concessione continua pertanto a essere un atto di disposizione o «atto voli-
tivo sovrano di un’autorità». L’amministrazione può, però, scendere a patti con i
privati concessionari, per stabilire il corrispettivo della concessione o altre obbli-
gazioni e questo è un vero e proprio regolamento contrattuale 56.
La nuova costruzione della concessione in termini di concessione-contratto, fu
54
Cass. Roma, 12 gennaio 1910, in Riv. dir. comm., 1910, p. 248. In particolare, la Corte affer-
ma (pp. 248 e 249): «Considerati analiticamente sono nella loro essenza due negozi distinti, che si
congiungono: il primo si attua e si realizza nell’altro, ma può anche non essere accompagnato dalla
stipulazione di un contratto. All’accettazione del concessionario, che rappresenta rispetto all’atto
amministrativo il verificarsi della condizione per la quale esso consegue il suo effetto, si unisce il
consenso delle due parti sopra un regolamento convenzionale della concessione per suo modo di
attuarsi e di svolgersi. Questo regolamento giuridico può essere costituito dal complesso delle mo-
dalità e delle condizioni dettate dalla pubblica amministrazione, indipendentemente da ogni vincolo
convenzionale, ma può, senza ostacolo legale, formare obbietto di una stipulazione o di un comples-
so di patti, in cui l’ente pubblico assume la figura di contraente. In questa seconda ipotesi, certamen-
te, possono aver luogo vere e proprie violazioni contrattuali e azioni ex contractu per ripararle. Ma
anche nella prima ipotesi, sia pure che non si tratti di un vincolo contrattuale nella sua essenza ope-
ratosi per l’accettazione da parte della volontà individuale del concessionario, sorgono obbligazioni
e responsabilità, diritti e doveri giuridici, le cui violazioni possono dar luogo ad azioni giudiziali».
55
Per questo importante percorso definitorio, M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative,
cit., p. 189.
56
G.F., Concessioni sul demanio marittimo per uso industriale e competenza dell’autorità giu-
diziaria, in Riv. dir. comm., 1910, vol. VIII, II, p. 248. L’autore affrontando il problema dei due ne-
gozi giuridici che possono riscontrarsi nella concessione amministrativa osserva (p. 251): «così nel
primo momento è un atto, un movimento di una potestà sovrana, ch’è la manifestazione di una so-
vrana volontà; nel secondo momento la volontà dell’amministrazione funziona come volontà di un
contraente, e, incontrandosi con quella del concessionario, dà esistenza ad un vero contratto. Non è a
confondersi questo regolamento contrattuale con la semplice accettazione: questa può non costituire
un contratto, ma un avvenimento indispensabile per l’attuazione della concessione».La natura giuridica della concessione e l’incidenza del diritto europeo 13
fondamentale per assicurare ai privati una tutela giuridica più forte rispetto alla
costruzione precedente.
Corollario della nuova disciplina furono due importanti elementi: l’applicabi-
lità ai rapporti concessori del regime contrattuale paritario e la caduta della revo-
cabilità ad nutum della concessione 57.
La concessione-contratto, una costruzione dualistica nella quale i due diversi
momenti si condizionano reciprocamente, sarà considerata come la tesi più tradi-
zionale 58 di ricostruzione dell’istituto negli anni a venire. Tuttavia, anche le altre
tesi, trovarono illustri sostenitori; la figura del contratto di diritto pubblico venne
ripresa nella propria elaborazione teorica dal Sandulli 59, il quale riconobbe l’esi-
stenza dei contratti della pubblica amministrazione di «diritto pubblico», soggetti
alle stesse regole del diritto comune.
Secondo al teoria contrattualista il rapporto di concessione ha carattere contrat-
tuale, pertanto, per la creazione dello stesso è necessario il concorso sinallagmati-
co della volontà della pubblica amministrazione e del privato. In questa ipotesi la
concessione (l’atto amministrativo concessorio) in sostanza non esiste, l’impor-
tanza fondamentale nella definizione del rapporto è attribuita soltanto al contratto.
La concessione venne ricostruita nei termini di contratto di diritto pubblico an-
che da M.S. Giannini 60.
Nella concessione le parti concorrerebbero in posizione giuridica paritaria alla
costituzione del rapporto e gli effetti giuridici che ne deriverebbero sarebbero col-
legati all’incontro delle due volontà; le prestazioni presenterebbero una stretta
correlazione nel senso che ciascuna di esse sarebbe legata causalmente all’altra 61.
La ricostruzione della concessione in termini pubblicisti del Giannini assunse
una importanza fondamentale per la ricostruzione dell’istituto della concessione
di pubblici servizi. In fattispecie, infatti, le concessioni non sarebbero “concessio-
ni”, ma atti di tipo organizzatorio con i quali la pubblica amministrazione affida a
terzi un proprio ufficio 62.
Alla teoria contrattualista si opposero gli anticontrattualisti, i quali sostennero
che la concessione sorgesse da un atto costituito dalla sola volontà della ammini-
57
Su questo aspetto ancora M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, cit., p. 195.
58
F. ROVERSI MONACO, Apertura dei lavori del convegno, in F. ROVERSI MONACO (a cura di),
Le concessioni di servizi, Atti della giornata di studio organizzata dall’Università di Bologna, Scuola
di Specializzazione in diritto amministrativo, in collaborazione con ANIG, Roma 3 dicembre 1987,
Rimini, 1987.
59
A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, p. 585.
60
Sul punto, M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, I, Milano, 1950, p. 350, l’Autore
ricostruisce il rapporto soprattutto in termini di atti amministrativi unilaterali costitutivi di rapporti
bilaterali.
61
E. SILVESTRI, Concessione amministrativa, in Enc. dir., VIII, ad vocem, Milano, 1961, pp. 373-374.
62
In tal senso il rinvio è allo scritto di F. ROVERSI MONACO, Apertura dei lavori del convegno,
in F. ROVERSI MONACO, cit., p. 13.14 La concessione dei servizi
strazione. Le dichiarazioni di volontà della amministrazione e del singolo si con-
creterebbero in due atti distinti e unilaterali: quello dell’amministrazione assume-
rebbe la posizione di atto principale e per se stesso operativo del rapporto, mentre
quello del privato, a seconda che intervenga prima o dopo l’atto di concessione,
assumerebbe rilievo come semplice presupposto o come condizione di efficacia
del medesimo 63.
Le differenti tesi si sono contrapposte nel corso degli anni fino all’intervento
decisivo del diritto comunitario che, a piccoli passi, ha posto fine a questo lun-
ghissimo dibattito ed ha avuto un’importanza fondamentale nella ricostruzione del-
l’istituto.
Si osserva che insieme alla concessione – contratto nacque anche la figura del
contratto ad evidenza pubblica; entrambi si articolano in atti amministrativi e in
atti consensuali; ma il rapporto tra gli uni e gli altri appare, nelle due ipotesi, pro-
fondamente diverso 64.
2. Il servizio pubblico nel diritto italiano: concezione soggettiva e ogget-
tiva
La nozione “servizio pubblico” è «tra quelle più tormentate» 65 nell’ordinamento
italiano e nell’ordinamento europeo.
I problemi definitori si presentano numerosi poiché la nozione utilizza due distinti
concetti rilevanti: accanto al nome “servizi” è posto l’aggettivo “pubblici” e l’inter-
connessione dei due termini costituisce un importante elemento di complessità.
La letteratura in materia di pubblici servizi 66 è amplissima, e ciò a conferma
63
La tesi è prospettata in E. SILVESTRI, Concessione amministrativa, cit., p. 374.
64
Osserva F.G. SCOCA, Autorità e consenso, in Dir. amm., 2002, 3, p. 431, che: «nella prima gli
atti della prima serie si situano nella fase di formazione del contratto, e terminano con la nascita del
rapporto consensuale; nella seconda essi investono la nascita del rapporto concessorio ed escludono
pertanto il consenso da tale fondamentale aspetto precettivo, limitandone il rilievo o la necessità alla
sola disciplina (che diventa pattizia) dello svolgimento del rapporto concessorio».
65
M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, Bologna, 1986, p. 69 ss.
66
U. POTOTSCHNIG, Pubblici servizi, Padova, 1964; B. MAMELI, Servizio pubblico e concessio-
ne, Milano, 1998; M. MENSI, Appalti, servizi pubblici e concessioni, Padova, 1999; G. NAPOLITA-
NO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001; L.R. PERFETTI, Contributo ad una teoria
dei pubblici servizi, Padova, 2001; E. SCOTTI, Il pubblico servizio tra tradizione nazionale e pro-
spettive europee, Padova, 2003; G. IACOVONE, Regolazione, diritti e interessi nei pubblici servizi,
Bari, 2004; V. LOSTORTO, I servizi pubblici, Milano, 2007; R. VILLATA, Pubblici servizi, discussio-
ni e problemi, Milano, 2008.
F. MERUSI, voce Servizio pubblico, in Noviss. dig. it., XVII, Torino, 1970, p. 215; S. CATTANEO,
voce Servizi pubblici, in Enc. dir., XLII, 1990, p. 355; P. CIRIELLO, Servizi pubblici, ad vocem, in
Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1992; F. GIGLIONI, Osservazioni sulla evoluzione della nozio-La natura giuridica della concessione e l’incidenza del diritto europeo 15
della difficoltà di definire l’istituto in termini precisi, sia in una prospettiva euro-
pea che italiana.
Le numerose trattazioni dedicate al tema dei “servizi pubblici” hanno eviden-
ziato la «sostanziale indeterminatezza della nozione» 67.
ne di “servizio pubblico”, in Foro amm., 1998, p. 2282; M. CLARICH e L. ZANETTINI, Servizi pub-
blici, in G. CORSO e V. LOPILATO (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituziona-
li, Milano, 2006; G. NAPOLITANO, I servizi pubblici, in S. CASSESE (a cura di), La nuova costituzio-
ne economica, Roma-Bari, 2007.
Per una visione comunitaria, G.B. NUZZI, Concorrenza e servizi pubblici locali: principi comu-
nitari e spunti problematici nella prospettiva della riforma del capo VII della L. 8 giugno 1990, n.
142, in Dir. comm. internaz., 2000, 3, p. 615; R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuri-
dica del pubblico servizio tra ordinamento interno ed ordinamento europeo, in Dir. amm., 2000, 1,
p. 41; F. TRIMARCHI BANFI, Considerazioni sui nuovi servizi pubblici, in Riv. it. dir. pubbl. comunit.
2002, 5, p. 945; E. PICOZZA, I servizi di interesse economico generale in Europa e la problematica
dei servizi pubblici locali, Convegno C.I.S.A., La riforma dei servizi pubblici locali (art. 35 L. n.
448/02), Roma, 15 ottobre 2002; M. CLARICH, Servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza:
l’esperienza italiana e tedesca a confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 1, p. 91; N. RANGONE, I
servizi pubblici nell’ordinamento comunitario, in Giorn. dir. amm., 2005, 4, p. 433; F. BIANDRON-
NI, Quale nozione di servizio pubblico? (un nuovo indirizzo giurisprudenziale sulla centralità della
qualificazione legislativa del servizio pubblico), in Foro amm. TAR, 2005, 11, p. 3413; N. BASSI, I
servizi pubblici comunitari: la loro recente comparsa, i loro primi sviluppi, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., 2006, 1, p. 69; R. GIOVAGNOLI, È servizio pubblico solo l’attività rivolta direttamente a
soddisfare le esigenze dell’utenza, in Urb. e app., 2006, 12, p. 1393; F. BRAGAGNI, Servizi ed ap-
palti pubblici nell’ordinamento nazionale e comunitario, www.altalex.com, 2007.
67
Tra le tante definizioni della nozione di servizio pubblico si ricorda: U. FORTI, Natura giuridica
delle concessioni amministrative, in Giur. it., 1900, IV, p. 369 e, in particolare, p. 380, in cui si afferma
che il concetto di pubblico servizio è ancora piuttosto ampio ma già molto più nitido rispetto alle pre-
cedenti enunciazioni dottrinali: esso viene definito come: «complesso di azioni costituenti una forma
dell’attività esplicata o regolata dallo Stato (o da altro ente pubblico) e diretta a conseguire i fini di que-
sto, esclusivamente o insieme a fini privati»; M.S. GIANNINI, Profili giuridici della municipalizzazione
con particolare riguardo alle aziende, in Riv. amm. rep., Roma, 1953, p. 611, l’Autore afferma (p.
614) che: «Il “pubblico servizio” forma oggetto di studio in tre distinte discipline: l’economia, la scien-
za dell’organizzazione, la scienza del diritto. In ciascuna di queste discipline si dà peraltro del pubblico
servizio un concetto che solo in parte coincide con quello dell’altra disciplina»; M. D’ALBERTI, Le con-
cessioni amministrative, cit., p. 107; osserva l’Autore che Ranelletti utilizzava il termine servizio pub-
blico conferendogli un significato molto ampio, qualificandolo una «attività imprenditoriale che può
avvantaggiare la pubblica amministrazione»; inoltre ammetteva che sia la concessione di lavori pubbli-
ci che quella di beni pubblici potesse dar luogo all’esercizio di servizi pubblici da parte del concessio-
nario e proprio lo svolgimento di un servizio pubblico giustificasse il diritto al lucro; P. CIRIELLO, Ser-
vizi pubblici, ad vocem, p. 1, in cui si spiega che la nozione pubblico servizio è stata «di volta in volta
accusata di “verbalismo” o di esser caratterizzata da un così alto tasso di genericità da consentire che
“le nozioni di servizio pubblico siano tante quanti gli autori che se ne occuparono”». La medesima dif-
ficoltà nella definizione del concetto servizio pubblico è riscontrata anche da S. CATTANEO, Servizi
pubblici, cit., p. 355, il quale afferma trattarsi «di una di quelle nozioni che hanno corso, e forse corro-
no ancora il rischio di venire ridotte ad espressioni solo approssimatamene descrittive di certe realtà
della vita amministrativa o di essere usate con significati mutevoli in relazione agli ordini concettuali
nel cui contesto sono collocate. In via generalissima il riferimento al servizio pubblico evoca l’idea di
un compito d’interesse generale da realizzare, al quale si preponga un soggetto o un gruppo di soggetti,
pubblici o privati»; A. ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. amm., Milano,16 La concessione dei servizi
Le difficoltà di definire il concetto si sono riscontrate ogni qual volta si è tentato
di costruire una teoria generale dei servizi pubblici 68 ed esse sono assai risalenti ove
si pensi che già ai primi del novecento, uno dei padri del concetto di servizio pub-
blico, il De Valles già in apertura del proprio lavoro, interamente dedicato ai servizi
pubblici, scriveva 69: «pubblico servizio è una frase che, pur correndo sulla bocca di
tutti, è usata raramente dal diritto positivo, il quale quindi può portare scarso sussi-
dio ad una determinazione giuridica: che fu adottata dagli economisti ed introdotta
nella loro nomenclatura scientifica con un significato che non coincide con quello
di cui comunemente di pubblico servizio si parla: che infine gli scritti di diritto pub-
blico, data tale incertezza, molto spesso rifuggono dall’adottare» 70.
Dall’Unificazione d’Italia si sono contrapposte diverse tesi e la nozione di ser-
vizio pubblico è stata ricostruita in termini soggettivi e oggettivi; oggi essa è erosa
dalla disciplina comunitaria che ricollega, intrinsecamente, la nozione di servizio
a quella di attività economica 71.
Le prime codificazioni in tema di servizi pubblici furono adottate tra la fine
dell’ottocento e l’inizio del novecento.
Nella evoluzione normativa in tema di servizi pubblici fu fondamentale la leg-
ge del 29 marzo 1903, con la quale, a seguito dell’unificazione d’Italia, si decise
di municipalizzare i servizi pubblici locali 72.
1994, p. 459, l’Autore, con riferimento alla nozione di concessione e di pubblico servizio dichiara (pp.
462 e 463): «si devono indicare subito le difficoltà che ogni studio del tema delle concessioni di pub-
blici servizi incontra: quelle che ineriscono alla precisazione dei tratti di ambedue le nozioni evocate
dai termini che tale locuzione compongono. Difficoltà le quali ne condizionano e ne limitano gli esiti».
E, inoltre, proprio con riferimento al pubblico servizio afferma trattarsi di nozione: «altrettanto discus-
sa e incerta, per i significati da attribuire sia a tale sostantivo come a tale sua aggettivazione, e tuttavia
altrettanto qui così rilevante».
68
Sul punto il rinvio è al lavoro di E. PICOZZA, Introduzione al diritto amministrativo, Padova,
2006, p. 299, in cui l’Autore spiega che: «nel diritto pubblico (la nozione di servizio) è stata sovente
associata in passato al predicato “pubblico” intendendosi con l’espressione “servizio pubblico” col-
legare attraverso una disciplina legislativa specifica l’attività inerente alla tutela di interessi pubblici.
Il fatto incontestabile è che essa sia stata oggetto di “pluriqualificazione giuridica”, e non solo attra-
verso le concezioni penalistiche che sono state accolte dal codice (art. 358 c.p.), ma anche
all’interno della scienza del diritto amministrativo, è segno che la medesima non ha omogeneità
dogmatica, ma può essere colta solo attraverso un’analisi storico-politica».
69
A. DE VALLES, I servizi pubblici, in Trattato Orlando, VI, Milano, 1923, p. 379: «La tratta-
zione dei pubblici servizi presenta una difficoltà iniziale, di definizione e di limite: che di pubblico
servizio manca della letteratura giuridica un concetto, non dico preciso, ma per lo meno generico».
70
In particolare A. DE VALLES, I servizi pubblici, cit., pp. 379 e 380, rinvia all’opera di S. RO-
MANO, Principi di diritto amministrativo, n. 31, il quale non ritiene il pubblico servizio una nozione
giuridica vera e propria ma bensì un complesso di scopi sociali che: «gli enti amministrativi devono
proporsi e comprende una quantità di istituti e rapporti l’uno profondamente diverso dall’altro, tra i
quali trova posto quello della prestazione degli enti medesimi».
71
La tesi è di E. PICOZZA, Introduzione al diritto amministrativo, cit., p. 300.
72
La municipalizzazione dei pubblici servizi, cioè l’attribuzione ai Comuni (e alla Province) di
attività economiche che incidevano, in larga misura, sulle comunità locali, avvenne proprio nel pe-Puoi anche leggere