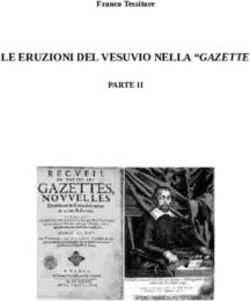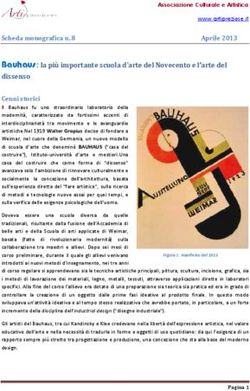Il primo "astronomo" greco - Unibo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il primo “astronomo” greco
Mileto fondata attorno al 1000 a.C. alla foce del fiume
Meandro (da cui deriva la terminologia associata alla
forma sinuosa) era una città della Caria, che poi
divenne una colonia ionica. Nel VII secolo a.C. formò
con altre 11 città (fra cui Samo e Efeso) la lega ionica
per resistere all’invasione dell’impero persiano.
Talete di Mileto Filosofo (624 – 546 a.C ca )
Alla fine del VII secolo durante la
guerra con la Lidia Trasibulo
divenne il tiranno di Mileto. Alla
morte di Trasibulo (590 a.C.) Mileto
subì l’ingerenza di Creso, re della
Lidia.Non è chiaro se Talete fosse nato a Mileto o se fosse di origine fenicia. (La civiltà fenicia raggiunse il massimo della propria potenza/grandezza intorno all' VIII/VII sec a.C. Dei Fenici si sa pochissimo. Per effetto di una delle tante diverse migrazioni, che si originarono dalla regione da loro abitata, si ebbe la fondazione della città di Cartagine, grande antagonista di Roma)
Erodoto di Alicarnasso (484 – 434 a.C.) famoso storico greco attribuisce (*) a Talete la previsione dell'eclissi solare che si verificò il 28 maggio del 585 a.C. e che impressionò talmente i Medi e i Lidi, in guerra tra loro da diversi anni, che smisero di combattere (la battaglia è nota come battaglia dell’eclissi o di Halys essendo avvenuta nei pressi di questo fiume che attualmente si chiama Kizilirmak). Erodoto riporta inoltre che Talete deviò il letto del fiume Halys per consentire all’esercito di Creso (re della Lidia in guerra contro il persiano Ciro il Grande che aveva conquistato il territorio dei Medi) di guadare il fiume.Se l’episodio fosse vero se ne dovrebbe dedurre che Talete non credeva alla presenza delle divinità dei fiumi(**). Inoltre, dal momento che Talete pensava che l’acqua fosse il “principio primo”, sembra strano che abbia agito su di esso (*) secondo Pannekoek questa attribuzione è frutto di una leggenda. (**) nella Teogonia Esiodo attrbuisce al Titano Oceano, figlio di Urano (il cielo) e di Gea, (la terra), la paternità di tutti i fiumi che avrebbe avuto assieme a Teti, sua sorella e moglie. Nella visione di Esiodo i Titani erano le forze primordiali che imperversavano nel cosmo prima dell'azione regolatrice degli Dei dell'Olimpo.
Lo storico greco Diogene Laerzio (180-240 d.C.) famoso per la sua opera Vite e
dottrine dei filosofi illustri (in cui esamina e descrive il pensiero di 83 filosofi e da
cui abbiamo derivato molte delle informazioni sulla storia della filosofia greca)
dipinge Talete come un uomo estremamente saggio.
Laerzio scrive che a chi chiedeva a Talete se
fosse venuta prima la notte o il giorno egli
rispondeva che era precedente la notte, di un
giorno; e a chi chiedeva a Talete quale fosse la
cosa più semplice egli rispondeva: dare consigli a
un altro.
Altre affermazioni attribuite da Laerzio a Talete
sono:
- la cosa più piacevole è avere successo mentre la
più sgradevole è vedere un tiranno che è riuscito ad
invecchiare;
- il divino è ciò che non ha né inizio né fine;
- gli ingiusti non possono sfuggire all'attenzione
degli dei, neanche solo pensando di fare
un'ingiustizia;- non bisogna abbellirsi nell'aspetto ma nei comportamenti,
- bisogna aspettarsi dai figli gli stessi benefici arrecati ai genitori.
Aristotele, invece, nella Politica riporta quello che è conosciuto come
l’aneddoto dei frantoi:
“Talete era criticato dai suoi concittadini, per lo stato di povertà in cui lo
relegava la pratica della filosofia. Pertanto, dopo aver raggranellato una piccola
somma di denaro, avendo previsto con le sue conoscenze scientifiche
un’abbondante raccolto di olive, affittò con largo anticipo (in inverno) tutti i frantoi
di Mileto e dell’isola di Chio. La richiesta era scarsa e lui li ottenne versando
solo un piccolo anticipo.
Giunta la stagione della raccolta (che si
rivelò copiosa come da previsioni) Talete
affittò a caro prezzo i frantoi ricavando un
abbondante guadagno”.
Commentando l’aneddoto Aristotele
sottolineava come un filosofo volendo può
arricchirsi utilizzando le sue conoscenze
ma il fine ultimo della filosofia è la ricerca
libera e disinteressata e non la
crematistica (da χρήματα, ricchezza), ossia
l'arricchimento personale.Platone nel Teeteto riporta invece un aneddoto che testimonia gli interessi
astronomici di Talete, e la sbadataggine che contraddistingue gli uomini di
scienza e i pensatori.
“Egli osservava gli astri e, avendo lo
sguardo rivolto al cielo, cadde in un pozzo.
Si dice che una spiritosa e graziosa
servetta tracia l'abbia preso in giro
dicendogli che si preoccupava di
conoscere quel che succede nel cielo
senza preoccuparsi di quel che gli
avveniva davanti e sotto i piedi. La stessa
ironia è riservata a chi passa il tempo a
filosofare […] provoca il riso non solo delle
schiave di Tracia, ma anche del resto della
gente, cadendo per inesperienza nei pozzi
e in ogni difficoltà.”
Questo aneddoto di Platone è stato ripreso, molti secoli più tardi, da Jean de La
Fontaine (L'Astrologue qui se laisse tomber dans un puits) e trasformato in una
critica verso gli astrologi.è ancora Diogene Laerzio (nella sua Vite e dottrine dei filosofi illustri) a riportare su Talete quanto asserito da Ieronimo di Rodi (290-230 a.C. ca, filosofo paripatetico, ossia appartenente alla scuola fondata da Aistotele) in relazione alla misura dell’altezza della piramide di Cheope. (Questo stesso episodio è stato ripreso in seguito da Plutarco e da Plinio il Vecchio) “Il faraone Amasis (XXVI dinastia, 520 a.C. ca) avrebbe voluto mettere alla prova le abilità scientifiche di Talete sfidandolo a misurare l’altezza della grande piramide. Ammirato per il modo con cui senza esitazione e senza strumenti Talete gli fornì il risultato, il faraone concesse al filosofo greco l’accesso alle loro biblioteche e alla consultazione delle opere ivi conservate”. OK ma come ha fatto Talete ?
I due triangoli (quello i cui cateti sono A e B e quello i cui cateti sono D e B) sono simili per cui A: D = B : C Dalla proporzione risulta che D (la quantità ignota) è pari a (A x C) / B ed essendo A, C e B misurabili si può derivare D.
Secondo Diogene Laerzio, Talete conosceva il giorno in cui l’ombra è uguale alla nostra altezza e quindi non avrebbe piantato un paletto nel suolo ma semplicemente misurato l’ombra e dedotto da tale valore l’altezza della piramide…. Questa storia è plausibile ?’ (la latitudine di Giza è circa 30°). Quando l’ombra (a mezzogiorno) è uguale alla nostra altezza, l’altezza del Sole (a mezzogiorno) è pari a 45° in quanto il rapporto tra i cateti è uguale a 1 e questo implica un angolo di 45° (tg 45°= 1). Essendo h max =90 °−|ϕ|+ δ ne risulta 45=90°−30 °+δ da cui δ=−15 ° plausibile δ≃−23° 30 ' il 21-22 dicembre, δ=0 ° il 22 settembre (il “giorno di Talete” era entro questo intervallo).
A Talete sono state attribuite diverse opere: Astronomia Nautica (che secondo Diogene Laerzio sarebbe invece del filosofo Foco di Samo e entrambi i filosofi ne avrebbero rivendicato la paternità), Sul solstizio, Sull’equinozio e Dei principi (un’opera in due libri). Tuttavia non ne è pervenuta alcuna e pare che nemmeno Aristotele le abbia mai viste. Aristotele nella Metafisica asserisce che Talete identificò il principio originario (ὰρχἠ, archè) nell'acqua, in quanto tutte le cose (ad esempio i semi) sono nutrite dall’umido e da esso traggono origine. Il calore stesso in forma di vapore ha origine dall’ umido. Beatrice Bersani (la vostra collega) riporta un’evidenza sperimentale (l’osservazione del formarsi di stalattiti e stalagmiti nelle grotte per effetto della deposizione delle acque) che avrebbe indotto Talete a ritenere che dall'acqua si originassero anche le rocce.
L’osservazione di enorme quantità di acqua sulla Terra e intorno alle terre avrebbe indotto Talete ad ipotizzare che la Terra tonda e piatta (un disco) galleggerebbe sull’acqua: l’Oceano L’acqua, secondo Talete, sarebbe la sostanza primordiale che sta sotto (materia) e che sostiene (forza). Aristotele definisce Talete come il primo filosofo naturale che, abbandonato il mito, ha cercato di trovare una relazione di causa effetto ai fenomeni naturali. Talete non ha lasciato nulla di scritto e tutte le testimonianze sulla sua figura hanno un discreto margine di incertezza. Quello che è certo è che la ricerca del principio primo,l’ ὰρχἠ, sarebbe stata una costante di quella che viene chiamata la scuola di Mileto caratterizzata da una visione naturalistica in cui l’osservazione dei fenomeni e la loro analisi dal punto di vista logico aveva preso il sopravvento sui discorsi esplicativi ispirati al mito.
Anassimandro (610-540 a.C ca)
Filosofo e cartografo appartenente alla scuola di
Mileto Per primo introduce il termine ὰρχἠ
(archè) che identifica nell’ ἄπειρον (apeiron)
(infinito, indeterminato).
Tutto è nell’ apeiron in armonia ma poi avviene
la separazione (forse è la rotazione dell’apeiron
a provocarla) si genera il cosmo e le coppie dei
contrari (giorno notte, vita morte, caldo freddo,
secco umido, ecc). La vita stessa è espiazione
per la rottura dell’ equilibrio, fino al ritorno
all’armonia del apeiron.
Anassimandro aveva osservato che i quattro elementi naturali acqua, terra, aria e
fuoco, mutavano continuamente cosicché aveva pensato di porne uno, l’originario,
al di sopra di tutti.
Esiste un’interpretazione diversa dell’apeiron...secondo Giovanni Semeraro (L’infinito un equivoco
millenario, Mondadori 2002) alla base della quale sarebbe una cattiva traduzione del termine di origine
mesopotamica che nella Ionia significava “polvere”.
Se Semeraro avesse ragione l’archè di Anassimandro sarebbe la Terra.La Terra (il nostro pianeta) per Anassimandro è al centro dell’universo che
ha forma sferica.
La forma della Terra è cilindrica con un’ altezza è pari a 1/3 del diametro di
base . Gli abitanti della Terra si trovano su una delle due facce del cilindro.
La Terra è ferma perché non ha ragione di muoversi in una o in un’altra
direzione essendo equidistante da tutto.
Sole, Luna e Stelle non sono corpi fisici ma
fori entro dei “cerchioni” che ruotano. Il La Terra è abitata solo su una delle
fuoco è visibile solo attraverso i buchi. Le due basi del cilindro. Il fiume Phasis
eclissi e le fasi della Luna si generano (l'odierno Rioni in Georgia) citato
quando i buchi sono totalmente o per la prima volta da Esiodo
parzialmente occlusi (da cosa?) secondo gli antichi divideva
l'Europa dall' Asia.Interessante notare che le distanze dei bordi interni dei cerchioni di stelle
Luna e Sole sono rispettivamente pari a 9 18 e 27 volte il diametro della Terra
(il loro spessore invece è pari a un diametro della Terra).
I valori scelti per le distanze mostrano come il modello si fondi sulla volontà di
“perfezione” (legata al numero 3) non motivata da osservazioni scientifiche.
Il pregio del modello di
Anassimandro è aver eliminato il
sostegno per la Terra : la Terra è
ferma nello spazio e gli astri
possono girare attorno ad essa.
Aezio, filosofo contemporaneo di Plutarco
di cui si sa pochissimo riferisce (secondo
Herman Diels autore dell’opera
Doxographi Graeci, del 1879) che
Anassimandro avrebbe sostenuto che gli
astri sono involucri d’aria a forma di ruota,
pieni di fuoco, dalle cui aperture
fuoriescono fiamme.Anassimene
(585- 526 a.C.)
anch’egli di Mileto probabilmente discepolo
di Anassimandro.
Fa un passo indietro rispetto al maestro identificando
come archè l’aria anche se attribuisce al suo archè
le caratteristiche dell’ apeiron di Anassimandro ossia
infinità e movimento incessante. Tuttavia il
principio originario resta concreto (come l’acqua di
Talete) e non astratto come per Anassimandro
(almeno secondo l'interpretazione più accreditata) .
Nell’unico frammento di Anassimene che ci è
pervenuto si vede come nell’aria identificasse anche
qualcosa di spirituale.
“Come l'anima nostra, che è aria, ci sostiene, così il soffio e
l'aria circondano il mondo intero”.Simplicio (filosofo e matematico bizantino 490-560 ca) citando
Teofrasto (filosofo e botanico greco 371- 287 a.C. ca) a proposito
di Anassimene scrive:
“L’ aria si distingue per via di rarefazione e di condensazione nelle
varie sostanze. E rarefacendosi diventa fuoco, condensandosi
invece diviene vento, poi nuvola, e ancora più condensata, acqua,
poi terra, e quindi pietra.”
Secondo Teofrasto la Terra per Anassimene era piatta e galleggiava
sull'aria.
Anche il Sole e i corpi celesti avevano forma piatta ed erano stati
generati dalla Terra: l’umidità salendo verso l’alto si era fatta fuoco.
Le stelle non si muovevano circolarmente attorno alla terra ma giunte
all’orizzonte contornavano il disco terrestre fino al luogo da cui sarebbero
risorte il mattino successivo.
Nemmeno il Sole girava sotto la Terra ma veniva nascosto dalle
montagne e rimaneva invisibile a causa della grande distanza.Pitagora (Samo 580 a.C ca – Metaponto 495 a.C ca)
Pitagora in un dettaglio del
dipinto La scuola di Atene,
Raffaello, Musei Vaticani.L’immagine mostra la localizzazione di Samo...i viaggi tracciati non sono quelli di Pitagora ma di...San Paolo...
Fonda nel 530 a.C. circa a Crotone la scuola pitagorica.
La scuola è una sorta di ordine
monastico con strette regole che
riguardano la vita e il cibo.
Pitagora non ha lasciato nulla di scritto e
la sua vita è avvolta nel mistero così come
la sua morte. E’ perito in seguito
all’assalto e all’incendio ordito dagli amici
di Cilone ( il Tiranno di Crotone)? O si è
ritirato nel Metaponto ?A Pitagora è attribuita la conoscenza della sfericità della Terra e dell’obliquità
dell’ eclittica. Informazioni che si diffusero fra i navigatori e che fecero
comprendere le ragioni delle variazioni climatiche fra i diversi luoghi.
Diogene Laerzio attribuisce a Bione di Abdera (430 – 370 a.C ca, filosofo
democriteo) l’affermazione che sulla Terra esistevano luoghi in cui la notte e il
giorno duravano sei mesi.(Ci sarà anche un navigatore Pitea di Marsiglia,vissuto fra il
380 e il 310 a.C. che compierà un viaggio verso Nord giungendo fino ad un luogo ove mare
e ghiaccio si fondono. Marsiglia era una colonia greca).
A Pitagora è attributo ancheil riconoscimento della stessa identità per la stella del
mattino e della sera.
Per Pitagora i numeri erano estremamente importanti
La tetraktys è una disposizione geometrica che
rappresenta un numero (10) o alternativamente un
numero (10) rappresentato in forma geometrica.
La tetraktys, numero
triangolareLa tetraktys è un triangolo equilatero col lato pari a 4 e risulta come somma dei primi 4 numeri (1+2+3+4) La tetraktys aveva un carattere sacro per i pitagorici, che giuravano su di essa la loro adesione alla scuola, in quanto rappresentava anche una sorta di modello per l’universo che non era dominato dal caos o da forze oscure ma dall’ordine e dall’armonia dei numeri e dei loro rapporti. Per i pitagorici esisteva una relazione stretta fra i numeri e le forme geometriche che potevano rappresentare attraverso di essi. In noi rimane reminiscenza (inconscia) di questa tradizione quando ad esempio diciamo che 25, 9, 16 sono dei quadrati l numero diveniva così una sorta di archè : - se la qualità delle sostanze è soggettiva la quantità essendo misurabile non lo è più.
Alcuni numeri erano particolarmente importanti per i pitagorici
- 1 o Monade . Rappresenta il principio primo. La sua forma geometrica è il punto.
- 2 o Diade. Rappresenta il femminile: indefinito e illimitato. Rappresenta inoltre l’opinione
che è sempre duplice. Geometricamente è la linea.
- 3 o Triade. Rappresenta il maschile: definito e limitato. Geometricamente è il piano.
- 4 o Tetrade. Rappresenta la giustizia in quanto si può dividere equamente da entrambe
le parti. Geometricamente è un solido.
-5 o Pentade. Rappresenta vita e potere, era il simbolo
di riconoscimento dei pitagorici.
-10 o Decade era il numero perfetto.
I pitagorici avevano una sorta di venerazione per la sfera, un solido che per loro era la
rappresentazione dell’armonia essendo tutti i punti equidistanti dal centro.Il modello pitagorico dell’ Universo si deve a Filolao di Crotone, (Crotone 470 a.C., Tebe 390 a.C.) pitagorico di seconda generazione (secondo Diogene Laerzio) che si sarebbe rifugiato a Tebe (Grecia) in seguito al rovesciamento (450 a.C.) del regime aristocratico di Crotone che era appoggiato dai pitagorici. In quell’ occasione i pitagorici si recarono in altre città della Magna Grecia (Taranto, Siracusa) o a Tebe. Il modello di Universo ha una sola novità nel ruolo marginale della Terra ma per il resto risente fortemente dell’impostazione pitagorica. Al centro è un grande Fuoco, la sede di Zeus, sede dell'attività cosmica. Attorno ad esso ruotano dieci corpi: Terra, Antiterra, Luna, Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, e il cielo delle stelle fisse. I dieci corpi si trovavano lontani dal Fuoco centrale secondo distanze proporzionali a multipli di 3 .
Il Sole è una sorta di grossa lente (più che lente uno specchio ndA) che riflette verso la terra la luce del fuoco centrale (detto anche Hestia, questa è figlia di Crono e Rea, fratelli, figli di Urano e Gea e sposi). La Terra ruota attorno al fuoco volgendo sempre la stessa parte verso l'esterno (dell'universo) quindi non vede il Sole (nè la luce di Hestia) quando si trova opposta ad esso. Non vede mai nemmeno l'antiterra poichè l'unica parte abitata della Terra è quella verso l'esterno. L'antiterra è un artificio di questo modello per dare sacralità al numero dieci in quanto senza di essa I corpi ruotanti attorno al grande Fuoco sarebbero stati 9.
Anassagora (Clazomene 496 a.C, Lampsaco 428 a.C)
a vent’anni si reca ad Atene dove diviene amico e maestro di Pericle, ma gli
avversari politici di quest’ultimo (Cleone, Tucidide) lo accusano di empietà per le
sue opinioni sul Sole e sulla Luna:
- la Luna splende di luce ricevuta dal Sole
- le eclissi lunari accadono quando la Terra (o un altro corpo scuro) intercetta la
luce del Sole (*)
La Terra di Anassagora è nuovamente piatta (come per Talete e Anassimene)
e le stelle ruotano attorno ad essa.
Del pensiero di Anassagora, restano soltanto 22 frammenti (del suo primo libro
sulla Natura). Da essi si deduce che il filosofo era convinto dell'esistenza
nell'universo di altri corpi celesti analoghi a Sole, Luna e Terra generati
dall’unione e dalla separazione dei “semi” ( i “semi” unendosi formavano i corpi
celesti che poi si separavano tra di loro) sparsi ovunque, spinti e ordinati dal
Nous una forza e intelligenza divina che non appartiene alla materia.
(*) non si sa chi fosse l’altro corpo scuro... le eclissi di Luna avvengono quando la Terra si frappone fra il
Sole e la Luna e proiettamdo la sua ombra su quest’ultima.Puoi anche leggere