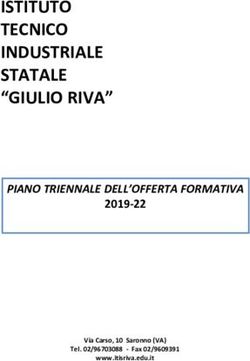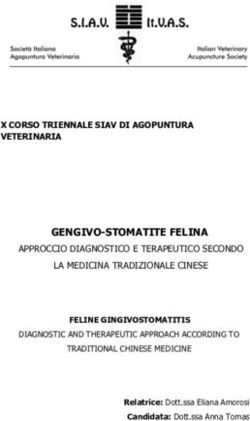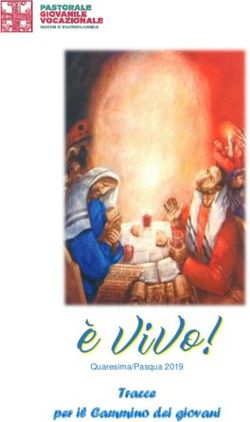Estetica. studi e ricerche - UNISA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
estetica. studi e ricerche Vol. IX, n. 2, 2019 Editoriale p. 347 Tempo e testimonianza tra poesia e filosofia (a cura di Rosa Maria Lupo e Salvatore Tedesco) Rosa Maria Lupo e Salvatore Tedesco Introduzione 349 Salvatore Tedesco Esclusione, parola, silenzio: Mariella Mehr 353 Ambra Carta «Scrivere è un trasmettere». La parola e l’abisso in Primo Levi 367 Francesco Camera «Gedicht und Gespräch». Motivi religiosi nel colloquio di Paul Celan con Nelly Sachs e Margarete Susman 381 Rosaria Caldarone Il desiderio come luogo di testimonianza. A partire da alcuni versi di Paul Celan 399 Filippo Fimiani Se questo è rumore. Lingua, memoria, testimonianza 409 Marcia Sá Cavalcante Schuback La poetica dei cori di Nelly Sachs 423 Leonardo Samonà L’esilio della testimonianza in Paul Celan 441
Varia Giovanni Lombardo Lo σπουδαιογέλοιον e l’arte del serio ludere nell’antichità classica 457 Eleonora Caramelli La paura più grande. Hegel, Macbeth, il servo e la letteratura nella filosofia 477 Elisabetta Mengaldo «Gaia scienza» e «triste scienza». La forma breve in Nietzsche e Adorno 503 Luca Taddio La misura dell’abitare. Osservazioni sull’estetica di Wittgenstein 521 Alice Giannitrapani Don’t Skip Intro. Sigle da non perdere 539 Camilla Robuschi L’estetico come strumento di modellizzazione. La prospettiva biosemiotica 565 Poietiche Claire Fontaine Towards a Theory of Magic Materialism 585 Per Andrea Emo (a cura di Massimo Donà) Andrea Emo Frammenti sull’arte 591 Massimo Donà L’arte e il negarsi dell’assoluto. Andrea Emo: un pensiero estremo 617 Marco Bruni La «perfetta conoscenza» dell’arte. Andrea Emo e la liberazione estetica 647 Federico Croci Euritmie immaginifiche. Iconodulia e iconoclastia in Andrea Emo 659 Francesco Valagussa Andrea Emo e la tautologia della presenza. Coscienza, attualità e trascendenza 669 344 Indice
Laboratorio filosofico
Franco Rella
Freud e Leonardo 681
Indice 345Editoriale
Questo fascicolo, che chiude il nono volume di «estetica. studi e ricerche», ri-
marca un percorso già segnato, lungo le precedenti annate, e ribadito nel primo
numero del 2019, quasi a sugello di un cammino iniziato e qui (solo provvisoria-
mente) concluso intorno al duplice registro della poesia (della letteratura) e della
filosofia. Nelly Sachs, Paul Celan, Primo Levi, Mariella Mehr sono le autrici e gli
autori (i «poeti-testimoni») con cui viene instaurato un dialogo nella sezione, con
la quale prende avvio il fascicolo, «Tempo e testimonianza tra poesia e filosofia»,
a cura di Rosa Maria Lupo e Salvatore Tedesco. L’interrogazione che appare nel
dialogo o, come andrebbe detto meglio, che fa affiorare il dialogo stesso, concer-
ne l’impossibilità, in ultima istanza, della comprensione di quel qualcosa, che
eccede ogni logica, costituito dallo sterminio – e tenendo soprattutto conto di
quella inscalfibile aporia della ragione, che principia direttamente da ogni ma-
nifestazione di sterminio, in quanto inflessibile applicazione di una logica che
non concede più spazio ad alcuna forma di discrimine. È a partire da questo che
poesia e filosofia si incontrano all’intersezione di un ethos che manifestamente
si riconosce in un esercizio politico, nel senso più alto che questo termine può
essere in grado di veicolare.
Apparentemente all’opposto speculare di questa sezione monografica di
apertura, si colloca quella dedicata ad Andrea Emo, curata da Massimo Donà e
aperta da una silloge di frammenti inediti sull’arte del filosofo veneto. Ma si trat-
ta, appunto, solo di un’apparenza, perché se nella sezione di apertura il pensiero,
nel confronto con la parola poetica (letteraria), viene sospinto verso un impegno
(etico) volto ad assumere su di sé il compito di una responsabilità testimoniale,
con Emo si assiste a una teoresi che, riflettendo (su) se stessa, mira a cogliere le
sue ragioni costitutive in un’esistenza che si fa specchio di se medesima, nel di-
spiegamento di una parabola esistenziale (diremmo quasi ascetica), che coincide
con quella (singolare) del suo stesso autore.
Fanno da trait d’union la sezione di saggistica varia e la consueta rubrica
«Poietiche», che raccoglie le riflessioni militanti ovvero quelle che, emergendo
dalla prassi artistica, fanno corpo unico con questa, legandosi, dunque, nel no-
estetica. studi e ricerche – vol. IX – 2/2019 – 347-348 ©Società editrice il Mulino. ISSN 2039-6635stro caso, a uno specifico percorso di immagini. Questa è la volta del duo di
artisti Claire Fontaine, che è stato coinvolto in un seminario, che si è tenuto ai
primi di dicembre presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, insieme all’artista
Daniele Puppi (un cui scritto assieme a un percorso di immagini di sue opere è
stato pubblicato sul n. 1/2019) e ai filosofi Anita Chari, Michael Marder e Gio-
vanbattista Tusa.
Chiude il fascicolo la rubrica «Laboratorio filosofico», che presenta uno
scritto di Franco Rella. Si tratta di una nuova rubrica, varata con questo fascico-
lo, che ci auguriamo possa diventare un appuntamento (quasi) fisso, con cui si
intende dare la parola ai maggiori tra i nostri filosofi, presentando così ai lettori
quegli scritti che si distinguono per una sorta di carattere «incompiuto», come
si conviene a ogni pensiero che si può cogliere in statu nascendi. Si tratterà,
dunque, di note o, anche, di appunti, da (parti di) saggi o da (capitoli di) libri
in via di definizione, la cui lettura ci permetterà di accedere a un determinato
«laboratorio» filosofico, grazie alla cui visita poter apprendere, di volta in volta,
qualcosa di più del modus operandi di maestri contemporanei del pensiero.
Non ci resta, dunque, a questo punto, che augurare a tutti una buona lettura.
D.G.
348 EditorialeRosa Maria Lupo e Salvatore Tedesco
Tempo e testimonianza tra poesia
e filosofia
Introduzione
Alla nota tesi adorniana del 1949 secondo la quale poetare dopo Auschwitz è
espressione di «barbarie» sembra far eco nel 1984 la consapevolezza jonasiana
dell’impossibilità di ammettere dopo la Shoah l’esistenza di un Dio onnipotente,
massimamente buono e comprensibile per la ragione di chi, sulle orme di Giob-
be, chiede il perché del silenzio di Dio ad Auschwitz. Nondimeno, tanto Adorno
nel 1966 quanto Jonas nel suo «frammento di teologia speculativa» riconoscono
la possibilità dell’impossibile, ossia la possibilità non di sciogliere o azzerare, ma
di abitare nell’aporia dello sterminio, che è aporia perché, come ci spiega Gior-
gio Agamben, Auschwitz incarna «la stessa aporia della conoscenza storica: la
non-coincidenza fra fatti e verità, fra costatazione e comprensione»1, posto che
Auschwitz sia, sì, un fatto storico, ma la sua fattualità ecceda la nostra capacità di
comprendere, di farcene una ragione – ammesso che qualcosa del genere possa
mai essere possibile.
Tanto la riflessione filosofica quanto quella teologica ci ricordano, sulla scia
dei poeti-testimoni, che l’aporia è in qualche modo governabile solo invertendo
la logica del dominio in favore di una metamorfosi del vissuto fra le cui pieghe
prende corpo l’idea della vita come possibilità di salvezza, ossia come tempo en-
tro cui il tempo torni a essere tale, e cioè speranza, «pietra che accetti di fiorire»,
come chiede Paul Celan in Corona, o «metamorfosi della fuga» che si fa «desi-
derio del cuore», che come «fuggiasco incatenato» cessi di essere ciò verso cui
sembra per vocazione destinato, ossia ferita, come si trova a scrivere Nelly Sachs.
Solo restituendo il tempo alla vita, la salvezza si fa speranza in quanto salvezza
che, in fin dei conti, riguarda tutti, perché dopo Auschwitz tutti siamo ormai dei
sopravvissuti e siamo tutti esposti, come comprende Primo Levi, nella misura
in cui ad Auschwitz la vittima diventa anch’ella carnefice e il carnefice a propria
volta si mostra vittima di un sistema di cui egli, in quanto singolo individuo, non
è responsabile, o quanto meno non lo è da solo. La salvezza che diviene speranza,
però, non passa e non può passare per l’oblio di ciò che è stato, ma semmai è insi-
1
G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 1998, p. 8.
estetica. studi e ricerche – vol. IX – 2/2019 – 349--352 ©Società editrice il Mulino. ISSN 2039-6635stenza testimoniale di ciò che è stato. Non è, forse, banale insistere su questo in
un tempo come quello odierno in cui ci si torna a chiudere in un nazionalismo
esacerbato che fa dell’altro un nemico da respingere, erigendo muri non sol-
tanto simbolici. Dunque, occorre ancora testimoniare e prestare nuovamente
ascolto alle parole di chi ha subito lo sradicamento dalla vita perché altro, per-
ché diverso.
La sezione monografica che segue si muove sulle tracce del convegno Tem-
po e testimonianza. Celan, Sachs, Levi, Mehr svoltosi nei giorni 19 e 20 ottobre
2016 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo.
Gli autori che qui intervengono, ciascuno a suo modo, provano a mettere in
luce i tratti di una relazione tanto teoreticamente cruciale quanto poetologica-
mente pervasiva come quella fra l’indagine sulla struttura del tempo storico e
determinate esperienze in cui la parola poetica si fa testimonianza dell’indicibi-
le: della sofferenza storica e insieme della verità incancellabile del cuore umano;
un indicibile, custodito nella sua fragile costanza in fondo al crepaccio dei tempi
(Celan). La coppia concettuale tempo-testimonianza dice, infatti, di un dovere
affidato al tempo contro la dispersione della memoria che fa del tempo quasi la
cura per la sofferenza, ma pone insieme domande cruciali: come testimoniare
nel tempo? Come il tempo stesso si fa testimone di ciò che esso stesso rischia di
cancellare? E cosa resta della testimonianza stessa che si affida al tempo?
Se il tempo non si svolge solo cronologicamente e trionfalmente dal passato
verso il futuro, ma se la cura del presente sta piuttosto nel suscitare tempi e vis-
suti altri, custoditi e ripiegati nell’oppressione di quella storicità apparentemen-
te inarrestabile, di quei vissuti e del loro tempo, seme prezioso ma privo di sapore
(Benjamin), occorre portare testimonianza, custodire il respiro, trasmettere la
voce.
Indagando la parola di Paul Celan, di Nelly Sachs e di Primo Levi, prende
corpo la ricerca dei contributi proposti che mettono al centro della loro attenzio-
ne la testimonianza che si costruisce in quell’asse storico e teorico rappresentato
appunto in modo privilegiato – ma non certo unico o esclusivo – dall’esperien-
za testimoniale celaniana, sachsiana e leviana. In un’estensione dolentemente
contemporanea, quindi, l’indagine si spinge fino ad abbracciare nella riflessione
anche la voce altissima di Mariella Mehr, poetessa svizzera di etnia jenisch e
voce fra le più grandi della lirica contemporanea di lingua tedesca, che reca nella
forma di una ferita ancora aperta quella stessa testimonianza e quella stessa luce
intensissima di liberazione, quello sguardo nella cui apertura, malgrado tutto,
è permesso ancora dire. E ciò perché ancora oggi assistiamo, sotto altre forme
non meno cruente, come nel caso della vicenda di Mariella Mehr, al perpetrarsi
di quella logica dello sterminio che non cessa di chiamare a un’assunzione di re-
sponsabilità il pensiero al cospetto della singolarità di un evento, che ormai non
350 Rosa Maria Lupo e Salvatore Tedescoè più solo un’eccezione, rispetto al quale è proprio la nostra ragione a reclamare,
assumendo nella sua stessa indagine teorica il peso del nostro presente storico,
una liberazione da quello stupore massimamente non filosofico per il fatto che
eventi di quel genere possano ancora oggi aver luogo, non abbiano mai smesso
di aver luogo.
Tempo e testimonianza tra poesia e filosofia 351Filippo Fimiani
Se questo è rumore
Lingua, memoria, testimonianza
What if death is nothing but sound?
Don DeLillo
Wer vermöchte einen Ton zu widerlegen?
Friedrich Nietzsche
If This is White Noise. Language, Memory, Testimony
The experience, the memory and the testimony of the concentration and extermination
camps, face up to an inarticulate and indefinable deafening and roaring sound: the mixed
pseudo-verbal mess of the screamed, violent barbarous commands of the executioners blurred
with the patois murmur, with the mumble vociferous and the starving schmooze of the vic-
tims without food, reduced to simple biological mechanism. The «Lagersprache» is analogue
to the «white noise» described by Claude Shannon and Warren Weawer the same years of If
this is a Man and of LTI – Lingua Tertii Imperii by Victor Klemper. If is this fuzzy buzz, the
witness’s memoir, especially of Primo Levi and Paul Celan, is it still a message? What is its
medium? And its content? Is it literal, informational and instrumental? Or literary, citational
and metaphorical? If the survived word is an unsound noise, is despite everything faithful and
true? Or is necessarily flawed and defective?
Keywords: Primo Levi, Paul Celan, Testimony, Lagersprache, White Noise.
1. «Rumore bianco» è una fortunata espressione della cosiddetta «teoria mate-
matica delle comunicazioni», il cui modello descrittivo e procedurale, nato nel
1948 presso il MIT e poi messo a punto per i servizi militari, aprirà la strada alla
cibernetica e molto altro. I due scienziati che la coniano, Claude Shannon e War-
ren Weaver1, erano d’altronde consapevoli del fatto che la loro teoria si potesse
generalizzare e applicare a molteplici situazioni e sistemi in cui avesse luogo una
comunicazione e si trasmettesse un’informazione.
1
La teoria matematica delle comunicazioni (1949), ETAS, Milano 1971.
estetica. studi e ricerche – vol. IX – 2/2019 – 409-422 ©Società editrice il Mulino. ISSN 2039-6635Non stupirà che c’è molto «rumore» nelle pagine di Levi, Celan e Mehr.
Quest’ultima scrive: «C’è ancora rumore / di sventura nella testa»2. Oppure:
Già abbandona
il senso
le mie parole,
persino il silenzio
sembra prigioniero
del vuoto.
Del rumore voglio tacere
al seguito della morte va a puttane
ogni vergogna.
Cosa sono costretta
a scrivere, quello che c’era all’inizio?
Nel sole ho consumato scrivendo
le parole, nei tronchi
nelle pietre le ho incise.
Una soltanto è sopravvissuta: tradimento3.
L’esperienza diretta, la memoria e la testimonianza dei campi si misurano
con un suono inarticolato, indeterminato e indefinibile, con un «rumore» che
sembra non lontano da quello di Shannon e Weawer. Tenerne conto apre una
serie di interrogativi sul se, sul perché e sul come la parola testimoniale sia un
messaggio, su quali ne siano medium e contenuto. E se essa comporti malgrado
tutto una poetica, una retorica e una stilistica, se debba essere letterale, infor-
mazionale e strumentale, o letteraria, citazionale e metaforica, fedele e vera o
difettosa e falsa.
2. Il modello di Shannon e Weawer prevede, in un sistema dato e chiuso, una
fonte e un canale dotato di una certa capacità di trasmissione e soggetto a ru-
more, che disturba e perturba il segnale emesso, peggiora l’informazione e opa-
cizza il contenuto del messaggio da decodificare. «Rumore» è però anche ciò
che permette ai segnali deboli di superare le soglie preposte all’eliminazione di
ciò che interferisce con i segnali forti o principali, e di giungere a una qualche
ricezione proprio perché «sporcati» e potenziati. In questa funzione ecologica
e non negativa del «rumore», sono decisivi il caso, la periodicità e l’entropia:
solo una parte dei segnali deboli che casualmente e ciclicamente entrano in ri-
sonanza con il messaggio non si perde o si degrada, non viene filtrata, cassata o
soppressa, ma, incrementata, emerge e giunge a una qualche destinazione. Mag-
2
M. Mehr, Ognuno è incatenato alla sua ora. 1984-2014, Einaudi, Torino 2014, p. 112.
3
Ivi, p. 121.
410 Filippo Fimianigiore è il disordine del sistema, l’equivocità della fonte del segnale e l’incertezza
della prevedibilità del messaggio, maggiore sono la massa e la libertà di scelta tra
informazioni possibili, la loro eventualità di arrivare a essere recepite. Là dove
si è vittima del «rumore» del processo comunicativo imposto brutalmente dalla
tecnica disciplinare dei campi, può dunque salvarsi un messaggio, opaco ma
ancora da interpretare.
La risonanza stocastica gioca un ruolo decisivo negli eco-sistemi simbolici e
nelle «macchine culturali» in generale, per esempio nelle «provincie finite di si-
gnificato» illustrate dalla sociologia fenomenologica di Alfred Schutz4, elaborata
già prima della fuga dall’Austria per le persecuzioni naziste. Come per Shan-
non e Weawer, come per Schutz, anche per Levi essenziale è il «contenimento»
dell’umano e la chiusura dei campi: fisica, spaziale, materiale, ma anche im-
materiale e immaginaria, linguistica e cognitiva, vissuta ed esperenziale, senza
di essa non c’è possibilità di comprensione. Com’è noto, all’inizio del capitolo
«I sommersi e i salvati» di Se questo è un uomo, Levi propone di considerare il
Lager come «una gigantesca esperienza biologica e sociale»: «Si rinchiudano
tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua,
cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, con-
trollabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso
uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale
e che cosa acquisito nel comportamento dell’animale-uomo di fronte alla lotta
per la vita»5.
Proprio la finitezza e la definizione eterotopica, lo stile del campo – il suo
«taglio» nei confronti del mondo, il suo esser «ritagliato» e fare eccezione –,
permettono di affiancare alla loro incomunicabile esperienza diretta un’osser-
vazione sperimentale e una reiterata chiarificazione da parte di una «ricerca nel
campo». In quanto inedita configurazione antropologica, la disumanizzazione
estrema realizzata nei campi è da documentare, descrivere e analizzare a partire
da un punto di vista etno-antropologico «rovesciato» ed «estraniato»6, costituti-
vo cioè di ciò che viene conosciuto perché in esso inscritto e da esso costretto a
conoscerlo dall’interno, da esule in una estraneità assoluta.
4
A. Schütz, «Sulle realtà multiple» (1945), in Saggi sociologici, UTET, Torino 1979, pp. 181-232.
5
P. Levi, Se questo è un uomo (1958), in Opere, intr. di C. Cases, cronologia di E. Ferrero, t. I,
Einaudi, Torino 1987, p. 88. Si veda Ch. Ross, Primo Levi’s Narratives of Embodiment. Containing the
Human, Routledge, London 2011, pp. 41-62.
6
Riprendo D. Scarpa, Ricerca nel campo, in «Riga», 38, Primo Levi, a cura di M. Barenghi, M. Bel-
politi, A. Stefi, Marcos y Marcos, Milano 2017, pp. 564-573, e F. Pellizzi, La lettura del mondo umano.
L’antropologia rovesciata di Primo Levi, «Italianistica Ultraiectina», 8, 2014, Ricercare le radici: Primo
Levi lettore – Lettori di Primo Levi. Nuovi studi su Primo Levi, a cura di R. Speelman, E. Tonello, S.
Gaig, pp. 125-135.
Lingua, memoria, testimonianza 411All’interno della paradigmatica forma di vita del campo, primario oggetto
di osservazione è la comunicazione. Nel capitolo de I sommersi e i salvati intito-
lato «Comunicare», Levi è molto chiaro: l’incomunicabilità evocata a proposito
dell’Olocausto è «frivola e irritante», è «discorso […] fittizio, puro rumore, velo
dipinto che copre il silenzio esistenziale» e, in realtà, dismette ogni decodifica
dell’intenzione e del significato insito in ogni atto linguistico ed espressivo, in-
cluso gli ordini strillati a squarciagola, «come si farebbe con un sordo, o meglio
con un animale domestico, più sensibile al tono che al contenuto del messag-
gio», o i gesti, i colpi inferti rabbiosi, perché nei campi «non c’è differenza so-
stanziale tra l’urlo e il pugno». Qui, dove «l’uso della parola per comunicare il
pensiero, questo meccanismo necessario e sufficiente affinché l’uomo sia uomo,
era caduto in disuso», l’incomunicabilità è tutt’altra: una «mancanza di comu-
nicazione» assoluta e assolutamente peculiare; qui, dato che «la comunicazione
genera l’informazione, e che senza informazione non si vive», solo «a prima
vista, [si muore] per fame, freddo, fatica, malattia; ad un esame più attento, per
insufficienza d’informazione»7.
Al di fuori del linguaggio elementare e scheletrico del comando, ogni altro
idioma è «non-lingua» e ogni parlante è barbaro, è anzi infans. La Lagersprache
è però affetta da idiotismi e idiosincrasie, creolizzata dal polacco e dall’unghere-
se, corrotta da formule idiomatiche e inquinata da forme monche germaniche:
il monolinguismo del potere è una lingua babelica e impoverita, impura e imba-
stardita, variante imbarbarita minuziosamente registrata come Zeugnis, come
testimonianza di un disastro della civiltà mai visto prima, da Viktor Klemperer,
allievo di Vossler e collega di Auerbach e Curtius, il cui taccuino fu pubblica-
to lo stesso anno in cui apparve la prima edizione di Se questo è un uomo, nel
19478. Altra dal linguaggio laconico delle scienze naturali e dal tedesco classico
colto, la lingua parlata dei campi è «lingua a sé stante», anzi è una «non-lingua»,
un gergo legato al luogo e al tempo della sua pronuncia eppure circolante oltre
i confini e le frontiere in formule semplificate e reiterate, in cui gli imperativi e
gli infiniti fungono da ordini, i numeri stanno al posto dei nomi, le bestemmie
e le urla sostituiscono le interazioni verbali.
Levi descrive la prima impressione del campo in termini di saturazione acu-
stica ambientale: uno spazio sonoro ma non parlato, «pieno di fracasso e di furia
e privo di significato: un tramestio di personaggi senza nome né volto annegati
in un continuo assordante rumore di fondo, su cui tuttavia la parola umana non
affiorava». Di questa massa acusmatica, continua e claustrofobica, c’è una me-
moria «in forma puramente acustica, [una memoria di] parole e frasi pronun-
7
P. Levi, I sommersi e i salvati (1986), in Opere, cit., pp. 720 ss.
8
V. Klemperer, LTI: la lingua del Terzo Reich, taccuino di un filologo (1947), La Giuntina, Firenze
1998; cfr. P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 728.
412 Filippo Fimianiciate intorno a noi in lingue che non conoscevamo né abbiamo imparato dopo»,
grovigli di suoni sciolti finalmente in ritornelli, «come le indecifrabili contine
dei bambini», eppure funzionali e meccanici «come il campanello che condizio-
nava i cani di Pavlov […], [giacché] provocava[no] una subitanea secrezione di
saliva». Questi suoni stranieri d’un parlato mimeticamente ritrascritto «erano
frammenti strappati all’indistinto: frutto di uno sforzo inutile ed inconscio di
ritagliare un senso entro l’insensato», ma anche «l’equivalente mentale [di un]
bisogno corporeo di nutrimento […]: poco più del niente, meglio del niente». Il
punto di vista e per così dire di ascolto di Levi è implicato nel campo osservato,
è insieme «da vicino» e «da lontano», e la sua conclusione è insieme una dia-
gnosi fattuale e una congettura a-posteriori: «Anche il cervello sottoalimentato
soffre di una sua fame specifica», ma, allo stesso tempo, la «memoria inutile e
paradossa» così alimentata poteva avere «un altro significato e un altro scopo:
era una inconsapevole preparazione per il “dopo”, per una improbabile soprav-
vivenza, in cui ogni brandello di esperienza sarebbe diventato un tassello di un
vasto mosaico»9.
La metafora alimentare nega ogni delega della memoria vivente singolare,
patica e incarnata, a una memoria vicaria, materiale e tecnologica, comunque
disponibile e accessibile a piacimento. In apertura de I sommersi e i salvati, la
«verità logora» sulla fallacia, la falsificabilità e la caducità della memoria sarà
detta in termini anti-monumentali e materialisti, propriamente fisiologici: «i
ricordi che giacciono in noi non sono incisi sulla pietra». Non solo «tendono
a cancellarsi con gli anni, ma spesso si modificano, o addirittura si accrescono,
incorporando lineamenti estranei», negoziando cioè con interferenze e
resistenze, repressioni e rimozioni di traumi – un passaggio da una provincia
di senso a un’altra lo è sempre, diceva Schütz10 a partire da James e Freud – e
con alterazioni, degenerazioni e deformazioni, insomma con un «oblio fisiolo-
gico». La memoria, conclude Levi alludendo all’entropia, obbedisce a «una delle
grandi forze della natura, quella stessa che degrada l’ordine in disordine, la gio-
vinezza in vecchiaia, e spegne la vita nella morte», e, aggiungerei con Shannon e
Weaver e Mandel’štam, smorza l’informazione nel rumore del tempo.
La segnatura mnestica è dunque plastica ed effimera, può assottigliarsi o
cristallizzarsi, e i ricordi più sfocati e offuscati, se osservati con attenzione e pre-
cisione da scienziato e naturalista, possono diventare pietre, quasi in uno sguar-
do di Medusa invertito11. È forse anche in questo senso che è stato detto che,
per Celan (ma lo si potrebbe dire anche della Mehr e della Sachs), «la memoria
9
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., pp. 724-726, anche per le citazioni successive.
10
A. Schütz, «Sulle realtà multiple», cit., pp. 204 ss.
11
Così in M. Mehr, «Ieri ancora», in Notizie dall’esilio, Effigie, Milano 2006, pp. 14-15.
Lingua, memoria, testimonianza 413è nelle pietre»12. A patto d’intendere che si tratta, da una parte, di una memoria
orfana sia della permanenza della natura e della storia naturale, sia della storia
e delle pratiche simboliche allestite, tramandate o cancellate dalle civiltà degli
uomini, e, dall’altra parte, di pietre inadatte a fungere sia da geroglifici per una
reminescenza magica o archetipica, sia da hypo-mnemata, da monumenti13 che
soccorrono e agevolano una rammemorazione individuale o collettiva puntuale.
3. Levi sembra dunque preferire alla scrittura litografica l’incorporazione del
suono e la fame, all’analogia epigrafica e monumentale quella mediale e ali-
mentare: le voci straniere del campo s’incidono nella memoria «come su un
nastro magnetico vuoto, bianco», allo stesso modo di «uno stomaco affamato
[che] assimila rapidamente anche un cibo indigesto»14. Il dispositivo tecnico è
come un apparato fisiologico e il paragone illustra il funzionamento basilare di
un essere vivente espropriato di ogni soggettività, ridotto a sistema di conser-
vazione biologica, e, apparentemente, di uno scrittore convertito in dispositivo
di trascrizione. Il corpo proprio è solo la sua meccanica inintenzionale, la sua
necessità elementare e animale – fressen, il «mangiare delle bestie»15. L’analogia
elide ogni differenza e istituisce anzi un’omologia tra la memoria singolare di un
sopravvissuto e una mmemotecnica sub-individuale della sopravvivenza di un
organismo in estremo pericolo di vita.
Per questo, il mangiarsi le parole dei deportati nel campo è diverso da quel-
lo degli oppressi di cui parla Adorno. «Dettata dalla fame», la parola dei secondi
si sazia di quanto biascica tra i denti e proietta sul corpo della lingua l’offesa che
le è stata inflitta, replicando con la violenza impotente della voce grossa16; per
così dire detta dalla lingua barbara della violenza, quella dei primi si accontenta
di ripetere balbettando suoni a stento compresi per sostituire e introiettare una
denutrizione estrema. Nella bocca dei prigionieri, il pane, «il sacro blocchetto
grigio» come lo chiama Levi, è solo un lacerto fonetico strappato all’insensa-
to e indistinto «rumore di fondo» dello storpiato multilinguismo del campo.
È «pane-Brot-Broit-chleb-painlechem kenyér», è una parola altrui e straniera
12
J. Bollack, voce «Mémoire/oubli», in B. Cassin (a cura di), Vocabulaire européen des philosophies.
Dictionnaire des intraduisibles, Editions du Seuil – Le Robert, Paris 2004, p. 773.
13
J. Derrida, La farmacia di Platone (1972), Jaca Book, Milano 1985, pp. 88-89.
14
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 724. Cfr. R. Di Castro, «La fame di Primo Levi: memoria
della fame / fame di memoria», in R. Di Castro e I. Kajon (a cura di), Traûma e Psyché. Le ferite del
Novecento nella riflessione artistica e filosofica, Lithos, Roma 2014, pp. 99-122; andrebbe riletto in que-
sto senso lo straordinario corpus analizzato da Leo Spitzer in Perifrasi del concetto di fame: La lingua
segreta dei prigionieri italiani nella Grande guerra (1920), a cura di C. Caffi, trad. di S. Albesano, Il
Saggiatore, Milano, 2019.
15
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., pp. 75-76, e I sommersi e i salvati, cit., pp. 729-730.
16
Th.W. Adorno, Minima Moralia (1951), Einaudi, Torino 1954, p. 113.
414 Filippo Fimianirimasticata e alterata – anche libresca: tra gli altri, di Rabelais, Folengo e Dante,
onnipresenti in Se questo è un uomo –, invece di un reale seppur misero ali-
mento. Indigeribile e quasi impronunciabile, non è neppure l’oscuro «boccone
/ d’insepolta poesia / [che] ha trovato dente e lingua» di cui scrive Celan17.
Nel campo, dove l’equipaggiamento biologico universale ha preso il so-
pravvento sul potere relativo del linguaggio di strutturare l’esperienza sensibile,
la decodifica di un siffatto segnale acustico, impuro e incerto, e la sua ricezione
in quanto informazione, inquinata ma vantaggiosa per la sopravvivenza, dipen-
dono pur sempre da una necessità vitale. Fuori, nella vita «salvata» e nella for-
mazione necessariamente interminabile della memoria dell’offesa, tale messag-
gio «sporco» può cessare di essere reale e diventare segno fisiologico o psichico,
rovinosamente ossessivo e incompleto; assillo e mania, può essere oggetto di
interpretazioni quasi divinatorie, condivise o segrete e idiosincratiche, reiterate
e interminabili, in cui, come per molti sopravvissuti, ogni cosa sembra segno
di qualcos’altro, ogni brusio una voce, ogni ghirigoro un profilo. In Celan, per
esempio, la morte «è da decifrare» ancora e sempre, e il poeta è «caricato di se-
gnali», è «collettore / di segnali»18.
Il «non esser parlati a»19, che per Levi contraddistingue la mancanza di co-
municazione del sistema concentrazionario, vincola così a un «essere parlati
da». Dentro e fuori il Lager, per così dire dentro e fuori l’orecchio degli uomini
sopravvissuti all’Olocausto – quell’«orecchio come patria» ma «ostruito dall’or-
tica», di cui scrive Nelly Sachs20 –, contro e malgrado il «rumore», qualcosa per-
siste come profetico, pur non essendo né preferito né proferito da qualcuno in
carne ed ossa: fenomeno acustico fattuale o babelica risonanza psichica, voce
straniera o vocio interiore, «cosa» sonora o fantasma acustico, ritornello senza
fonte o ritorno in eco di parole degli autori più amati. Qualcosa richiede ancora
sensibilità e attenzione, qualcosa riappare ancora all’ascolto di chi scrive e te-
stimonia.
Tali permanenze e ripetizioni non sono elementi di una poetica o cifre di
una metaforica, esplicitamente o implicitamente mobilitate nella scrittura let-
teraria e saggistica di Levi; sono piuttosto sintomi di una casualità benevola
che non è, però, meno vincolante ed esigente; sono segni di una tyche, di una
necessità e di una responsabilità della rammemorazione a-posteriori. Sono ma-
nifestazioni sonore di una figuralità della lingua in cui si mostra l’impossibilità
tanto della omogeneizzazione e della cancellazione imposta del linguaggio to-
17
P. Celan, «Paesaggio», in Poesie, a cura di G. Bevilacqua, Mondadori, Milano 1998, p. 598.
18
P. Celan, «Occhi-di-ardesia», ivi, p. 672, e «Collettore», ivi, p. 940.
19
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 724.
20
N. Sachs, «Le stelle si oscurano», in Poesie, Einaudi, Torino 1971.
Lingua, memoria, testimonianza 415talitario, «nero», quanto della continuità e della trasparenza di quella che Levi
chiama «testimonianza integrale», impassibile e «bianca».
Ci tornerò nelle conclusioni. Per ora, mi preme dire che tale coloritura della
lingua, anzi delle lingue, dell’Altro21, ascoltabile nei campi e, starei per dire con-
tro Adorno, perfino cantabile malgrado il «rumore bianco» del gergo totalitario
del potere, sembra essere illustrata dalla copertina, disegnata con le consuete in-
telligenza e sensibilità da Munari, per Se questo è un uomo nella collana dei «Sag-
gi» einaudiani, del 1958. In primo piano, il nero pieno e piatto impone il profilo
irregolare e oppressivo di staccionate e di un taglio orizzontale perfettamente a
metà della copertina, e ospita i caratteri netti, in bianco, del nome dell’autore,
dell’editore e del titolo; questo nero non è però solo: dietro di esso, su quel poco
che resta del fondo bianco, cinque strisce verticali, come papiers collés varia-
mente colorati, in beige, arancione, blu indaco, e, in basso, in un rosso primario
ma ambivalente, vivo e accesso dall’arancione e incupito dalle sovrapposizioni
con il blu e il verde, fusi in semitrasparenza in un viola molto carico, unione
dell’umano e del divino secondo Jung ma anche del sangue rappreso e ossidato.
4. Rileggiamo allora un’altra volta l’analogia de I sommersi e i salvati: «Voci stra-
niere si erano incise nelle nostre memorie come su un nastro magnetico vuoto,
bianco»22. Vale la pena ricordare che la pellicola di celluloide, prodotta dalla
BASF dal 1935, era massicciamente e sapientemente utilizzata per la propagan-
da e la documentazione tedesca grazie ai registratori AEG, della cui tecnologia
si approprieranno poi gli Alleati, fino a commercializzare, con John Mullin, la
Ampex e la Crosby Enterprise, registratori a nastro molto diffusi presso le emit-
tenti radiofoniche e le grandi case discografiche. Aldilà dell’archeologia mediale
e della sua storia culturale, mi interessa però l’ontologia del medium acustico
richiamato qui da Levi, altrove accanto a quello fotografico e filmico23.
Decisivo è, infatti, che il supporto materiale di registrazione analogica
evocato dallo scrittore torinese accolga e conservi in maniera continua e senza
interruzioni il reale in quanto tale. Reale che resterebbe, invece, inarticolato e
inimmaginabile, fuori dalla portata di altri strumenti e tecniche di riproduzione
e rammemorazione24. Per parafrasare una citazione riportata da Benjamin in
21
Sul multilinguismo, rimando agli studi di Cases, Cavaglio, Cicioni, Gordon e Belpoliti, Gram-
ling, Giulio e Laura Lepschy, Mengaldo, Pepe.
22
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 724.
23
Si vedano P. McMurray, Once upon a Time: A Superficial History of Early Tape, «Twentieth-
Century Music», XIV, 1, 2017, pp. 25-48; F. Engel, Zeitschichten: Magnetbandtechnik als Kulturträger,
Polzer Media Group, Potsdam 2008; H. Thiele (a cura di), 50 Jahre Stereo-Magnetbandtechnik: Die
Entwicklung der Audio Technologie in Berlin und den USA von den Anfängen bis 1943, Audio Engi-
neering Society, Brussels 1993.
24
Mi limito a F. Kittler, Grammophon Film Typewriter, Brinkmann & Bose, Berlin 1986, pp. 24 ss.,
416 Filippo FimianiParigi, Capitale del XIX secolo25, la cui traduzione italiana per Einaudi è contem-
poranea a I sommersi e i salvati, direi che anche per Levi il passato lascia delle
immagini acustiche del tutto analoghe a quelle che la luce imprime sulla pellico-
la foto-sensibile. Come dirà in una celebre intervista a Philip Roth, sempre del
1986, Levi riprende quasi alla lettera Il sistema periodico e afferma che, superata
la crisi dell’inserimento nell’ordine del Lager e sviluppata una «strana callosità»,
non ha «mai smesso di registrare il mondo e gli uomini intorno a [lui], tanto
da serbarne [molto dopo] un’immagine incredibilmente dettagliata»26. La me-
tafora fotografica, d’altronde molto diffusa – per esempio in Proust e Valéry,
Bergson e Freud –, dice che solo retrospettivamente e indipendentemente dalle
intenzioni e dalla volontà del soggetto, il futuro potrà reagire con le tracce del
reale depositate profondamente nella sua memoria, svilupparle e renderle final-
mente presenti e visibili, e ristabilirne fedelmente la realtà e la verità.
Questo vuol dire che non solo la rilevazione del ricordo – visivo e acustico,
e non importa quanto insignificante e accidentale – arriva necessariamente in
ritardo e in differita, e non solo la restituzione completa e non filtrata del passa-
to prende un certo tempo, ma, soprattutto, che la pazienza che una tale tempo-
ralità in gran parte inconscia richiede al soggetto sembra essere in definitiva una
passività analoga all’indifferenza del supporto materiale di registrazione – e alla
«curiosità […] del naturalista che si trova trasportato in un ambiente mostruoso
ma nuovo, mostruosamente nuovo», che Levi, nella succitata intervista a Roth,
apostroferà come «cinica» –: come il nastro magnetico o la pellicola fotografica
sono indifferenti e sensibili a tutto quanto può impressionarli, nulla escluso,
così è il corpo disumanizzato e apatico del prigioniero, la meccanica fisiologica
che è ridotto ad essere per sopravvivere. La condizione di possibilità della «te-
stimonianza integrale» del campo e del suo «rumore di fondo», sembra essere
la medesima della registrazione ottica e acustica del reale, e il medium vivente
del corpo proprio sembra rispondere alla stessa ontologia (e allo stesso mito) del
realismo e della trasparenza del medium meccanico.
Philippe Mesnard27 ha più volte parlato della «fatica testimoniale» di Levi,
proponendo, sin dalla prima edizione di Se questo è un uomo, una vicinanza
con le riflessioni coeve di Lévinas e Blanchot – in De l’existence à l’existant e La
e J. Sterne, Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press, Durham &
London 2003, pp. 548 ss.
25
W. Benjamin, Parigi, Capitale del XIX secolo, a cura di G. Agamben, Einaudi, Torino 1986,
[N15a, 1], p. 626. Il passo è di André Monglond, Le Préromantisme français (1930).
26
P. Levi, P. Roth, «L’uomo salvato dal suo mestiere. Intervista di Philip Roth a Primo Levi»
(1986), in P. Levi, Primo Levi: Conversazioni e interviste, a cura di M. Belpoliti, Einaudi, Torino, 1997,
p. 87; cfr. P. Levi, Il sistema periodico (1975), in Opere, t. I, cit., p. 558.
27
Per esempio in Entre témoignage et mémoire, quelle place pour Primo Levi?, «Témoigner. Entre
histoire et mémoire», 119, 2014, pp. 77-90.
Lingua, memoria, testimonianza 417littérature et le droit à la mort – sulla fatica fisica e l’insonnia, intese come situa-
zioni-limite di spersonalizzazione del soggetto e del corpo vissuto, caro alla fe-
nomenologia husserliana, e di una impossibilità di morte autentica, patrocinata
invece dall’esistenzialismo heideggeriano. Accanto a tali richiami e a sostegno
dell’ipotesi che la relazione indessicale tra registrazione meccanica audio-visi-
va e reale sembra essere utile per descrivere la genesi e il funzionamento della
«testimonianza integrale» dei «sommersi» e, in maniera negativa, della me-
moria imperfetta e lacunosa dei «salvati», ricordo anche che, sempre nel 1947,
si registra il primo show radiofonico di Bing Crosby ed esce una ristampa di
l’«Ontologie de l’image photographique» di André Bazin28. A mio avviso, come
quello acustico che ho già commentato, anche il realismo fotografico e filmico
argomentato in queste pagine può essere messo in relazione con la memoria e la
storia, intesa tanto come res gestae, quanto come historia rerum gestarum.
L’occhio dello storico può essere infatti paragonato all’occhio meccanico
del mezzo fotografico. In un articolo straordinario, Kracauer sostiene che se
la fotografia restituisce il continuum spaziale, lo storicismo crede di poter ri-
costruire il continuum temporale, crede cioè di «spiegare qualsiasi fenomeno
unicamente sulla base della sua genesi [e] della catena degli avvenimenti nella
loro successione temporale, senza tralasciare nulla»29. Una siffatta storia sarebbe
l’equivalente di una immensa «fotografia del tempo» o di un «film gigantesco»,
o di un field recording, di una lunga registrazione sonora sul campo: sarebbe
completa e neutra, in tutto e per tutto esatta e senza lacune, aderente fino a es-
sere l’analogo permanente e il sostituto monumentale del suo oggetto. Il reale,
l’accaduto, sarebbe finalmente sepolto da una siffatta superficie continua e com-
patta come un manto di neve, un po’ come quella che, nel finale del racconto
di Joyce, The Dead, ricopre e rende equivalente tutto e tutti, i vivi e i morti30.
28
A. Bazin, «Ontologia dell’immagine fotografica» (1945), in Cos’è il cinema?, Garzanti, Milano
2000, pp. 3-10.
29
S. Kracauer, «La fotografia» (1927), in La massa come ornamento, Prismi, Napoli 1982, p. 114.
30
Ecco, nella traduzione di Franca Cancogni, il passo del racconto del 1904 che chiude The Du-
bliners: «Un battere sui vetri lo fece voltare verso la finestra. Aveva ripreso a nevicare. Assonnato
guardava i fiocchi neri e argentei cadere di sbieco contro il lampione. […] E l’anima gli svanì lenta
mentre udiva la neve cadere stancamente su tutto l’universo, stancamente cadere come cadeva la loro
ultima ora, su tutti i vivi e i morti». J. Joyce, Racconti e romanzi, a cura di G. Melchiori, Mondadori,
Milano 1974, pp. 228-229. A tale sublime annullamento del soggetto, opporrei l’impossibile evasione
da sé imposta all’assoggettato organismo biologico nei campi: «Poi, in seno ai vapori delle digestioni
torpide, leggiamo in Se questo è un uomo, un nucleo doloroso si condensa, e ci punge, e cresce fino a
varcare le soglie della coscienza, e ci toglie la gioia del sonno. “Es wird bald ein Uhr sein”: è quasi la
una. Come un cancro rapido e vorace, fa morire il nostro sonno e ci stringe di angoscia preventiva:
tendiamo l’orecchio al vento che fischia fuori e al leggero fruscio della neve contro il vetro, “es wird
schnell ein Uhr sein”. Mentre ognuno si aggrappa al sonno perché non ci abbandoni, tutti i sensi sono
tesi nel raccapriccio del segnale che sta per venire, che è fuori della porta, che è qui...»: P. Levi, Se
questo è un uomo, cit., pp. 68-69.
418 Filippo FimianiNon sarebbe difficile rintracciare in queste pagine di Kracauer una vicinanza a
quanto l’altro grande teorico del «realismo» che ho già ricordato, Bazin, dirà sul
«complesso della mummia»; in particolare, sarebbe anzi opportuno riflettere sul
rapporto tra la scrittura storiografica, la genesi meccanica dell’immagine foto-
grafica (e acustica) e il desiderio di illusione e di vittoria sulla morte.
Come che sia, prima di soffermarmi, per concludere, sulla sorprenden-
te metafora introdotta da Kracauer e discutere un altro «sguardo» (e un altro
«ascolto») dello storico che essa introduce, voglio invece ricordare, seppur
troppo velocemente, quanto ha scritto Giorgio Agamben sulla «testimonian-
za integrale». Mi sembra infatti che «l’essere nella sua integrità e compattezza,
pura sostanzialità senza soggetto»31, considerato come l’oggetto stesso della «te-
stimonianza integrale», quella che i «sommersi» non hanno potuto attestare e
restituire perché non sopravvissuti, abbia proprio le medesime qualità messe in
luce da Kracauer discutendo la relazione tra fotografia, realtà storica e discorso
storico. Paradossale equivalenza tra opacità e trasparenza, dato che Agamben32
fa dell’impossibilità e dell’impassibilità della «testimonianza integrale» la con-
dizione negativa e necessaria della presa della parola testimoniale «vera», e tut-
tavia inevitabilmente manchevole e monca, di chi è rimasto in vita, come Levi.
Finalmente, la «testimonianza integrale» della memoria meccanica dei
mussulmani e dei sommersi sarebbe come il sapere assoluto della conoscenza
storica, come la registrazione sonora e fotografica, come la neve indifferente su
ogni cosa. In ogni caso, sembra trattarsi di coerenza senza scarti, di continuità
senza lacune, di totalità senza differenze; finalmente, di una medesima ontolo-
gia e di un unico mito.
5. «Sotto la fotografia di una persona – si legge nel passo di Kracauer in parte
già citato – c’è la sua storia, sepolta come da un manto di neve […] [Perché] la
storia si rappresenti, deve essere distrutto il nesso superficiale che la fotografia
raffigura»33.
Si potrebbe accostare questa analogia alle numerosissime ricorrenze della
neve nella scrittura concentrazionaria, a patto di non ricondurla né a un banale
naturalismo, né a un oscuro simbolismo, e di non ridurla a questioni di poe-
tica ed esegesi, di genere e stile. Di tale elemento naturale è, infatti, ancora da
fare una «microstoria»34 culturale, attenta alle fonti e alle discendenze letterarie,
31
G. Agamben, Ciò che resta di Auschwitz, L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri, Torino
1998, pp. 137-138.
32
Ivi, pp. 31 ss., 152 ss.; P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., pp. 716 ss. Si veda anche J. Kelly, Primo
Levi. Recording and Reconstruction in Testimonial Literature, Troubador, Burlington 2000, pp. 95 ss.
33
S. Kracauer, «La fotografia», cit., e p. 125 per le citazioni precedenti.
34
Fu proprio Levi a sdoganare in italiano il termine in «Carbonio», ultimo racconto di Il sistema
Lingua, memoria, testimonianza 419scientifiche e intertestuali, nonché ai registri epistemici e agli usi ermeneutici
diversamente mobilitati, per esempio, in Levi e Celan. Lasciando ad altri tale
lavoro, rievoco qui, certo troppo rapidamente, la neve non bianca, color di co-
lomba, ma grigia, nera, la neve che non è neve ma «fango avido»35, la neve che
è «inquinata»36 e «corrotta» anche al momento della liberazione, ma che è pur
sempre «preziosa»37, perché è acqua e cibo, goccia e briciola liquida di vita.
La neve dunque non è solo neve: è, ci dice Celan, «creta e calcina. / E ghiaia»38.
Ed è la «neve delle cose taciute»39 e sottratte alla vista, segrete e clandestine, ma
anche delle cose «per nulla scritte»40, delle «cose non scritte, indurite / a linguag-
gio»41 e proprio per questo, come già insegnava Benjamin, bisognose di essere
lette42. La neve, infatti, inesorabile perché pur sempre evento naturale e memen-
to temporale per il tempo fuori dei cardini, sospeso e coatto, dei campi, non con-
sente nessuna memoria dei morti abbandonati e ammassati senza sepoltura. Lo
spazio innevato dei campi di sterminio nega la logica sostitutiva elementare della
monumentalità e la localizzazione della rammemorazione funeraria. Tuttavia, i
morti «parlano neve» (Sachs): in che lingua? E quale orecchio, quale bocca, qua-
le mano, la potrà mai ricevere e restituire? Quale sarà il colore di una tale parola?
In White Noise, uscito un anno prima di I sommersi e i salvati, leggiamo
che «la morte non è nulla ma suono»43. È un rumore, scrive DeLillo, che «si
sente per sempre e ovunque», «uniforme, bianco»; proprio come l’eco sonoro
del «rumore di fondo» dei campi ancora nell’orecchio interiore di chi scrive e
testimonia. «A volte mi invade – dice un personaggio del romanzo dello scritto-
re nordamericano – a volte mi si insinua nella mente, a poco a poco. Io cerco di
parlarle. “Non adesso, morte.”».
Certo, queste battute c’entrano poco con lo scrittore torinese: se DeLillo
riscrive un sermone protestante44 molto popolare, dedicato originariamente a
periodico (1975): lo ricorda C. Ginzburg, «Microstoria. Due o tre cose che su di lei» (1994), in Il filo e
le tracce, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 244-247.
35
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 66.
36
Id., I sommersi e i salvati, cit., p. 771.
37
Id., La tregua (1963), pp. 215-216, 165.
38
P. Celan, «Alata notte», in Poesie, a cura di G. Bevilacqua, Mondadori, Milano 1998, p. 217.
39
Id., «Con alterna chiave», ivi, p. 189.
40
Id, «Sopra vento», ivi, p. 285.
41
Id., «A la pointe acerée», ivi, p. 431.
42
«Was nie geschrieben wurde, lesen», è citazione da Der Tor und der Tod, del 1893, di Hugo von
Hofmannsthal: W. Benjamin, «Sulla facoltà mimetica» (1933), in Angelus Novus, Einaudi, Torino
1982, p. 74.
43
Don DeLillo, Rumore bianco (1985), Einaudi, Torino 2010, p. 238, anche per la citazione suc-
cessiva.
44
«Death is nothing at all. It does not count. […] Nothing has happened. Everything remains exactly
as it was. I am I, and you are you…» Questo l’inizio di The King of Terrors (1910) del canonico Henry
Scott Holland, Facts of the Faith, Longmans, Green & Co., London 1919, p. 125.
420 Filippo FimianiEdoardo VII e letto anche per la morte non meno improvvisa di John «John»
Fitzgerald Kennedy jr., e si riferisce all’implosione tecnologica e consumistica
della società globalizzata, in Levi il fenomeno storico inedito dell’atrofizzazione
antropologica dell’umano è invece la tecnicizzazione radicale del vivente realiz-
zata nei campi. Eppure, nell’uno e nell’altro, colui che parla non si annulla nelle
eco di un monologo interiore senza interlocutori e il linguaggio e la letteratura
non cedono il passo alla morte e al silenzio.
D’altronde, se la morte è suono come vuole DeLillo, o, come nota Levi, il
«rumore di fondo» onnipresente nel Lager, e se questo, come dimostrano We-
aver e Shannon, è un’astrazione, allo stesso modo anche una «scrittura bianca»,
trasparente e impersonale, è un mito o un’utopia. Com’è noto, in pagine cele-
bri, iniziate nel 1947, Barthes evoca, per esemplificare tale «scrittura al grado
zero», la scrittura parlata di Queneau e Jean Cayrol, autore del testo letto da una
anaffettiva voce off in Nuit et Brouillard di Alain Resnais. Opposta alla retorica
dell’indicibile, dell’irrappresentabile e dell’inimmaginabile, insomma alla falsa
incomunicabilità dell’Olocausto duramente denunciata anche da Levi, una tale
scrittura sarebbe «basica» e «strumentale», «da giornalisti». Rivelerebbe «senza
colori»45 la verità sull’uomo e la realtà inumana dei campi, il suo essere, per
riprendere un’ultima volta Kracauer, «non penetrata dalla coscienza»46 ed estra-
nea al significato.
Non c’è una «scrittura bianca» perché non c’è una parola specifica e au-
tosufficiente, l’unica giusta per dire in maniera definitiva il «rumore bianco»
dell’esperienza concentrazionaria e dell’esistenza umana ridotta a meccanismo
biologico. A dirlo, ogni volta daccapo e mai per sempre, c’è sempre e solo la
lingua comune della letteratura.
Filippo Fimiani
Università di Salerno
Dipartimento di Scienze Politiche
e della Comunicazione
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA)
fimiani@unisa.it
45
R. Barthes, Il grado zero della scrittura (1953), Torino, Einaudi 1982, pp. 28 ss. e 55-57.
46
S. Kracauer, «La fotografia», cit., p. 125.
Lingua, memoria, testimonianza 421Puoi anche leggere