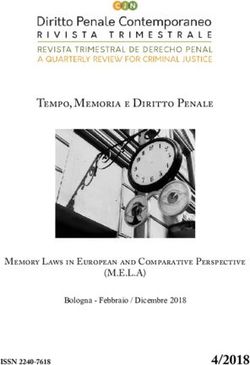CRIMINOLOGIA, RIASSUNTO - (manca parte a scelta che è sul quaderno)
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CRIMINOLOGIA, RIASSUNTO (manca parte a scelta che è sul quaderno) CAPITOLO IV, GLI STUDI BIO-ANTROPOLOGICI 1) La questione eredità-ambiente La dicotomia tra antropologia criminale e sociologia criminale ha prodotto due correnti di pensiero: l’una imperniata sulla vis generativa, ereditaria ed individuale, l’altra sulla vis nutritiva, sociale (concetto di nature and nurture). Tale concetto fu influenzato particolarmente dalla teoria della tabula rasa di John Locke che, insieme alla prima psicologia sperimentale, dava enfasi al ruolo dell’esperienza. La sociologia, se dapprima accoglie la teoria evoluzionista darwiniana applicandola ai fenomeni sociali ed economici, poi inizia a prendere le distanze dai contributi sull’ereditarietà e sul determinismo biologico dettati dal darwinismo sociale. Quest’ultimo riguarda le teorie psicologiche e sociologiche che, utilizzando la concezione evoluzionista di Darwin, studiarono le trasformazioni dei sistemi sociali e ne interpretarono i conflitti (concetti di razza superiore e inferiore e di sopravvivenza del più adatto). Da qui nasce anche il collegamento con i primi sostenitori dell’eugenetica. Tuttavia, la confusione tra obiettivi politici e di propaganda e aspetti scientifici portò a diversi effetti deleteri (es. igiene della razza, leggi sulla sterilizzazione degli individui). Alcune teorie sostengono l’idea che il comportamento deviante debba esser messo in relazione con le caratteristiche fisiche dell’individuo, altre danno importanza all’ereditarietà e alla genetica. In ogni caso, per comprendere l’atto criminale si deve considerare sempre l’interazione tra l’uomo e l’ambiente (teorie bio-sociali). La ricerca biologica ha evidenziato in definitiva l’influenza sul comportamento deviante di fattori genetici, bio-chimici e neuro-fisiologici. Infine, con gli ulteriori sviluppi delle neuroscienze e della genetica si è riportato alla luce l’eterno dilemma sull’esistenza o meno del cosiddetto “gene del male” e la sua importanza nel campo del comportamento antisociale. 2) Antropo-biologia e criminalità. Le tipologie costituzionali La genetica del comportamento è una scienza che cerca di spiegare il livello e la natura della determinazione genetica nelle somiglianze e differenze del comportamento dei singoli soggetti. Ereditario -> caratteri morfologici e fisiologici trasmessi alla progenie Innato -> derivante dai geni, ma non necessariamente ereditato Congenito -> ciò che è presente alla nascita, ma non necessariamente innato Costituzionale -> riferito alla costituzione fisiologica e al substrato biologico
Genotipo -> comprende sia i caratteri innati sia quelli ereditari, è il patrimonio genetico
dell’individuo
Fenotipo -> comprende le caratteristiche morfologiche e funzionali dell’individuo prodotte
dall’interazione dei geni tra loro e con l’ambiente.
Partendo dall’affermazione che il comportamento umano è il risultato di alcune caratteristiche
fisiche e biologiche, i primi criminologici studiarono tali caratteristiche per arrivare a definire i
connotati distintivi del “tipo criminale”. Cesare Lombroso fu il primo che si spinse in questa
direzione trovando in alcuni delinquenti caratteristiche fisiche inferiori comuni (asimmetria
facciale, naso schiacciato, orecchie a sventola con lobo allungato, labbra carnose, braccia lunghe).
Tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 ci furono i primi tentativi di individuare le determinanti
biologiche della deficienza mentale e di varie forme di comportamento deviante e criminale che
iniziarono con gli studi sulle famiglie criminali.
Tra i nomi da citare ricordiamo:
- Charles Goring, pur negando l’esistenza di un tipo fisico criminale, rilevò dai suoi studi che
coloro che erano meno intelligenti e meno dotati sul piano fisico presentavano una
predisposizione più elevata per il crimine;
- Earnest Albert Hooton sostenne che i delinquenti erano inferiori in quasi tutte le
misurazioni corporee e che tale inferiorità era dovuta all’ereditarietà.
Molti studiosi poi hanno collegato il tipo somatico con il temperamento tentando di dimostrare
l’esistenza di una relazione tra determinati tipi costituzionali e vari aspetti della personalità. Ernst
Kretschmer ne distinse tre:
- Il tipo leptosomo: snello, testa piccola, torace ristretto, spalle esili, ossatura delicata,
carattere rigido, freddo, riservato e poco socievole;
- Il tipo atletico: muscoloso, ossatura grossa, torace ampio, temperamento stabile, non
nervoso, ma a volte esplosivo;
- Il tipo picnico: corpo tozzo, viso largo, carattere allegro, socievole e affabile
- Il tipo displastico differente dagli altri tre, ma caratterizzato da disturbi ghiandolari.
Kretschmer individuò poi se vi fosse una relazione tra i tipi costituzionali e la predisposizione verso
alcune malattie mentali: egli definì schizotimici i tipi leptosomi e atletici (=avrebbero più
facilmente sviluppato una schizofrenia se avessero contratto una malattia mentale) e ciclotimici i
picnici (=più probabilità di diventare maniaco-depressivi). Successivamente, mise in relazione tali
tipologie con il delitto rilevando come i tipi costituzionali si distribuissero proporzionalmente nei
delinquenti come nella popolazione in generale: i leptosomi erano più frequenti tra ladri e
truffatori, gli atletici tra coloro che commettevano delitti contro la persona e sessuali, i picnici fra
gli autori di frodi e i displastici tra i delinquenti sessuali.
William Sheldon rilevò un’elevata correlazione tra tre tipi corporei e un determinato tipo
temperamentale:
- Gli ectomorfi (leptosomi) in cui prevale inibizione, riflessione e ipersensibilità;
- I mesomorfi (atletici) in cui prevale piacere per l’attività muscolare, aggressività verso gli
altri e l’autoimporsi; -> sembrano, per Sheldon, quelli più coinvolti nel comportamentocriminale per via di alcuni loro tratti predisponenti ad atti aggressivi, ma giocano un forte
ruolo (come noteranno autori successivi) anche l’apprendimento e i condizionamenti
ambientali.
- Gli endomorfi (picnici) in cui prevale l’amore per le comodità, socievolezza, affettività,
ghiottoneria.
Per ultimo va citato Eysenck che ha ipotizzato nei criminali l’eredità di un sistema nervoso centrale
che non si fa condizionare dai processi di socializzazione e dall’apprendimento sociale e tali
caratteristiche predispongono poi l’individuo verso condotte antisociali.
3) Studi genetici sui gemelli e sui soggetti adottati
Si è studiata la relazione tra il tipo di comportamento antisociale dei gemelli monozigoti e quello
dei gemelli dizigoti. Assumendo che l’ambiente sociale sia lo stesso per entrambi i gemelli, se
l’ereditarietà gioca un ruolo importante nel determinare il comportamento criminale, si dovrebbe
giungere al risultato che i gemelli monozigoti dovrebbero averlo simile rispetto ai gemelli dizigoti.
Dai diversi studi effettuati è emerso che nei gemelli monozigoti c’è una caratteristica genetica che
aumenta la probabilità che loro siano coinvolti in azioni criminali. Tuttavia, la somiglianza rilevata
nel comportamento di tali gemelli potrebbe essere dovuta a una maggiore conformità di
esperienze nel processo di socializzazione e nell’ambiente di appartenenza come ad un loro
identico substrato ereditario.
Gli studi sui soggetti adottati hanno analizzato se il loro comportamento fosse più simile a quello
dei genitori adottivi (influenza dei fattori ambientali) oppure a quello dei genitori biologici
(influenza dei fattori genetici); è emersa una maggiore concordanza della delinquenza con la
condotta deviante dei genitori biologici.
Il problema rimane comunque aperto perché da altre ricerche è emerso il ruolo svolto dai fattori
ambientali.
4) Il cromosoma criminale
Dalle ricerche effettuate sulla relazione tra caratteristiche genetiche innate e criminalità è emerso
che coloro che possiedono una mutazione genetica relativa al cromosoma extra Y sono
maggiormente predisposti a comportarsi in maniera antisociale e violenta. Da notare le
implicazioni relative a tali soggetti sul piano dell’imputabilità e della pericolosità sociale ai fini della
punibilità; essi, infatti, non avrebbero alcuna possibilità di interventi riabilitativi e rischierebbero
l’ergastolo o di essere internati a vita in ospedali di massima sicurezza. Studi successivi hanno poi
disconfermato la relazione tra l’anomalia cromosomica XYY e la malattia mentale o il
comportamento deviante.
5) I fattori biochimici
Molti studiosi hanno rilevato differenze significative sul comportamento in base al tipo di
nutrizione, disfunzioni cerebrali e agire deviante.- Un elevato contenuto di zucchero o al contrario un significativo basso contenuto di
zucchero, basso consumo di triptofano e carenze vitaminiche sono state associate a
condotte criminali.
- Altri ricercatori hanno collegato i livelli di androgeni e testosterone con l’antisocialità; più
sono elevati tali livelli più frequenti sono i comportamenti violenti.
- Altre analisi hanno associato le attività devianti delle donne con le variazioni ormonali
legate al ciclo mestruale.
- Ulteriori studi si hanno sulle cerebro e neuro allergie in rapporto alle condizioni ambientali;
quando una sostanza (es. serotonina) è presente in eccesso la persona attua
comportamenti che potrebbero trasformarsi in criminali.
- Non vanno trascurati gli effetti dei prodotti chimici sul comportamento (inquinamento
ambientale).
- Sostanze stupefacenti, alcool e droghe provocano violenza, aggressione, irritabilità,
agitazione che potrebbero trasformarsi in condotte criminali.
6) Neuroscienze e crimine
Biologi e neuroscienziati hanno cercato di analizzare il ruolo svolto dai fattori neurofisiologici
nell’agire deviante servendosi dell’EEG, ovvero si è cercato di capire se vi fosse o meno una
relazione tra alcuni tipi di onde cerebrali anomale e il comportamento antisociale. I risultati
mettono in evidenza la presenza di anormalità nei tracciati dei criminali violenti con discontrollo
degli impulsi. -> Disturbo da deficit di attenzione\iperattività: disturbo del neurosviluppo che porta
a difficoltà di concentrazione ed a manifestazioni impulsive che determinano disadattamento
sociale e a volte comportamenti a rischio di devianza. Caratteristiche: carenza dell’attenzione,
manifestazioni impulsive e iperattive prima dei 12 anni di età, ostinazione, ribellione, negativismo,
prepotenza, labilità d’umore, scarsa tolleranza alle frustrazioni, bassa autostima… Fattori
predisponenti: ritardo mentale lieve o moderato, epilessia, forme di paralisi cerebrale. Cause:
esposizione a neurotossine, stress prenatale, abuso.
Anche disfunzioni e danni cerebrali possono essere collegati al comportamento deviante;
attraverso raggi X, TAC e RM, si sono associati deficit funzionali e strutturali soprattutto nella
regione della corteccia prefrontale con comportamenti antisociali e violenti.
Medicinali, sostanze chimiche o stupefacenti, lesioni cerebrali come traumi cranici e neoplasie
spesso causano una modificazione nella personalità e nel comportamento che implica labilità
emotiva, apatia, idee paranoidi, poco controllo degli impulsi, comportamenti socialmente
sconvenienti. -> Disturbo organico di personalità\modificazione della personalità dovuta ad una
condizione medica generale: sindrome prefrontale con deficit cognitivi e\o disturbi
comportamentali, emotivi e motori. Un comportamento impulsivo o esplosivo può essere di
pericolo per il soggetto stesso e per gli altri fino a diventare causa di gravi delitti.
Soggetti affetti da tumore cerebrale potrebbero trasformarsi in aggressivi e violenti proprio a
causa di una forma tumorale nel cervello e sviluppare atteggiamenti sociopatici e sessuali alterati.Dalle diverse indagini formulate anche più recentemente è emerso come l’origine degli atteggiamenti devianti sia per metà da attribuire a fattori genetici e per l’altra metà a fattori ambientali. Si è poi cercato di trovare il gene specifico che potrebbe essere legato all’origine di tali comportamenti: il MAO-A potrebbe essere il gene ed è ereditario soprattutto in soggetti maltrattati durante l’infanzia. La questione ha una sua importanza anche se si guardano i risvolti in campo forense di tutto ciò: un soggetto affetto da un disturbo psicopatologico potrebbe vedersi la pena ridotta o potrebbe anche venire assolto. In conclusione, molte ricerche genetiche e neuroscientifiche sono entrate a pieno titolo anche nella letteratura criminologica senza dimenticare che si deve considerare un paradigma biosociale riferito al crimine che permetta di comprendere i legami tra ambiente sociale, cervello e comportamento. La presenza di una patologia organica o anomalia cerebrale o alterazione genetica può provocare un comportamento deviante ed essere considerata determinante indipendentemente dalle condizioni ambientali, ma si deve comunque ricordare che tali teorie non offrono una spiegazione valida per la maggior parte degli atti criminali commessi da persone normodotate. Si auspica un cammino di integrazione tra diverse discipline: le neuroscienze che servono per comprendere il funzionamento del sistema nervoso e di conseguenza individuare adeguati trattamenti terapeutici e le scienze umane che servono per conoscere e spiegare le esperienze e i significati che il soggetto attribuisce alle proprie azioni.
CAPITOLO V, PSICOLOGIA E DELITTO
1) Alcuni concetti fondamentali
Ci sono numerose interpretazioni del crimine in ambito psicologico in cui è enfatizzato il ruolo
dell’autore nella criminogenesi e nella criminodinamica→ in questo approccio si da maggior
rilevanza ai tratti di personalità nei comportamenti e azioni devianti.
È necessario definire e distinguere 3 concetti:
Temperamento→ deriva dal greco “temperamentus” = mescolanza, in questo caso mescolanza
dei
vari umori del corpo.
In generale il temperamento ha una base innata e biologica e si può definire come disposizioni
e tendenze innate peculiari che ogni individuo ha e utilizza nell’operare nel mondo e nell’agire
nell’ambiente.
Ippocrate e Galeno distinguono 4 tipi di temeperamento:
Collerico o bilioso
Sanguigno o nervoso
Flemmatico o linfatico
Melanconico o atrabiliare
Kretschmer identifica 2 tipi di temperamento:
- Schizotimico
- Ciclotimico
Altri autori (Birnbaum)→ il temperamento è un aspetto formale della personalità nei fattori
istintivo-affettivi che condizionano il comportamento
Il temperamento si differenzia dal carattere poiché non comprende le qualità dell’individuo che
orientano le direttive della sua condotta.
Carattere→ per Kahn si divide in 2 elementi principali:
La valutazione dell’io rispetto al mondo
Lo scopo delle direttive
In altre parole, il carattere è visto come un’interazione fra il temperamento e l’ambiente in
cui il soggetto è inserito, mostrandosi come una componente dinamica che si modifica nel il
tempo e con gli eventi che ne plasmano gli effetti. Queste modificazioni non avvengono ad
un livello profondo e si riducono man a mano che si invecchia.
In generale il carattere deriva dal greco e significa scalfire, impronta, segno impresso e lo si può
definire come la particolarità, l’impronta, che la persona lascia nelle sue azioni e che si manifesta
in
determinati tipi di esperienza sistematizzati come totalità→ costituisce un aspetto della
personalità.
- In filosofia, Kant suddivide in mondo:
fenomenico→ con carattere empirico (azioni determinate)
noumenico→ con carattere intellegibile (libero)
Personalità→ deriva dal latino e significa maschera; in generale si può definire come la totalità
affettivo-volitivo del soggetto, compresi la tendenza istintiva, il temperamento e il carattere.• Allport definisce la personalità come “l’organizzazione dinamica all’interno dell’individuo di
quei sistemi psicofisici che determinano il suo adattamento unico all’ambiente”.
• L’approccio sistemico vede la personalità all’interno del processo di “causalità circolare”, in
cui la personalità interagisce e reagisce con l’ambiente in una dinamica di reciprocità.
Mettendo insieme queste visioni si può quindi definire la personalità come “l’organizzazione di
attitudini, credenze, abitudini e comportamenti, oltre ad altre caratteristiche, che si sviluppa
nell’individuo attraverso l’interazione sociale.”
Dalla prospettiva psicologica, quindi, è un’acquisizione che si ha dopo la nascita essendo la
risultante della socializzazione e delle relazioni sociali.
Le teorie Psicologiche della criminalità possono avere focus diversi:
➢ Alcune danno rilevanza all’influenza di:
Processi mentali
Esperienze dell’infanzia
Pensieri inconsci
➢ Alcune danno attenzione:
Apprendimento sociale
Percezione
➢ Alcune invece pongono l’attenzione:
⸰ Inadeguatezza o immaturità della personalità
⸰ Senso di frustrazione
2) Psicoanalisi: Freud e il delinquente per senso di colpa
Per molto tempo psicologi e psichiatri si sono interrogati attorno alle personalità criminali senza
giungere ad una spiegazione esaustiva.
Freud diede un contributo importante alla criminologia grazie alle sue teorie sulla
personalità, aiutando a spiegare il comportamento antisociale.
Nei suoi scritti, egli definisce la personalità come il risultato dell’esperienza sociale
evidenziando l’importanza dell’esperienze dell’infanzia e i conflitti derivanti dalle richieste
che la società avanza con i bisogni individuali.
Freud nella personalità distingue tre parti:
Io→ è la parte razionale che frena gli impulsi biologici dell’es; parte della struttura
psichica conscia e razionale; è il mediatore tra l’es (pulsioni) e il super-io (imperativi).
Fattore di legame dei processi psichici, zona difensiva della personalità dove risiedono i
meccanismi di difesa
Es→ costituisce la parte pulsionale, più istintiva che risiede nella nostra coscienza; in
parte è innata/ ereditaria in parte è acquisita/rimossa; riconducibili a Eros (istinto vita) /
Thanatos (istinto morte) che possono essere rivolti anche all’esterno; non ha il senso del
tempo, dell’ordine e della morale, solo spinta verso il piacere
Super-io→ è l’insieme delle regole etiche e morali che sovrastano l’es e la ragione (io);
interiorizzazione delle norme, regole, divieti dei genitori e della società; funzione dicoscienza sociale, auto-osservazione; è la componente che permette la messa in atto di
comportamenti accettati socialmente e reprime gli istinti asociali; da una visione dell’io
ideale secondo l’aspettativa sociale.
Freud ricollega la criminalità ad un inconscio senso di colpa che prova il soggetto, infatti
ritiene che alcuni criminali mentre commettono l’atto hanno una percezione persistente del
senso di colpa che è la motivazione scatenante del comportamento criminale→ secondo lui
infatti, il comportamento criminale potrebbe essere il risultato di “un conscio iperattivo che
causa un potente senso di colpa”, e che viene messo in atto per poi essere arrestati e puniti
in modo da ottenere un sollievo mentale dal senso di colpa.
Le condotte antisociali sono il senso di colpa che insorge come risultato tra il conflitto del
super-io con i desideri aggressivi e sessuali infantili.
Questa ipotesi non si può estendere a tutti i criminali.
La tesi freudiana del senso di colpa del delinquente viene rivista e ripresa da varie teorie
psicoanalitiche (e sono quelle esposte nei paragrafi successivi).
3) Reik e la coazione a confessare
T. Reik nella sua teoria parla della “Coazione a confessare” ovvero la “manifestazione attraverso atti
di dimenticanza (lapsus) e di trascuratezza sulla scena del delitto, oppure con atteggiamenti di
disprezzo e arroganza, quasi provocatori, in sede di interrogatorio di polizia e di giudizio”. Sono
come delle forme di auto-accusa che reik dice essere dovute al bisogno di punizione per il senso di
colpa, poiché il sollievo da senso di colpa lo si ottiene solo se il delitto viene scoperto (secondo
Mannheim un es. è “delitto e castigo”).
Rispetto alle teorizzazioni di Freud e Reik ci sono 2 ipotesi:
1- Il senso di colpa porta a commettere un delitto, ricercando la punizione per ottenere sollievo
ma che in un secondo momento spinge la persona a reiterare il delitto per ottenere un’altra
punizione→ possibile interpretazione per criminali recidivi.
2- In questo caso il desiderio della punizione e il senso di colpa sono così intensi che il soggetto
non volendo liberarsi facilmente e rischiando di vedere diminuita la pena, decide di non
confessare
In questo caso Reik sostiene che la punizione sia inefficace e anzi controproducente, poiché
invece che avere effetto deterrente sul delinquente potrebbe attrarlo nel commettere altre
azioni criminali, portando ad essere mancante la funzione preventiva.
Musatti sostiene che le funzioni superiori della pena derivino da una razionalizzazione
secondaria operata dal pensiero giuridico.4) La diagnostica criminale di Alexander e Staub
Contributi importanti sono dati alla psicocriminogenesi da studi psicoanalitici. Freud mette in
evidenza due tratti fondamentali per la psicologia criminale: 1) l’egoismo e 2) una forte tendenza
distruttiva.
Alexander, Staub e Healy formulano una nuova teoria dove viene riconosciuto il ruolo importante
dell’es nell’agire e negli impulsi criminali ma viene anche mostrato il ruolo fondamentale dell’io,
infatti quando quest’ultimo è fragile è più probabile che si mettano in atto comportamenti devianti.
In questa teoria, gli autori classificano la criminalità gradualmente in relazione alla partecipazione
che avviene dell’Io:
a) Criminalità fantastica→ l’io partecipa in minima parte e le azioni criminali, qui, rimangono a
livello di sogni e fantasie→ il super-io è molto forte e non permette all’aggressività di realizzarsi
mentre l’io compie una dislocazione portando gli istinti a livello di fantasia
b) Criminalità accidentale→ qui la partecipazione da parte dell’io aumenta e avviene ad opera di
persone non criminali→ il super-io non permette che vi sia un’aggressività diretta ma si
manifesta attraverso l’io che mette in atto con condotte imprudenti
c) Criminalità cronica→ la partecipazione dell’io risulta totale e avviene ad opera di personalità
criminali→ gli autori ne distinguono 4 sottocategorie:
➢ Azioni criminose per processi tossici o biopatologici→ sono reati prodotte da persone
affette da patologie mentali su base biologica, con gravi ritardi mentali o dovuti ad
intossicazione cronica da sostanze
➢ Azioni criminose dovute da motivazioni inconsci→ vi è un forte conflitto tra ES e Super-io
che trova soluzione nell’azione deviante, non è una scelta dell’io criminale ma è una
riduzione della tensione conflittuale. (es. piromani, cleptomania, ecc..)→ collegate a nevrosi
ossessivo-compulsiva e a razionalizzazioni psicotiche in cui la colpa viene proiettata
all’esterno sugli altri
➢ Azioni criminose del delinquente normale con Super-io criminale→ la formazione del
super-io avviene con un’identificazione con modelli criminali; in questa sottocategoria
rientrano vagabondi, capibanda, professionisti criminali, ovvero soggetti che si sono
integrati e adattati ad una sottocultura criminale
➢ Azioni criminose da delinquente genuino senza Super-io →il soggetto è inadatto alla vita
sociale e traduce i suoi impulsi istintivi in azioni immediate; è quindi privo di un controllo
interiore e di un’interiorizzazione.
In questa teoria viene anche messa in evidenza l’importanza del super-io nella
manifestazione di comportamenti criminali.
5) Antisocialità per impulsi proibiti dei genitori di Johnson
Bowlby ha evidenziato l’importanza dei legami affettivi e come la carenza affettiva da parte dei
genitori o la troppa severità possa creare nel figlio conflitti irrisolti e sensi di colpa insoddisfatti
provocando il bisogno di creare situazioni che comportino delle punizioni. In questi casi il Super-io
dei bambini si è sviluppato in maniera discontinua e incostante creando delle lacune che avranno
delle ripercussioni anche a livello antisociale o scolastico.Johnson crea la teoria eziologica della delinquenza individuale inconscia che parte dal presupposto
che il le modalità antisociali del figlio siano inconsciamente sia sanzionata che incoraggiata dai
genitori, che ottengono attraverso le azioni del figlio la soddisfazione a dei loro impulsi proibiti e
poco integrati. Questo elemento genitoriale può essere la causa dei comportamenti antisociali del
minore, da cui si possono anche individuare il tipo di comportamento deviante e le tecniche che
saranno adottate.
L’autore, infatti sostiene che passare da un completo permissivismo (dato dall’approvazione
inconscia) a punizioni e proibizioni farà sentire il figlio ingannato e tradito e insegnandogli a sua volta
ad ingannare.
Personalità psicopatiche sono ritenute dall’autore, lo sviluppo e maturazioni di una coscienza etica
difettosa.
Le lacune presenti nel Super-io sono sia nei figli che nei genitori, e quest’ultimi attraverso i primi
possono ottenere la soddisfazione inconscia alle proprie tendenze devianti.
Secondo Johnson, però, questa teoria può spiegare solo comportamenti devianti di giovani che
appartengono a classi agiate; altri autori, invece, ritengono che questa teoria valga anche per ragazzi
appartenenti a classi sociali basse visto che gli atteggiamenti genitoriali e la formazione del super-
io sono precedenti all’entrata nelle gang in cui invece verrà acuita la personalità antisociale.
6) Mailloux e la teoria della “pecora nera”
In criminologia un altro concetto molto importante è quello di identità, definita come
“organizzazione costante nel tempo, nello spazio e nei contesti sociali, della rappresentazione
mentale del soggetto, della sua presentazione pubblica della percezione e del sentimento del sé.”
Quindi si possono ritrovare 2 dimensioni rispetto all’identità:
- Quella intrapsichica
- Quella culturale-relazionale
Nelle analisi di devianza ci si è riferiti molto alla “scelta dell’identità negativa” durante l’adolescenza
proposta da Erikson.
Strettamente connessa al concetto di identità, vi è la teoria sulla personalità del delinquente “tipico”
proposta da Mailloux. L’autore sostiene che il giovane delinquente si caratterizzi per una percezione
di sé negativa che deriva dall’interiorizzazione di aspettative negative rispetto a se date dai genitori
o da figure significative, in altre parole l’ambiente invia messaggi negativi al ragazzo che poi li
assimila e in cui poi s’identifica, e che lo portano poi a compiere azioni devianti reiterandole e a cui
seguiranno punizioni che confermeranno l’immagine negativa di sé, creando un circolo vizioso.
Il sentimento che insorge nel ragazzo è di inferiorità e disagio sociale che lo porterà a creare
un’immagine di se come cattivo compensando così l’inadeguatezza e avvicinandolo a sottoculture
delinquenti dove sarà accettato. Secondo lo studioso P.A. Achille la ricerca d’identità in questi
ragazzi si ha grazie alla socializzazione con il gruppo e dove l’identità negativa troverà sostegno e
dove prenderà il sopravvento il super-io di gruppo e portando quindi il ragazzo a diventare da adulto
un criminale professionista che, quando condannato pubblicamente avrà una riconferma della sua
identità negativa.
In questi casi la rieducazione dovrebbe consistere in un percorso a ritroso dove il soggetto arriva a
rielaborare le varie fasi fino al giudizio della “pecora nera” dato dalle figure significative.Tra studi sociologici interazionisti-simbolici vi è la teoria dell’etichettamento di Becker che sostiene
che “è il significato sociale dell’esperienza che porta alla stabilizzazione della devianza.”
7) I meccanismi di difesa
I meccanismi di difesa stanno alla base del comportamento sia conforme che deviante e si possono
definire come “operazioni psichiche, in parte inconsce e a volte coatte , adottate per ridurre o
sopprimere qualunque elemento che possa turbare l’integrità e l’equilibrio dell’io e che si
oppongono alle esigenze dell’ES in modo da evitare la possibilità di conflitti con il Super-io e la
realtà.”
I meccanismi di difesa più rilevanti e d’ interesse per la criminologia sono i seguenti:
❖ Identificazione→ processo psicologico per cui l’individuo assimila e s’identifica con un
aspetto, una proprietà, un attributo di un soggetto o “oggetto” piacevole trasformandosi
totalmente o in parte sul modello di questo. Questo meccanismo è anche detto “introiezione
o incorporazione”. Dal punto di vista criminologico è interessante perché:
- ci possono essere scelte criminali basate sull’identificazione con soggetti reali o fantastici
- ci può essere un’identificazione con l’aggressore, portando il soggetto ad assumere la
stessa funzione aggressiva, imitandolo e adottando nuovi simboli distintivi (es. l’adulto
che abusa il minore dopo essere stato da piccolo abusato a sua volta)
- ci può essere un’identificazione con l’aggressore che sta alla base della sindrome di
Stoccolma
❖ Proiezione→ operazione psichica con cui il soggetto sposta da sé nell’altro (cosa o persona)
sentimenti, qualità, desideri che non riconosce o rifiuta. Aiuta ad evitare l’angoscia per
sentimenti non socialmente accettati o negativi soprattutto nel caso di un super-io rigido
(spesso pregiudizi, superstizioni e opinioni si basano su proiezioni).
Per la criminologia è d’interesse perché attraverso la proiezione della colpa possono
verificarsi delle forme di comportamenti delinquenti e devianti poiché la motivazione
dell’atto avviene in base all’attribuzione a persone o oggetti esterni di comportamenti
emotivi e tendenze che in realtà sono interni al soggetto (es. omicidio, deliri persecutori,
gelosia).
❖ Razionalizzazione→ processo in cui il soggetto cerca di dare una spiegazione logica e
coerente o moralmente accettabile rispetto ad un’azione un atteggiamento, un sentimento
o un’idea di cui non si percepiscono le vere motivazioni. Questo processo può avvenire anche
durante i deliri.
È un meccanismo di difesa in cui si trovano rispetto alla situazione motivazioni che sono
apparentemente accettabili e fondate per il super-io, e quindi può comportare la messa in
atto di comportamenti antisociali poiché avvallati come leciti nonostante non lo siano.
A livello criminologico possiamo riscontrare questo processo soprattutto i soggetti che
hanno compiuto delitti politici o a sfondo ideologico, in cui i motivi razionali nascondono
inconsce tendenze aggressive. Questa interpretazione è collegata strettamente alla teoria
del simbolismo psicoanalitico il quale sostiene che ogni oggetto, persona azione può avere
un valore inconscio che rappresenta qualcosa di diverso. Quest’ultima teoria sostiene,
quindi, che nell’inconscio rimangono cariche spiacevoli che possono in qualche momento
riemergere influenzando pensieri e azioni ma mascherandosi dietro una simbolizzazioneirriconoscibile e dove il vero significato rimane inconscio (es. la persona che viene aggredita
può rappresentarne simbolicamente un’altra)
❖ Rimozione→ l’io cerca di respingere o mantenere nell’inconscio rappresentazioni legate ad
una pulsione che invece di procurare piacere comporterebbe un dispiacere. Si origina da un
conflitto di desideri opposti inconciliabili. I “rappresentanti ideativi” possono riemergere
producendo una situazione di angoscia- aggressione che può comportare la messa in atto di
comportamenti aggressivi e devianti. In ambito criminologico sono interessanti le forme di
amnesia:
- Dopo aver commesso un delitto in soggetti affetti da isteria
- Da parte della vittima dopo un evento traumatico (es. abusi sessuali infantili)
❖ Formazione reattiva→ atteggiamento o stato psicologico contrario ad un desiderio rimosso
e formato in reazione contro di esso (es. la crudeltà repressa è mantenuta inconscia da
un’eccessiva compassione verso gli altri). La sovracompensazione e il formarsi di reazioni
sono misure difensive dell’io contro tendenze inconsce represse, finché tali misure
funzionano (es. odio per la persona amata può improvvisamente esplodere, perché si si
sente traditi, e diventare spietato). Spesso questo meccanismo avviene nei delitti passionali.
Le teorie psicoanalitiche permettono lo studio di comportamenti e azioni criminali, analizzandoli
come un sogno e considerandoli come il modo con cui il delinquente cerca di ridurre delle tensioni
interiori e di soddisfare bisogni inconsci.
La criminogenesi ha derivazione da un’impulsività egocentrica in cui il comportamento
dell’individuo rappresenta una reazione sintomatica poiché il soggetto prova un malessere che lo
blocca dall’aspirare a integrarsi socialmente.
In generale le interpretazioni psicoanalitiche, nonostante gli approfondimenti rispetto alle
motivazioni e alle dinamiche che portano il soggetto a compiere comportamenti devianti, data la
loro indimostrabilità scientifica e visto che sono considerate speculazioni filosofiche nel campo della
giustizia penale non è possibile utilizzarle; però possono offrire un mezzo diagnostico differenziale
rispetto alla delinquenza e possono apprestarsi come strumento terapeutico per il riadattamento
sociale. Inoltre, queste interpretazioni e questi studi sono utili nell’analisi delle testimonianze, infatti
si è potuta notare una tendenza razionalizzatrice che opera sul ricordo introducendo la massima
unità e coordinazione nell’evento. La deformazione dell’evento avviene non solo nella fase del
ricordo (fase mnestica) ma anche quando lo si vive e assimila (fase percettiva).
I processi deformatori delle testimoniane sono:
Il processo di unificazione→ funzione per cui il troppo complesso viene semplificato
riducendo così gli elementi.
Il processo di sdoppiamento→ qui si ha la sensazione di ricchezza e complessità della scena
ma gli elementi ricordati sono effettivamente pochi e quindi si ha la necessità di riempire la
scena.8) Comportamentismo e teorie dell’apprendimento sociale
Le TEORIE DEL COMPORTAMENTISMO nascono nei primi del Novecento con l’idea di basarsi su
dati obiettivi, per cui come dati di osservazione saranno ammessi solo quegli eventi che possono
essere verificabili da uno sperimentatore. Di conseguenza l’attenzione sarà spostata sui concetti di
stimolo, risposta e di comportamento.
Watson
Ci si deve limitare allo studio del comportamento, controllabile e misurabile in base al sistema di
risposte date agli stimoli dell’ambiente. Il suo maggior interesse riguardava l’eliminazione della
soggettività e dell’imprecisione.
Di interesse per la criminologia è il suo concetto di “dottrina estrema dell’importanza degli
influssi ambientali”.
Spiega le differenze individuali per mezzo dei processi di apprendimento. In base al
meccanismo del condizionamento, l’associazione ripetuta di uno stimolo ad una risposta
faceva in modo che dopo un periodo di tempo, a quello stimolo seguiva la risposta
condizionata.
Tolman
Descrive il comportamento sul piano molare, cioè ogni atto della condotta ha caratteri del
tutto specifici, identificabili e descrivibili indipendentemente dai processi muscolari e
neurali
Ogni comportamento è considerato come finalizzato agli obiettivi
L’individuo non impara sequenze di movimenti, ma aspettative sorte da precedenti
esperienze
Al posto del rinforzo subentra il principio della conferma
Variabili intervenienti: intervengono tra stimolo e risposta modificandone il rapporto
Per studiare un comportamento è necessario considerare, oltre alle condizioni dello
stimolo, la storia evolutiva dell’organismo
Hull
Il suo principio fondamentale stabilisce che lo stimolo iniziale è solo il primo anello di una catena
di avvenimenti che portano alla fine alla reazione. Tra stimolo e reazione ci sono molte variabili
intervenienti.
Skinner
Il concetto di base è che si ha una condotta di partenza che può essere modificata e controllata
attraverso una variazione sistematica di stimoli che hanno una funzione di rinforzo. Si può quindi
plasmare mediante rinforzo, premiando ogni inclinazione verso la direzione desiderata e non
premiando ogni propensione indesiderata. Di conseguenza la condotta è controllabile e perciò
modificabile per mezzo di stimoli.
Il suo scopo è di prevedere e controllare ogni condotta indipendentemente da qualsiasi processo.
→
Dalle teorie del comportamentismo ha origine la convinzione che il comportamento sia appreso
ed il rifiuto dell’idea che l’aggressività sia l’espressione di una pulsione innata.
I comportamenti criminali, compresi quelli più violenti, sono perciò considerati come risposte
(apprese) alle condizioni sociali ed alle situazioni di vita.Da tenere in considerazione però il fatto che i presupposti del comportamentismo si basano su
esperimenti fatti in laboratorio mentre nella vita reale la situazione è differente perché manca:
- Sequenza temporale
- Frequenza con cui sono presentati ricompensa/punizione o stimolo condizionato
Quindi in mancanza di un controllo del processo di condizionamento, non è detto che esso
funzioni nella realtà e questo permette di mettere in discussione le terapie comportamentali.
TEORIE PSICOLOGICO-SOCIALI
Bandura – Teoria dell’apprendimento sociale
Secondo questa teoria i controlli interiorizzati si basano sulle conseguenze anticipate di
azioni future che portano all’aspettativa che un certo modo di comportarsi sia premiato,
ignorato o punito.
Viene sottolineato inoltre come non si nasca già con la capacità di comportarsi in modo
violento, quanto piuttosto si apprenda nel corso della socializzazione (tratti di personalità
che si acquisiscono e meccanismi psicologici che sono alla base).
Questa teoria si basa sull’idea che il comportamento aggressivo o violento viene appreso
dai bambini osservando e imitando i modelli di ruolo, che vengono rinforzati con
ricompense e poi assumendo quei ruoli. Ciò che è importante nel determinare tale
apprendimento è il grado di violenza o non violenza dei modelli in natura.
Si è giunti poi a capire che sebbene il modello aggressivo venga emulato, i suoi attributi
sono valutati negativamente → Disimpegno morale: elevati valori morali possono essere
compatibili con il commettere atti riprovevoli perché possono intervenire meccanismi
psicologici che bloccano il senso di autocondanna. Esso opera sotto varie forme:
- Giustificazione morale
- Etichettamento eufemistico
- Confronto vantaggioso
- Spostamento della responsabilità
- Diffusione della responsabilità
- Distorsione delle conseguenze
- Deumanizzazione
- Attribuzione di colpa
Viene messo in evidenza come aggressività e violenza vengano apprese non solo
attraverso l’interazione con gli altri, in particolare nell’ambiente familiare, ma anche in
altri setting sociali (film, programmi televisivi). L’esposizione a mezzi di comunicazione di
massa può produrre 3 differenti reazioni:
- Risposte imitative non presenti nel soggetto
- Effetto inibitorio o disinibitorio su risposte precedentemente acquisite
- Risposte simili, ma effetto di un apprendimento precedente. Quindi i media
possono influenzare i bambini in modo che abbandonino, modifichino, rafforzino o
si creino stili di vita e modelli di comportamento.
Il problema di una socializzazione non conforme o deviante non può essere quindi
addebitata ad una singola fonte.Dollard – Teoria della frustrazione-aggressività
Frustrazione: condizione del soggetto che si vede rifiutare o rifiuta a se stesso il
soddisfacimento di una domanda pulsionale. In psicologia ha 3 accezioni:
- Situazione frustrante: impossibilità di soluzione, impossibilità di uscirne, forte
motivazione all’azione.
- Stato di frustrazione: provocato dalla situazione frustrante, il cui grado varia negli
individui.
- Reazione alla frustrazione: può essere di varia natura ad esempio aggressione,
regressione, fissazione
Comportamento aggressivo: caratterizzato dall’intenzione di distruggere un oggetto,
inanimato od umano, e l’intento può concretizzarsi in un atto o rimanere inattuato.
L’aggressività, essendo un comportamento sociale, non sempre ha una connotazione
negativa e distruttiva, può infatti anche essere positiva e costruttiva.
L’aggressività è sempre conseguenza di una frustrazione
L’esistenza di una frustrazione conduce sempre a qualche forma di aggressività
L’inclinazione all’aggressività diminuisce in rapporto all’intensità delle punizioni attese
come conseguenza dell’agire.
Per quanto riguarda l’aspetto criminologico: il criminale è sottoposto ad una frustrazione
maggiore della media e dispone di una capacitò di previsione della punizione inferiore alla
media, quindi sente più facilmente le frustrazioni ed è meno facilmente condizionato
dall’aspettativa di una punizione.
Il delinquente agisce sempre secondo un meccanismo psicologico che lo porta a giustificare
la propria condotta di base al proprio sentimento di aver subito un’ingiustizia. Quindi
mette in atto il meccanismo di difesa della razionalizzazione o una tecnica di
neutralizzazione.
Questa teoria è stata inoltre utilizzata per spiegare l’influenza dei mass media sul
comportamento antisociale: tali reazioni non sono solo il frutto della visione di messaggi a
contenuto violento, ma anche di quelli a contenuto neutro. Il sottoporre le persone a miti
di facile successo e di invidiata condizione socio-economica equivale a provocare forti
frustrazioni connesse all’impossibilità di raggiungere gli stessi traguardi. Perciò alcuni
possono reagire esprimendo aggrssività
Zimbardo
Ha studiato le dinamiche di Gruppo in un contest penitenziario con lo scopo di analizzare
quanto tale situazione avrebbe influenzato atteggiamenti e comportamenti dei
partecipanti.
Si è dimostrato come il male possa essere commesso da chiunque si trovi in particolari
situazioni. Ciò a dimostrare quanto sia sottile la linea di confine tra bene e male, quando
entrano in gioco certe dinamiche sociali.
9) La così detta “personalità criminale”
La letteratura si è sempre posta il problema del rapporto tra personalità e delitto tanto che la
Scuola Positiva sosteneva la teoria del valore sintomatico del reato, secondo cui il reato è
rivelatore della personalità e di conseguenza nasce la necessità di adeguare la pena al fatto
criminoso inteso come espressione della personalità dell’autore.Da ciò deriva un altro problema che riguarda la colpevolezza e imputabilità di quella categoria di
delinquenti che non sono infermi di mente.
Esiste una categoria di delinquenti che ha una personalità non malata ma abnorme, soffrendo una
psicopatia. Si tratta di personalità psicopatiche il cui valore criminologico si sostanzia in due
enunciazioni:
tra gli elementi della loro personalità è possibile staccare quelli che rompono l’equilibrio
dell’insieme, mentre dalla psicosi deriva la disorganizzazione della personalità completa;
nelle personalità psicopatiche non è assente la moralità dell’atto
Gli psicopatici vengono esclusi dalla legge dalla definizione di infermi perché nulla incide sulla
normalità dell’intelletto.
DSM 5, CRITERI DEL DISTURBO DI PERSONALITA’/PERSONALITA’ PSICOPATICHE
• CRITERIO A: Pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia
marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo e si manifesta in almeno
due delle seguenti aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonali o controllo
degli impulsi
• CRITERIO B: questo pattern abituale risulta inflessibile e pervasivo in un’ampia varietà di
situazioni personali e sociali
• CRITERIO C: determina disagio clinicamente significativo o compromissione del
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti
• CRITERIO D: il pattern è stabile e di lunga durata e l’esordio avviene nell’adolescenza o
nella prima età adulta
• CRITERIO E: il pattern non risulta meglio giustificato come manifestazione o conseguenza
di un altro disturbo mentale
• CRITERIO F: non è attribuibile a effetti fisiologici di una sostanza o di un’altra condizione
medica
Caratteristiche dei soggetti psicopatici:
alloplastici, poiché tendono a soddisfare i propri bisogni attraverso la manipolazione
dell’ambiente esterno e sono
egosintonici, in quanto le alterazioni sono accettate e condivise dal soggetto, quindi il suo
comportamento non gli provoca sentimenti di colpa per la sofferenza causata agli altri
comportamento cronicamente anomalo
abnorme struttura del carattere che rende difficile il modificarsi
I disturbi di personalità non rientrano quindi tra le anomalie del carattere e della personalità. Lo
psicopatico è responsabile del disagio provocato con la sua condotta alla società, la cui relazione è
diversa da quella che si verifica nei confronti del malato di mente.
I disturbi di personalità non provocano alterazioni delle funzioni psichiche fondamentali come
nei disturbi psicotici. Si distinguono per le alterazioni della condotta e per i comportamenti
disadattati e socialmente disturbanti.
È quindi importante la diagnosi differenziale, sia sul piano clinico, sia per quanto riguarda la
valutazione dell’imputabilità. Infatti non essendo considerati malati di mente, i delinquenti con
disturbo di personalità vengono ritenuti capaci di intendere e di volere e perciò imputabili e
punibili.DSM 5: 3 cluster in riferimento ai Disturbi di personalità
Gruppo A:
- Disturbo paranoide
Diffidenza e sospettosità, con costante aspettativa di essere ingannati. Sempre vigili,
dubitano della correttezza e lealtà degli altri. Iperattivazione dell’attenzione e incapacità a
rilassarsi. Attribuiscono agli altri pensieri malevoli che sono proiezioni delle loro paure. La
realtà non è distorta, ma lo è il significato di realtà come appare.
Prospettiva criminologica: litigiosità legale, che può sfociare in battaglie giudiziarie. Le
caratteristiche di questo disturbo possono portare a condotte etero-aggressive.
- Disturbo schizoide
Distacco nelle relazioni e gamma ristretta di espressioni emotive. Freddezza emotiva,
prediligono l’isolamento e hanno difficoltà ad inserirsi. Apparente mancanza di interesse
verso gli altri, con desiderio nascosto di relazioni.
Prospettiva criminologica: autori di reati aggressivi e violenti che spesso sono perpetrare in
una condizione emotiva di distacco e freddezza.
- Disturbo schizotipico
Stravagante e bizzarro, sospettoso con distorsioni cognitive e percettive e credenze
magiche. Pensiero e linguaggio molto elaborati, metaforici ed eccentrici. Limitati interessi
sentimentali.
Gruppo B:
- Disturbo antisociale
Comportamento caotico e scarsamente in sintonia con le richieste della realtà.
Irresponsabile e senza rispetto per i sentimenti altrui. Incapace di apprendere
dall’esperienza. Inosservanza e violazione dei diritti altrui. Privi del sentimento del rimorso,
adottando un meccanismo di razionalizzazione superficiale.
Prospettiva criminologica: anomalie di carattere e di comportamento che portano a
reiterati atti possibili di arresto, disonesti, esperti nel manipolare, utilizzano la menzogna,
aggressivi e rissosi.
- Disturbo borderline
Instabilità e intensità nelle relazioni interpersonali. Immagine di sé alterata, inadeguato a
livello affettivo, umore variabile e paura dell’abbandono. Impulsivo, con episodi di rabbia
immotivata e intensa, anche autodiretta. Stabiliscono relazioni esclusive con un0unica
persona, con cui non vi siano rischi di abbandono. Stabilita un’intimità vengono attivate
due tipologie di ansia:
Il soggetto teme di essere fagocitato dall’altro e finisce con il perdere la propria
identità
Vive nell’angoscia all’idea di poter essere abbandonato
Prospettiva criminologica: reati contro la persona, connessi agli stupefacenti o alla
circolazione stradale, dissipare denaro, avere rapporti non protetti.
- Disturbo istrionico
Emotività pervasiva ed eccessiva, comportamenti drammatici. Attira su di sé l’attenzione
con atteggiamenti seducenti. Incline a gesti e condotte manipolatorie, facilmente
influenzabile, bugiardo patologico. Maggiore labilità emotiva e teatralità, seduttività più
scoperta.
Prospettiva criminologica: truffatori, abusano di titoli o funzioni e simulano di essere stati
vittima di reato o minacciano il suicidio per attirare attenzione.- Disturbo narcisistico
Le forme patologiche sono più facilmente identificabili per la modalità pervasiva di
grandiosità e necessità di ammirazione e la qualità delle relazioni interpersonali. Tendenza
a rapportarsi in modo manipolatorio e funzionale ai propri interessi. Convinzione di avere
diritto a trattamenti di favore, difficoltà a sviluppare relazioni affettive profonde, mancanza
di empatia, atteggiamenti arroganti.
Prospettiva criminologica: può indurre il soggetto ad abusare di sostanze, a perpetrare
truffe.
Gruppo C:
- Disturbo evitante
Ritiro sociale, modalità pervasiva di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e
ipersensibilità al giudizio altrui. Desidera relazioni strette, ma ne è spaventato. Evita
occasioni sociali perché teme l’umiliazione, connessa al fallimento. Bassi livelli di
autostima.
- Disturbo dipendente
Non sono in grado di prendere decisioni da soli, sottomessi, bisognosi di rassicurazioni.
Prospettiva criminologica: questa categoria prevale tra le vittime, ma può anche costituire
l’elemento succube di una coppia criminale.
- Disturbo ossessivo compulsivo
Ansia e paura. Eccessiva attenzione a dettagli, ordine, organizzazione a tal punto da
perdere di vista lo scopo dell’attività. Perfezionista, scrupoloso, rigido, ostinato, è avaro
con se e con gli altri.
Prospettiva criminologica: si può caricare di rabbia, quando perde il controllo della
situazione o subisce critiche, può reagire con aggressività, ma raramente passa all’atto.
Quando questo avviene, pianifica tutto in modo dettagliato.
Due categorie diagnostiche interessanti a livello criminologico:
- Disturbo sadico
Abile comportamento aggressivo, crudele, umiliante verso gli altri. Trae godimento dalla
sofferenza fisica o psichica inflitta agli altri. Si compiace nel ferire le persone e spaventa le
sue vittime con l’intimidazione. Sono autori di feroci torture, omicidi con lesioni,
maltrattamenti in famiglia.
- Disturbo esplosivo intermittente
Frequente ricorrenza di reazioni imprevedibili e molto violente, per la perdita di controllo
inibitorio, possono sfociare in attentati all’incolumità altrui. È necessaria una significativa
reiterazione di tali manifestazioni di acting out.
In conclusione, molti disturbi di personalità, in particolare quello antisociale, portano a
comportamenti devianti in conflitto con le regole sociali, ma va tenuto presente che non tutte le
persone affette da questi disturbi diventano criminali e solo una parte di delinquenti ha una
personalità disturbata.10) I disturbi parafilici
Alcuni di essi, per venire soddisfatti, comportano azioni che, a causa della loro nocività o
potenziali pericoli per altre persone, vengono definite come reati.
Parafilia: qualsiasi interesse intenso e persistente di natura sessuale diverso da quello per la
stimolazione genitale o per i preliminari sessuali con partner fenotipicamente normali, fisicamente
maturi e consenzienti. Si trasforma in disturbo parafilico quando causa disagio o compromissione
nel soggetto o quando la soddisfazione della parafilia arreca o rischia di arrecare danno al soggetto
stesso o ad altri.
Freud: parla di parestesie, cioè di perversioni dello stimolo sessuale, in cui rappresentazioni
psichiche, normalmente indifferenti o addirittura spiacevoli, si accompagnavano a sensazioni di
piacere. Divise le perversioni in due gruppi:
- Primo gruppo: in cui è perverso lo scopo dell’azione
- Secondo gruppo: in cui è perverso l’oggetto e di conseguenza l’azione stessa.
DSM 5 divide i Disturbi parafilici in alcune categorie.
Tutti i seguenti disturbi implicano:
- eccitazione sessuale ricorrente e intensa, manifestata attraverso fantasie, desideri o
comportamenti,
- per un periodo di almeno 6 mesi,
- nonché causano un disagio significativo sul piano clinico o una compromissione del
funzionamento nel contesto sociale e lavorativo:
Disturbi del corteggiamento:
Voyeuristico
Osservare una persona nuda o che si spoglia, a sua insaputa e non consenziente.
Non c’è contatto fisico, ma è il più diffuso tra i comportamenti sessuali potenzialmente
criminali.
Esibizionistico
Esibizione dei propri genitali a persona che non se lo aspetta, senza cercare contatto
diretto.
Frotteuristico
Toccare una persona non consenziente.
Disturbi algolagnici
Masochismo
Farsi infliggere umiliazioni, percosse o sofferenza in vario modo o con pratiche
autoerotiche (automutilazione). Il masochista può rimanere vittima di morte accidentale.
Sadismo sessuale
Infliggere umiliazioni o sofferenze fisiche o psicologiche ad altri. Soggetto più pericoloso.
Predilezione per l’atipicità dell’oggetto sessuale:
Pedofilico
Interesse sessuale per bambini al di sotto dei 13 anni. Per la diagnosi di questo disturbo il
soggetto deve avere almeno 16 anni ed essere di almeno 5 anni maggiore della vittima.
FeticisticoPuoi anche leggere