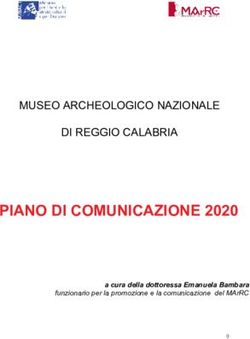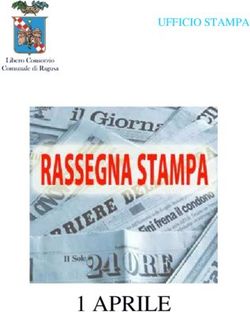COME CAMBIA IL CLIMA: CAUSE ED EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI - MARINA BALDI CNR-IBIMET, ROMA - Velletri 2030
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
COME CAMBIA IL CLIMA:
CAUSE ED EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
MARINA BALDI
CNR-IBIMET, ROMA
ASSOCIAZIONE VELLETRI 2030 - VELLETRI, 6 APRILE 2019EVENTI METEOROLOGICI SALIENTI – ANNO 2018 https://www.arcgis.com/apps/InteractiveFilter/index.html?appid=49fa8561891049ff9ba16a443edb56a5
EVENTI METEOROLOGICI SALIENTI IN ITALIA – ANNO 2018
Nel 2018:
• 32 vittime;
• 148 eventi estremi;
• 66 allagamenti da piogge intense;
• 41 danni da trombe d’aria;
• 23 danni alle infrastrutture;
• 20 esondazioni fluviali.
Tutto questo si colloca in uno scenario per cui la
tendenza è quella di un costante peggioramento delle
condizioni climatiche che rende oggi non più
rinviabile intervenire anche sul fronte
dell’adattamento ad un clima che cambia, con
l’obiettivo di salvare le persone e ridurre l’impatto
economico, ambientale e sociale dei danni provocati.EVENTI METEOROLOGICI SALIENTI IN ITALIA – ANNO 2018
Nel mese di ottobre 2018 l'Italia è stata teatro di una serie di eventi
meteorologici estremi che hanno determinato gravi conseguenze per la
popolazione, l'ambiente e il territorio del nostro paese.
• Il 19 ottobre una serie di eventi temporaleschi molto intensi ha colpito la Sicilia orientale,
causando alluvioni e gravi danni alle abitazioni, alle strutture e al territorio di una vasta area,
soprattutto in provincia di Catania
• A fine ottobre 2018 un'ondata di maltempo più estesa e violenta ha investito tutta l'Italia da nord
a sud.
• Il 29 e 30 ottobre il vento ha soffiato costantemente con forte intensità dai quadranti meridionali.
• Diverse stazioni meteorologiche della rete nazionale hanno registrato velocità del vento
dell'ordine di 100 km/h con raffiche fino a circa 180 km/h in montagna (Monte Cimone) e tra 140 e
150 km/h sul mare (Capo Carbonara e Capo Mele).
• Localmente, le reti regionali hanno rilevato valori di velocità del vento anche superiori, con
raffiche fino a più di 200 km/h.
• Le piogge sono cadute abbondantemente su quasi tutto il territorio nazionale, con tempi e
intensità diverse nelle varie regioni.
• Le precipitazioni cumulate giornaliere più elevate sono state registrate nelle zone prealpine, con
valori di oltre 400 mm in Friuli Venezia Giulia e di oltre 300 mm in Liguria, Veneto e Lombardia".TUTTI QUESTI EVENTI METEOROLOGICI «ESTREMI» SONO
CORRELATI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI?
La meteorologia e la climatologia si occupano dei fenomeni che avvengono in atmosfera
e delle interazioni che quest'ultima ha con il suolo e il mare.
La differenza fra meteo e clima consiste nelle scale di tempo coinvolte:
• la meteorologia lavora su scala temporali relativamente brevi (dall‘ora alla stagione),
per le quali studia, monitora, analizza e prevede i fenomeni che avvengono in un
determinato tempo e luogo
• la climatologia lavora su intervalli temporali lunghi (~30 anni) sui quali valuta per un
determinato territorio la media dell'insieme delle condizioni meteorologiche, studia i
processi dinamici che le modificano e cerca di stimare l'entità di tali modifiche.STORIA DELLA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA La storia delle previsioni meteorologiche ha radici antiche. Gli antichi babilonesi (650 a.C.) tentavano di predire i cambiamenti atmosferici studiando le nubi e le stelle. Importanti sviluppi si ebbero nell'Antica Grecia. «Meteorologia» deriva da μετεωρολογικά, titolo del libro di Aristotele (340 a.C.) che presenta osservazioni miste a speculazioni sull'origine dei fenomeni atmosferici e celesti. Teofrasto (allievo di Aristotele) nel "Libro dei segni" catalogò previsioni di pioggia, temporale e bel tempo, osservazioni più o meno razionali per decidere se mettersi in mare, organizzare il lavoro nei campi, e in che condizioni si può svolgere una battaglia. All'epoca dell'antica Roma, il geografo Pomponio Mela introdusse il sistema delle zone climatiche. Plinio il Vecchio tratta di meteorologia nel Libro II della Naturalis Historia.
STORIA DELLA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA
Passarono tuttavia secoli prima che le previsioni
Mappa dei climi e dei venti meteorologiche potessero basarsi su conoscenze
Strabone (63 a.c. 23 d.c.) tecnico-scientifiche. Oggi la nascita ufficiale della
meteorologia viene collocata alla metà dell'Ottocento.
Due sono le persone riconosciute come padri
fondatori: Francis Beaufort e Robert Fitzroy
Fitzroy, navigatore britannico, è celebre perché fu il
comandante del brigantino Beagle nel viaggio in
Patagonia e nello stretto di Magellano, su cui viaggiò il
naturalista Charles Darwin. Considerato uno dei
pionieri della meteorologia, diede inizio alla
meteorologia sinottica.Il Clima è il risultato di un sistema complesso di
interazioni fra diversi elementi
• ATMOSFERA: lo strato di gas che
circonda la superficie terrestre.
• IDROSFERA: l’insieme di tutta l’acqua
allo stato liquido che si trova sulla terra
(oceani, mari, laghi, fiumi e acqua
sotterranea).
• BIOSFERA: la totalità degli esseri
viventi presenti sulla Terra, compreso
l’uomo e la materia organica non ancora
decomposta.
• CRIOSFERA: tutte le masse di ghiaccio
e gli accumuli di neve della Terra.
• LITOSFERA: tutte le terre emerse, più
il fondo degli oceani e i primi strati
dell’interno del pianeta.L'atmosfera terrestre è un involucro molto
L'ATMOSFERA sottile d'aria che circonda la Terra
Il 99% dell'intera massa si trova nei primi 30
km dalla superficie terrestre
Grazie ad essa è possibile la vita sulla terra in
quanto regola la temperatura alla superficie
del nostro Pianeta
Se l'Atmosfera venisse liquefatta
occuperebbe una larghezza di appena 11
metri
Lo spessore dell'atmosfera, rispetto alla
terra, è paragonabile alla buccia per una
arancia.Cause di variabilità climatica
I fattori naturali che provocano i mutamenti climatici terrestri sono:
• variazioni dell’orbita terrestre
• variazioni dell’attività solare
• attività dei vulcani
• impatti di meteoriti
• variazioni della composizione della atmosfera
Alle variazioni della composizione della atmosfera contribuiscono
le attività antropiche con l'emissione di gas ad effetto serraIl Clima: l'effetto serra
L’effetto serra, fenomeno naturale permette di mantenere la temperatura alla superficie
del Pianeta a livelli accettabili per lo sviluppo della biosfera e la sopravvivenza dell’uomo.
• L'effetto serra è un fenomeno di regolazione
della temperatura presente in ogni pianeta
provvisto di atmosfera.
• Esso consiste nell'accumulo all'interno della
atmosfera di una parte dell'energia termica
proveniente dalla stella attorno al quale
orbita il corpo celeste (il Sole).
• Tale effetto è il risultato della presenza in
atmosfera di alcuni gas, detti appunto "gas
serra", che permettono l'entrata della
radiazione solare proveniente dalla stella,
mentre ostacolano l'uscita della radiazione
infrarossa riemessa dalla superficie del
corpo celesteLA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA ATMOSFERA
COMPONENTI VARIABILI:
COMPONENTI
• Anidride carbonica (CO2)
DELL'ATMOSFERA (SECCA):
370 ppm;
• Metano (CH4) 1,7 ppm
• Azoto 78%
• Biossido di azoto (N2O) 0,3
• Ossigeno 21%
ppm
• Gas in tracce- fra cui Argon 0,
• Vapore acqueo (H2O) 0-4%
93%
citazione di concentrazione: fino
a 12-18 km
Azoto ed ossigeno costituiscono
• Pulviscolo (nei primi km)
da soli oltre il 99% della
atmosfera, ma non hanno alcun
Vapore acqueo e pulviscolo
ruolo nei fenomeni meteorologici
atmosferico hanno grande
importanza a fenomeni meteo
Le attività antropiche alterano le concentrazioni di
gas ad effetto serra a causa di due fattori:
• uso dei combustibili fossili
• attività agricoleTendenze climatiche attuali alle diverse scale:
Globale, EuroMediterranea, ItalianaWMO STATEMENT
STATE OF THE GLOBAL CLIMATE
https://public.wmo.int/en/our‐mandate/climate/wmo‐
YEAR 2018
statement‐state‐of‐global‐climate
Every year, WMO issues a Statement on
the State of the Global Climate based on
data provided by National
Meteorological and Hydrological
Services and other national and
international organizations.
https://youtu.be/6r5wKrC7p50EVENTI METEOROLOGICI SALIENTI – ANNO 2018
• A scala globale Il 2018 è stato il 4° anno più
caldo (in Italia il 1°) a partire dal 1880 (prime
osservazioni sistematiche)
• La T è stata più elevata di ~1°C rispetto al
periodo di riferimento
• Gli anni 2015-2018 sono stati i 4 anni più caldi
mai registrati
• Continua la tendenza al riscaldamento sul
lungo periodo
• Aumenta la concentrazione dei maggiori gas
ad effetto serra
• Aumenta il livello degli oceani
• Diminuisce la estensione dei ghiacci nelle
regioni polari
Italia
https://youtu.be/2S6JTLRmQdUFifth Assessment Report © IPCC 2013, 2014 Una pietra miliare per l'avanzamento delle conoscenza scientifiche sul cambiamento climatico • Osservazione • Comprensione • Evoluzione futura
Cambiamenti climatici in atto
L'evidenza
scientifica del
riscaldamento
climatico è
inequivocabile
(IPCC).
Gli impatti dei cambiamenti climatici sono globali. Senza adeguate misure per
contrastarli, l'adattamento futuro sarà molto più difficile ed economicamente
insostenibile.
Oggi, il cambiamento climatico è una delle sfide maggiori e inferisce un notevole stress
sulla società e l'ambiente: mutevoli condizioni climatiche minacciano la produzione
alimentare, aumento del livello del mare aumenta il rischio di inondazioni.Variazione osservata della precipitazione
A scala globale, tuttavia, si hanno ancora delle incertezze
sul trend delle precipitazioni ed il quadro complessivo è molto disomogeneoLa Regione Mediterranea
• 22 Paesi, oltre 450 milioni di abitanti nel 2010 (7% della popolazione mondiale)
• Nel 2025 la popolazione supererà i 500 milioni con un aumento notevole di densità
nelle aree urbane dei Paesi meridionali
• Invecchiamento della popolazione nei Paesi a Nord, più giovani al Sud
• Secondo la Classificazione climatica di Köppen il clima Mediterraneo (Cs) è quello in
cui il mese più scarso di precipitazioni nel semestre caldo ha un totale di precipitazioni
inferiore a un terzo di quello del mese invernale più piovoso e in ogni caso inferiore a
30 mm.
• Settori chiave vulnerabili ai cambiamenti climatici:
Risorse idriche, Agricoltura, Energia, Aree Urbane, Turismo, SaluteTendenze in temperatura annuale in tutta Europa tra 1960 e 2015 Le celle delineate con la linea scura contengono almeno tre stazioni e quindi sono più rappresentative delle alter celle. Una tendenza significativa (5%) a lungo termine è indicata da un punto nero. Tendenze osservate in giornate calde in tutta Europa tra 1960 e 2015 Le giornate calde sono definite con temperatura massima giornaliera al di sopra del 90° percentile. Le celle delineate con la linea scura contengono almeno tre stazioni e quindi sono più rappresentative delle alter celle. Una tendenza significativa (5%) a lungo termine è indicata da un punto nero.
L'aumento della temperatura media registrato nell‘ultimo secolo in Europa è superiore a quello medio globale (AEA, 2012). Viene stimata una differenza di circa 1,3 °C tra la temperatura media europea sulla terraferma nel 2001-2010 rispetto all'epoca Preindustriale. In Italia la temperatura è aumentata più rapidamente: Periodo Italia - °C IPCC - °C 1956-2005 0.27 ± 0.04 0.13 ± 0.03 1981-2005 0.54 ± 0.12 0.18 ± 0.05
Anomalie delle precipitazioni in Italia nel periodo
1800 – 2011 rispetto al periodo 1971-2000.
Le osservazioni mostrano una alta variabilità annuale,
stagionale e regionaleEventi Estremi in Italia
L'Italia e gli eventi estremi: alcuni dati • L'Italia è al 21 ° posto per danni subiti da eventi climatici estremi che hanno provocato enormi danni (alluvioni nel 1966, 1994, 2000 e 2002,... ma anche siccità) • Negli ultimi 20 anni si sono avute perdita per 31 miliardi di dollari ed oltre ventimila morti (dovuti essenzialmente all'ondata di calore del 2003 con oltre 70mila vittime in EU) • Nella lotta ai cambiamenti climatici, l'Italia vendita al 18 ° posto, riuscendo a ridurre le emissioni grazie al contributo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ma anch per effetto della crisi economica
L'Italia e la politica climatica • Per quanto riguarda la politica climatica siamo al 50 ° posto • La grande sfida che ha di fronte l'Italia, è quella di riuscire a mettere in campo un'ambiziosa politico climatica in grado di rendere strutturali le significativa riduzioni delle emissioni dovute alla recessione economica di questi ultimi anni e superare la doppia crisi economica e climatica investendo nella verde economia (cfr Portogallo
Violenti nubifragi e alluvioni
MAPPA DEGLI EVENTI DI DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA
INONDAZIONE CON VITTIME NEL MORTALITÀ PER INONDAZIONE NEL
PERIODO 1968-2017 PERIODO 1968-2017
( )Precipitazioni in Italia
I risultati non indicano una tendenza
(significativa) ben definita
I trend degli indici di precipitazione
mostrano poca coerenza spaziale ed una
tendenza poco marcata
Differenze nette si notano fra Nord,
Centro e Sud Italia
Serie delle anomalie del massimo annuale di precipitazione su 1 e 5 giorni,
RX1day e RX5day in Italia (base: 1961-1990)LE ALLUVIONI IN ITALIA 2000-2018
Data Comune Area geografica
03‐nov‐18 Alluvione a Casteldaccia Sicilia provincia di Palermo
29‐30 ottobre 2018 Alluvione delle Dolomiti belunesi Provincia di Belluno, Alto Agordino
9‐10 Settembre 2017 Alluvione di Livorno del 2017 Toscana
31 ottobre/1 novembre 2015 Alluvione nella Calabria jonica Calabria jonica
14‐set‐15 Alluvione in val Nure e val Trebbia e in parte nel comune di Piacenza Emilia nord‐ovest, provincia di Piacenza
Alluvione Genova in più zone della città, Savona e Ponente Ligure, sud della
15‐nov‐14 Provincia di Alessandria e porzione nord della città di Milano Genova, Savona ed Imperia in Liguria; Provincia di Alessandria; Milano
10‐nov‐14 Alluvione di Chiavari del 2014 Liguria Tigullio[2].
05‐nov‐14 Alluvione di Carrara del 2014 Alta Toscana
9/10 ottobre 2014 Alluvione di Genova
02‐ago‐14 Alluvione di Refrontolo valle del torrente Lierza, affluente del fiume Soligo, presso il molinetto della Croda
03‐mag‐14 Alluvione di Senigallia e Chiaravalle area nord della Provincia di Ancona
18‐nov‐13 Alluvione in Sardegna Olbia, Nuoro, Uras, Bitti, Onanì, Torpè e alcune zone dell'Ogliastra e del Medio Campidano
12‐nov‐12 Alluvione della Maremma grossetana Provincia di Grosseto
11‐nov‐12 Alluvione di Massa e Carrara dell'11 novembre 2012 Provincia di Massa e Carrara
36 eventi 22‐nov‐11
04‐nov‐11
Alluvione di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Saponara
Alluvione di Genova
Provincia di Messina
Genova e provincia
in 18 anni 25‐ott‐11 Alluvione dello Spezzino e della Lunigiana Val di Vara, Cinque Terre, Lunigiana
11‐giu‐11 Alluvione di Sala Baganza, Collecchio e Fornovo di Taro Sala Baganza, Collecchio, Fornovo di Taro (Provincia di Parma)
La frazione di Casette d'Ete, nel comune di Sant'Elpidio a Mare, è la più
03‐mar‐11 colpita Interessate gran parte delle Marche, il teramano e la Romagna
Vicenza e hinterland, aree collinari e montane della zona nord ovest del vicentino, aree extraurbane a
1º e 2 novembre 2010 Alluvione del Veneto ovest e a sud‐est di Padova, Bassa Padovana sud‐occidentale, alcuni comuni tra Vicenza e Verona
05‐ott‐10 Prato Comune e provincia di Prato
04‐ott‐10 Alluvione a Genova Sestri Ponente, Varazze, Cogoleto Liguria Città metropolitana di Genova e Provincia di Savona
09‐set‐10 Alluvione e colata di detrito ad Atrani Costiera Amalfitana in Provincia di Salerno
Alluvione e colata di detrito a Messina, nelle frazioni di Giampilieri
1º ottobre 2009 Superiore, Altolia e Briga Superiore e nel comune di Scaletta Zanclea Provincia di Messina
Alluvione a Cancia, nel comune di Borca di Cadore, e nei paesi di Valesella,
18‐lug‐09 San Vito di Cadore, e Acquabona Valboite in Provincia di Belluno
22‐ott‐08 Alluvione e colata di detrito nel comune di Capoterra]] Capoterra (CA)
29‐mag‐08 Alluvione e colata di detrito nel comune di Villar Pellice Villar Pellice (TO)
30‐apr‐06 Frana a Ischia Città metropolitana di Napoli
03‐lug‐06 Alluvione di Vibo Valentia Vibo Valentia e provincia
25‐set‐05 Alluvione di Terracina Terracina
23‐set‐03 Alluvione di Carrara del 2003 Provincia di Massa‐Carrara
Palagiano e provincia occidentale di Taranto comprendente i comuni di: Massafra‐Palagianello‐
08‐set‐03 Alluvione di Palagiano Castellaneta‐Mottola
29‐ago‐03 Val Canale e Canal del Ferro Provincia di Udine
6 e 23 novembre 2000 Alluvione nella Riviera di Ponente Province di Imperia e Savona
dal 13 al 16 ottobre 2000 Alluvione del Piemonte del 2000 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
09‐set‐00 Alluvione della Calabria del 2000 SoveratoAlcune alluvioni con vittime (Fonte: MATTM)
Genova – 4 novembre
2011: dalla mezzanotte del
4 novembre alle 13 di
sabato 5 novembre è
caduta 1/3 della pioggia
che in media cade sulla
città in un anno.
Roma – 20 ottobre 2011: Nell'Arco di 3
ore sono caduti in media 120 mm di
pioggia. In particolare 96 mm nel
centro di Roma, 127 mm nella zona
della stazione termini, 121 mm a Porta
Portese, 117 mm a Roma Eur.Alcune alluvioni recenti: Olbia (2013), Livorno (2017), Capoterra (2018)
Livorno - notte tra il 9 e il 10 settembre 2017.
La pioggia si abbatte su Livorno. In due ore si riversano sulla città toscana
oltre 250 millimetri d'acqua: la dose di tre mesi in tempi normali. I fiumi e
i torrenti straripano, travolgono tutto. Si allagano le zone collinari:
Montenero, Ardenza, Collinaia. Alla fine la furia dell'acqua porterà via
con se otto vite. Lasciando uno strascico di polemiche e accuse incrociate
sulla gestione dell'allerta meteo. Oltre a un'inchiesta della procura per
omicidio e disastro colposo.
Cagliari – 10 ottobre 2018
La città è completamente
isolata per la chiusura della
SS “Sulcitana”. A Poggio dei
Pini, frazione di Capoterra, il
pluviometro ha raggiunto i
242mm di pioggia da ieri
sera (a Capoterra in media
cadono 500mm di pioggia
l’anno - nelle ultime 18 ore è
Olbia – 18 novembre caduta la metà della pioggia
che di solito cade in un
2013 anno)LA GRANDINATA DEL 21 OTTOBRE 2018 A ROMA
Le parole del Sindaco:
Nella serata di domenica 21 ottobre 2018, tra le 19.30 Questa notte si è abbattuto su Roma un violento temporale con
e le 21.00, Roma è stata teatro di un evento forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni
meteorologico davvero impressionante che quartieri della Capitale, in particolare nel quadrante est.
sicuramente resterà negli annali della capitale sia per Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del Fuoco,
intensità che per violenza dei fenomeni. Protezione Civile, Polizia Locale, e squadre del Simu e dell'Ama.
Sono caduti diffusamente almeno 5/10 cm di grandine, Abbiamo prontamente riunito il COC, Centro Operativo
con picchi localizzati fino a 40 cm specie in Comunale, per coordinare al meglio le operazioni.
corrispondenza degli avvallamenti. Anche le dimensioni Ringrazio tutte le squadre che questa notte lavoreranno senza
dei chicchi non sono state banali: in alcuni momenti i sosta sul territorio per ripristinare più velocemente possibile la
chicchi hanno raggiunto un diametro di 3-4 cm in grado normalità.
di provocare danni ingenti. Ci scusiamo sin d'ora per i disagi.IL CASO DELLA CALABRIA – AGOSTO 2018: LE GOLE DEL RAGANELLO A costituire un grande pericolo è la combinazione della presenza di forti temporali e il regime torrentizio dei corsi d’acqua montani la cui portata può aumentare di alcuni metri cubi in pochissimo tempo. MALGRADO I PROGRESSI DELLE MODERNE TECNOLOGIE PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE, LE PIOGGE DI BREVE DURATA E ALTA INTENSITÀ, FREQUENTI IN ESTATE E CHE EVOLVONO VELOCEMENTE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, RESTANO ANCORA DIFFICILI DA PREVEDERE CON ACCURATEZZA.
IL COMPOSITO RADAR DEL
DPC E IL NOWCASTING
In meteorologia con il termine nowcasting
(dall'inglese da now, "adesso", e [fore]casting,
"previsione") si intendono le previsioni
meteorologiche a brevissimo termine o
scadenza (entro poche ore) su un particolare
territorio d'interesse.
E’ uno strumento molto utile per previsioni
molto localizzate anche di fenomeni intensi
(nubifragi, grandinate, ecc) con un anticipo da 0
a 6 ore prima dell’evento.Vento forte Il fenomeno vento si manifesta non soltanto in forme molto varie nel tempo, ma anche con caratteristiche assai disomogenee sul territorio, che nel caso italiano presenta un'orografia generalmente complessa. Il quadro generale che emerge anche da una rapida rassegna delle tavole dell'Atlante Eolico indica che le aree ventose in Italia sono maggiormente concentrate: (1) nel Centro-Sud e (2) nelle isole maggiori, (3) off- shore. La frequenza di eventi con vento forte è solitamente bassa (tempo di ritorno molto lungo).
La tempesta «Vaia»
Funzione protettiva della foresta a rischio
La tempesta "Vaia", di fine ottobre, è
stato il più importante "disturbo da
vento" avvenuto recentemente in Italia,
tanto violenta da provocare, secondo le
stime, l'abbattimento di ben 8-10
milioni di metri cubi di legname.
Le Tempest Burglind e Vaia hanno
provocato alle foreste in Svizzera e in
Italia i danni più consistenti mai visti dal
Forti venti e raffiche portano alla rottura del tronco o
1994: si stima che il legname distrutto possono addirittura sradicare completamente gli alberi.
dal maltempo rappresenti 130000 L'abete rosso è particolarmente esposto a questo tipo di
metri cubi, circa il 30% del consumo danni poiché ha radici poco profonde e non può ancorarsi
nel terreno.
annuale.Tornado e Trombe d’Aria I tornado (o trombe d'aria) in Italia non sono fenomeni eccezionali. Nei secoli e decenni passati ci sono stati moltissimi episodi, molti dei quali hanno causato ingenti danni e vittime. Quando si parla di tornado, solitamente, si pensa subito agli Stati Uniti. Se un tornado avviene in Italia, spesso si pensa all’evento eccezionale, probabilmente legato a qualche fenomeno inspiegabile e “nuovo”. In realtà in Italia questi fenomeni ci sono sempre stati, con la differenza che da noi si chiamano solitamente “trombe d’aria”. Il termine tornado è di origine spagnola, usato nelle regioni latino americane devastate molto più frequentemente da questo genere di fenomeni meteo estremi, ed oggi usato come sinonimo di tromba d’aria anche nel nostro paese.
Tornado e Trombe d’Aria Trombe d’aria e marine: in Italia oltre cento episodi all’anno Secondo una ricerca del CNR le trombe marine colpiscono in particolare le coste tirreniche, quelle di terra interessano maggiormente Toscana e Lazio, pianura veneta e Salento. Il picco nel 2014 con 217 eventi. La tromba d’aria marina si verifica di solito nei mari in cui la temperatura è più calda, e il Mediterraneo è di sicuro uno di questi. Essendo fenomeni di breve durata ma piuttosto intensi, rappresentano un rischio per le imbarcazioni, in quanto non sono affatto prevedibili.
Temperatura in Italia
Le analisi climatiche indicano una generale
tendenza al riscaldamento.
Aumento dei giorni estivi (SU25) e notti tropicali
(TR20)
Aumento massimo su 10 anni:
-SU25 circa 10-12 giorni
-TR20 circa 8-9 giorni
Aumento delle onde di calore soprattutto al NordOndate di calore
Impatto delle ondate di calore sulla salute umana Nelle città mediterranee l'aumento stimato della mortalità è di circa il 3% per 1°C di aumento di temperatura apparente massimo L'impatto sulla mortalità è maggiore per le persone anziane In Italia l'HW può causare un aumento del 20-30% della mortalità fra gli adulti di età superiore a 75 anni Gli effetti a breve termine possono essere ridotti con l’adozione di piani di prevenzione Ma sono necessari piani di prevenzione a lungo termine al fine di accrescere l'efficienza energetica delle case
Confronto fra Estate 2003 ed Estate 2012
Temperatura
Estate 2012: Anomalia di Temperatura = +2.3°C
Estate 2003: Anomalia di Temperatura = +3.7°C
Durata media dell’evento
Estate 2003: 34 giorni
Estate 2012: 17 giorni
Mortalità
Estate 2003: +46% (2704)
Estate 2012: +7% (226)
A cosa sono dovute queste differenze?
→ In funzione il sistema operativo di allerta per le ondate di caloreSISTEMA DI ALLERTAMENTO PER LE ONDATE DI CALORE
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jspSiccità
• 1954: da Maggio a Settembre quasi senza eccezioni niente piogge su Calabria, Sicilia e Sardegna
• 1959: due episodi, uno alla fine dell'inverno in Veneto, Salento e versante adriatico dell'Appennino settentrionale. L'altro durante
la stagione estiva con assenza ininterrotta di pioggia per più di 100 giorni in Sardegna, alta Pianura Padana, bacino del fiume
Adige, Piemonte e Liguria.
• 1962: siccità su tutta l'Italia, tra l'estate e l'autunno, per più di 100 giorni. In particolare fascia costiera tirrenica, Sardegna.
Soprattutto in Sicilia addirittura fino a 200 giorni senza piogge.
• 1976: primo semestre dell'anno specie in Piemonte, Lombardia, Alpi centrali. Ad esempio a Milano e Como solo 200 millimetri in
sei mesi, il valore piu basso degli ultimi 200 anni. Il Po il 20 luglio toccò la portata minima di 335 metri cubi al secondo (il minimo
storico era di 275).
• 1980-81: 106 giorni a secco, dal 26 novembre al 13 marzo, in Lombardia, con non più di 20 millimetri di pioggia. Un inverno molto
siccitoso per tutto il Nord-Ovest in generale (ma non per il resto d'Italia).
• 1988-89: una siccità davvero intensa tra settembre e marzo, peraltro durante quello che dovrebbe essere il periodo più piovoso
dell'anno. Durata ed estensione come non avveniva da 250 anni. Praticamente totale assenza di neve con solo 2 o 3 deboli
nevicate. Oltretutto il clima mite e i cieli sereni sciolsero quel poco che c'era, eccetto i ghiacciai perenni a quote oltre i 2500
metri.
• 1989-90: come se non bastasse la siccità si ripeté ancora in questo periodo. Da settembre a gennaio si ebbe appena il 30-50%
delle piogge che si hanno normalmente sull'intera Penisola. Dunque ulteriore aggravio del deficit idrico che si protraeva dall'anno
precedente, con tanto di razionamento dell'acqua potabile in molte città.
• 1994-95: un'alluvione mise in ginocchio il Piemonte all'inizio di novembre, ma poi scarse o assenti precipitazioni sulla Pianura
Padana fino alla fine di febbraio, con l'eccezione poco dopo metà gennaio di una debole perturbazione atlantica che anche grazie
alle basse temperature fece nevicare a Milano e Torino, ma furono pochi centimetri.
• 2000: ancora una volta la siccità colpì soprattutto il Nord e durò per i primi 70 giorni dell'anno. Su tutto l'arco alpino la neve non
fece la sua comparsa con danni anche al turismo.
• 2001: per la Sicilia e per gran parte del Sud Italia l'estate e l'inizio dell'autunno furono particolarmente avari di precipitazioniSICCITÀ • I casi di siccità più estremi che hanno colpito il nostro Paese non sono solo nei mesi estivi. • Le siccità del periodo autunnale e/o invernale sono anche più gravi perché sono periodi in cui terreni e falde acquifere dovrebbero essere "riforniti" proprio per affrontare la normale mancanza di piogge e il caldo estivi. • Specialmente la neve è importante che si accumuli in quantità sulle montagne, allo scopo poi di rilasciare l'acqua più lentamente durante la fase di scioglimento. • Se piove dopo dieci giorni di bel tempo il terreno è comunque in grado di assorbire l’acqua. Ma se la pioggia non si fa vedere per cento giorni il suolo diventa incapace di gestire il flusso idrico L’indice di siccità in Italia al 20 agosto 2017
SICCITÀ 2019
Mappa dell’indice di siccità degli ultimi 3 mesi.
Sono fenomeni sempre più frequenti e intensi che dobbiamo imparare a gestire
Si aggrava la siccità al nord. In questa
prima parte del 2019, sono transitate
numerose perturbazioni, ma complice la
traiettoria prevalente da nordovest la
pianura Padana e il settore tirrenico del
centro Italia spesso hanno avuto scarse
precipitazioni a causa dell’effetto
barriera dell’arco Alpino. Di
conseguenza aumenta la
preoccupazione soprattutto da parte
delle organizzazioni di agricoltori e dei
consorzi di bonifica, in prospettiva
dell’estate, stagione in cui cresce la
necessità di acqua per le attività umane.
(L. Lombroso)
Osservatorio sulla siccità Cnr-IbimetUNO SGUARDO AL FUTURO: VARIAZIONI DELLA TEMPERATURA ANNUALE, ESTIVA E INVERNALE: 2071-2100 Scenari di cambiamento della Temperatura (°C) a scala annuale (a sinistra), in estate (medio) ed in inverno (a destra) in prossimità della superficie nel periodo 2071-2100, rispetto al periodo di riferimento 1971-2000 per gli scenari RCP4.5 (sopra) e RCP8.5 (sotto). Risultati dall'ensemble multi-modello delle simulazioni RCM – Progetto EURO-CORDEX.
UNO SGUARDO AL FUTURO: VARIAZIONI DEL NUMERO DI ONDATE DI CALORE
Le Mappe mostrano la mediana
del numero di ondate di calore
Venire si ricavano dai modelli
climatici per Ho Dovuto intervalli:
• 2020-2052 (colonna di sinistra)
• 2068-2100 (colonna di destra)
e per due scenari diversi
• RCP 4.5 (sopra)
• RCP 8.5 (sotto)UNO SGUARDO AL FUTURO: VARIAZIONI DI PRECIPITAZIONE
Variazioni di
precipitazioni intenso per
il periodo 2071-2100
rispetto al periodo 1971-
2000 in inverno (SX) ed
tenuta (DS)
Variazioni del numero di
giorni secchi per il
periodo 2071-2100
rispetto al periodo 1971-
2000IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA: COSA ACCADRÀ NEL FUTURO? • Più frequenti i periodi di siccità (se ripetuta possibili problemi di desertificazione dei suoli...) • Meno acqua disponibile, minor qualità, problemi di approvvigionamento, comprese il comparto idropotabile • Impatto negativo sulla produzione agricola (meno acqua disponibile) • Nuove patologie ed effetti negativi sulla salute per più frequenti onde di calore • Maggiore richiesta e consumo di energia (es: raffreddamento estivo) • Maggior rischio idrogeologico e idraulico • Maggior frequenza di incendi boschivi
TUTTI QUESTI FENOMENI SONO CORRELATI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI?
Nel 2018, per la seconda volta gli scienziati hanno identificato eventi meteorologici estremi che non sarebbero potuti avvenire senza il riscaldamento climatico indotto dalle attività dall'uomo. Ad esempio, temperature più elevate possono intensificare il ciclo dell'acqua, portando a più siccità e inondazioni, a causa del terreno più secco e all’aumento dell'umidità. Naturalmente, questi approcci possono solo dare indicazioni sulla probabilità che si verifichi un determinato evento.
L'accordo di Parigi chiede di limitare l'aumento della temperatura globale entro
la fine di questo secolo a non più di 1.5°C-2°C.
PERCHÉ 1.5°C DI AUMENTO DELLA TEMPERATURA RAPPRESENTA UN
PROBLEMA
Un recente studio prevede i seguenti impatti a seguito di un aumento di
2°C rispetto ad un aumento di 1.5°C:
• Aumento delle ondate di calore, delle precipitazioni intense, del livello
del mare (e il livello del mare rischia di continuare a salire a lungo dopo
che la temperatura si è stabilizzata).
• Impatto maggiore su alcune colture di base (qualità e quantità della
resa).
• Raddoppia la diminuzione di acqua dolce disponibile nella regione
Mediterranea.
• Le barriere coralline tropicali sarebbero distrutte.La conferenza delle Parti COP24 (Katowice, dicembre 2018) ha stabilito alcune
regole per l’applicazione dell’accordo di Parigi che entrerà in vigore nel 2020
Il documento finale di 100 pagine stabilisce la regole
comuni che i firmatari devono rispettare per fermare il
global warming e rende operativo l’accordo di Parigi
firmato nel 2015.
I paesi che hanno sottoscritto il Rulebook si sono
impegnati a ridurre le emissioni di CO2 per limitare la
crescita della temperatura media globale ad un
massimo di 2°C entro la fine del secolo.
Nonostante la firma di un accordo finale (per questo non si parla di fallimento), mancano
delle indicazioni precise su come i paesi hanno effettivamente intenzione di ridurre le
emissioni di anidride carbonica.
Attualmente, gli scienziati hanno calcolato che la temperatura globale aumenterà di 3°C
rispetto ai livelli pre-industriali, provocando alluvioni, l’aumento del livello dei mari e il
declino della produzione agricola.IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA: COSA POSSIAMO FARE?
• Conoscenza dei fenomeni
• Definizione del rischio
• Valutazione del rischio
• Previsione e prevenzioneACCRESCERE IL BAGAGLIO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE • Occorre una migliore conoscenza dei fenomeni e della vulnerabilità territoriale per combattere meglio eventi come desertificazione e alluvioni. • Occorre formazione continua degli operatori del settore e formazione di giovani ricercatori e tecnici. • Occorre un potenziamento delle capacità di monitoraggio e un miglioramento del coordinamento dei servizi meteorologici e climatici. • Occorre uno sviluppo di politiche di pianificazione che aumentino la resistenza e la resilienza del territorio agli impatti.
IL RISCHIO SI VALUTA SULLA BASE DI TRE ELEMENTI:
• Probabilità che si verifichi l’evento
• Vulnerabilità dei sistemi umani e naturali
• Esposizione dei sistemi umani e naturali
IPCC ‐ WGIIRISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO Nell’ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico rientrano gli effetti sul territorio determinati da “condizioni meteorologiche avverse” e dall’azione delle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche di questa tipologia di fenomeni sono temporali, venti e mareggiate, nebbia, neve e gelate, ondate di calore, frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe. Il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano, aumentando l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso.
PREVISIONE E PREVENZIONE Sul territorio italiano è attivo un sistema di centri per la raccolta, il monitoraggio e la condivisione dei dati meteorologici, idrogeologi e idraulici. La rete di questi centri costituisce il Sistema nazionale di allertamento. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, delle strutture regionali e dei Centri di Competenza. Ogni Regione stabilisce le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti a un’alluvione, una frana etc. Le attività di prevenzione sono quindi volte ad adottare provvedimenti finalizzati all’eliminazione o attenuazione degli effetti al suolo previsti.
http://iononrischio.protezion ecivile.it/la‐comunicazione‐ delle‐allerte‐meteo‐idro‐nel‐ sistema‐allertamento‐ nazionale/
ALLERTA GIALLA, a differenza del codice giallo del pronto soccorso, NON vuole affatto dire che "non è niente di grave" o che "non c'è pericolo di morte", ma al contrario che i fenomeni potenzialmente molto intensi - e i relativi impatti, associati a scenari di rischio di assoluta importanza, che riguardano anche il pericolo per le vite umane - riguarderanno situazioni alla scala locale, cioè tali da coinvolgere la macchina degli interventi e dei soccorsi a livello comunale (e non quelle dell'intero sistema regionale o statale, come accade nelle situazioni segnalate da allerta arancione o rossa). Per cui il GIALLO è un codice colore a cui prestare ASSOLUTA ATTENZIONE perché, laddove i fenomeni assumeranno carattere molto forte o violento, gli effetti sul territorio e sul tessuto urbano, e quindi sui cittadini che si trovino esposti al pericolo, potranno essere molto gravi, locali sì ma comunque molto gravi, compreso il mettere a serio rischio le VITE UMANE. Allerta Gialla è allerta alla scala COMUNALE, ma non vuol dire che NON sia grave, anzi comprende anche scenari con forte pericolo per Vite Umane.
Vi ringrazio per l'attenzione!
Marina Baldi, CNR-IBIMET
m.baldi@ibimet.cnr.itPuoi anche leggere